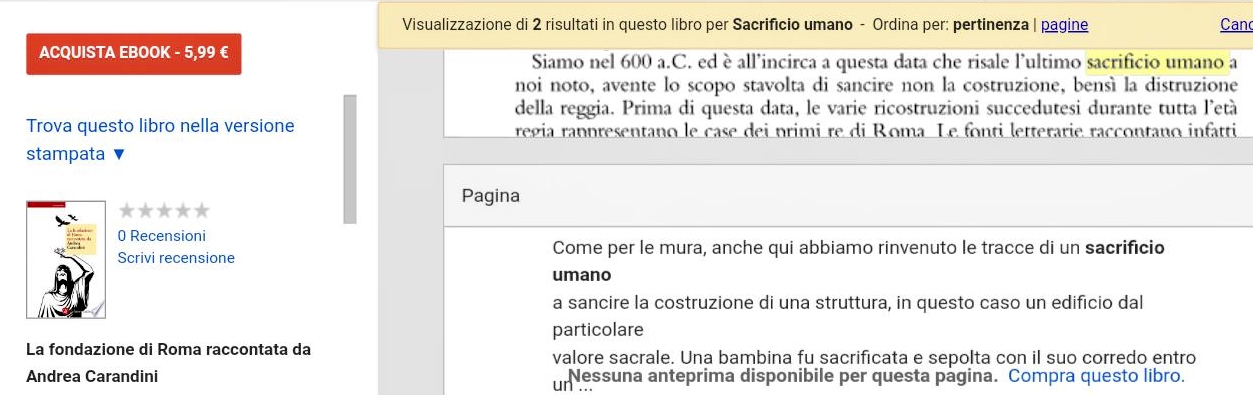Artù l’antico re di un regno italiano la cui leggenda conquistò la Britannia?
Artù l’antico re di un regno italiano la cui leggenda conquistò la Britannia?
Indagine indiziaria di
Oreste Caroppo
La figura del fiabesco Re Artù di Britannia fu ispirata dal reale Re Artù del Salento messapico?
“In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù, fosse lo medesimo de quel Artù Re del Inghilterra?“
Questo che fu il dubbio del Mago Tafuri è anche il mio!
Mentre diversi anni fa raccoglievo dati intorno a questa mia ipotesi teorica mi sono imbattuto in questa frase qui virgolettata scritta dal filosofo-mago rinascimentale salentino M. Tafuri (1492-1584); forse anche lui aveva avuto il mio medesimo dubbio? Un dubbio che può dunque nascere in chi vivendo in Salento e nutrendosi di cultura antica scopre la enigmatica raffigurazione di Re Artù nel mosaico medioevale di Otranto e la figura dell’antico grande e famoso re messapico Artas/Artos.
PRIMA PARTE
Inizio qui la divulgazione di tutta una ricca serie di dati che ho raccolto negli anni sui temi qui dibattuti, seguite e chiedete per gli aggiornamenti successivi.
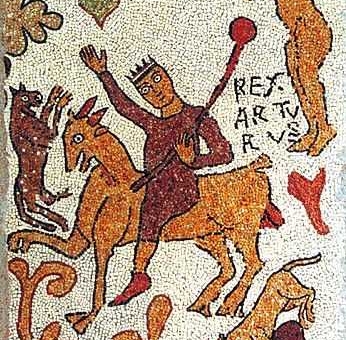
espressa in sintesi la teoria qui esposta:
“Re Artù britannico fiabesco = Re Artas messapico storico“
Elenco aggiornato dei paragrafi
Introduzione
Il percorso di ricerca
Quell’iconografia enigmatica e unica del Re Artù nel mosaico di Otranto che ricorda Dioniso e gli stregoni
Il dubbio degli eruditi salentini del Rinascimento
Approfondiamo la figura storica del Re Artù salentino (Artas chiamato in messapico, Artos in greco)
Il nome Artù
Il testo perduto su Re Artos dei Messapi scritto da Polemone
Ci fu un reale re Artù in Inghilterra?
“Loegria” il regno del fiabesco Re Artù, “Locria” il regno di Re Artas?
I parallelismi con il mito greco-latino sono tantissimi nella letteraria saga medioevale di Re Artù
Excalibur nella antica Calabria (il Sud Puglia) terra del Calabrops e della sacra bipenne la Labrys (prima parte)
L’origine della Fata Morgana e le leggende medioevali che narrano della sua presenza tra Penisola Italiana e Sicilia
La spada nella Roccia e il mito di Teseo l’eroe ateniese ecista fondatore di Brindisi
Avalon l’isola delle Mele in Salento o nella vicina Albania
Le leggende medioevali che narravano della presenza di Re Artù sul monte Etna
Artù? Se tutto porta verso la Messapia, ipotizziamo “Re ARTU’ fiabesco di Britannia = Re ARTOS reale di Messapia”
I sacrifici umani per costruire fortificazioni solide a Oria in Salento come nella leggenda di Mago Merlino
Archita di Taranto il Pitagorico e l’amore ed odio dei Messapi per i Tarantini e i Romani
TARAS e ARTAS nomi ricorrenti nell’epigrafia messapica sono uno la metatesi dell’altro?
Nel Salento popolare l’insegnamento morale del Graal
Alcuni dati sulla città di Otranto e i flussi di pellegrini
La caccia al terribile cinghiale di Artù, relazioni con il megalitismo e gli influssi classici
(…)
APPENDICI con commenti discorsivi dell’autore con sintesi e ulteriori dati dalle corrispondenze sviluppate a seguito della divulgazione di questo studio
(…continuerà…)
Presentazione di questo lavoro su Academia.edu al link.
——————————————
Introduzione
Non solo il leggendario REX ARTURUS compare effigiato in Salento con tanto di esplicita epigrafe nell’enigmatico mosaico pavimentale del XII sec. d.C. della Cattedrale medioevale di Otranto, ma qualche secolo dopo un erudito salentino del ‘500, eclettico personaggio dai poliedrici interessi con fama di mago, Matteo Tafuri, ci parla del Re Artù salentino, Artos/Artas messapico quindi delle fonti antiche greco-romane, e si domanda se non sia proprio lo stesso di cui si favella invece per l’Inghilterra traslato nei cosiddetti secoli buoi del medioevo:
“In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù – e fosse lo medesimo o un altro de quel Artù Re del Inghilterra nol so – lo quale hebe per maestro quel Gano de Magonza nigromante e pythagorico inventore de la tavola rotunda, lo quale insegnò (a) quel re ch’era grande Imperatore li soldati et capitani dovere mangiare in Tavola Rotunda, et li forti et quieti principi in la Tavole quadra, perché redono li pythagorici la figura rotunda esser mobile et la quadra ferma et stabile, havendo Malchia profeta detto che Dio divise lo geno humano tra li forti et li quieti”
(fonte: Quotidiano di Lecce, pag.11, domenica 3 settembre 2000, articolo dal titolo: “La Figura di Mattero Tafuri nel secondo ‘500”, di Vincenzo Ligori).
Lo scrittore e filosofo naturalista tedesco Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) diceva: “Niente è più difficile da vedere con i propri occhi di quello che si ha sotto il naso”. Ed è così che benché pubblicato questo passo su un quotidiano locale, nessuno né ha colto il vero esplicito pensiero chiaro dell’autore, ma il virgolettato è stato letto nel verso della mera allegoria, né poi collegando l’ “Artù di Terra d’Otranto” al famoso Re Artos/Artas dei Messapi, cioè dei Salentini del tempo preromano!
Io invece già da anni raccoglievo dati sulla figura fiabesca del Re Artù delle letterarie saghe medioevali, e rare raffigurazioni artistiche, sempre sfuggito a qualunque tentativo di storicizzazione, e sullo storico reale Re Artos della antica area che poi anche si chiamò Terra d’Otranto, il Salento, la Messapia, la Iapigia, (la Calabria persino prima che tale antico nome fosse traslato nella vicina regione del Bruzio dove rimane oggi), nei suoi molteplici nomi. E queste due figure praticamente omonime per me era come se convergessero nella figura effigiata enigmaticamente e che attonita ti guarda dal basso verso l’alto sul pavimento musivo nella navata centrale della Cattedrale di Otranto.
Il percorso di ricerca
In questo scritto pertanto la raccolta di una ricca mole di indizi, a partire da un sospetto iniziale, quel dubbio fondato sulla omonimia e rafforzato da quella enigmatica figura di un REX ARTURUS sul medioevale mosaico di Otranto proprio in Terra d’Otranto.
(Nota: ovunque qui parleremo di mosaico di Otranto sarà sempre sottointeso, salvo precisazioni, quello firmato da Pantaleone e dal vescovo Gionata come suo committente realizzato tra 1163 e 1165, anche perché da scavi archeologici strati di mosaici più antichi ma semplici decorativi e non figurati son emersi nello stesso luogo di culto).
Indagheremo per quanto possibile elementi correlati ad Artas che possono avere ispirato aspetti che si ritrovano poi nel ciclo arturiano come elementi più caratteristici e che possono avere influenzato l’iconografia idruntina medioevale musiva di Artù che è un unicum assolutamente al momento senza fonti, a differenza degli altri elementi del mosaico della Cattedrale di Otranto quasi sempre comunque riconducibili a fonti letterarie o ad altri modelli per dei confronti, pur se comunque enigmatici, ma non certamente a livello della più enigmatica delle icone di quel mosaico: quella di Re Artù!

Quell’immagine musiva mi mostrava una iconografia in cui vi leggevo ricchi contenuti classicheggianti, con un lessico quasi da corteo dionisiaco (caproni/capre, bastoni-scettri simili al tirso, pantere, fanciulli nudi, ma anche coppe in mano a fanciulli nei pressi dell’altare e vigne in altre zone del mosaico);

queste associazioni vi vedevo lì sulla base della mia cultura.
Mostro qui alcune immagini per fare comprendere i tipi e motivi iconografici dal tema dionisiaco che io notavo fortemente in quella scena in quel mosaico medioevale; mosaico in cui è bene ribadire non mancavamo suggestioni antiche greche e romane, si pensi ad esempio alla figura del titano Atlante, ai giovani che cavalcano grossi pesci o delfini, ecc.


Viene dunque il dubbio semmai nel Salento medioevale fossero noti mosaici dionisiaci immortalanti re Artos in cortei di feste dionisiache, o magari semplicemente mosaici messapici o romani a tema dionisiaco ma che la tradizione popolare attribuì al famoso re Artos, mosaici che poi abbiano contribuito alla genesi di storie locali su Artos mal interepretando i mosaici e il significato dei loro simboli, travisandoli e/o travisando il senso di quelle rappresentazioni.



Ubicazione: Museo Archeologico di Ferrara, Italia. Immagine dal link.


Vedi anche i bei mosaici romani in bianco e nero con leopardo e vigna ad Ostia in questa antologia.
Propongo ancora la visione di questa statua romana di Dioniso su pantera datata dal I al III sec. d.C. che è esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, e questi rilievi scultorei ispirati a Dioniso ed Eracle nella città di Leptis Magna in Libia, nella Basilica dei Severi del III sec. d.C. Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, con figure tra i viticci come poi si troveranno nei portali delle chiese romaniche, ed un motivo che poi ritroviamo a Otranto con l’inserimento delle figure tra i rami dell’albero nel pavimento musivo.
Iconografie simili nel medioevo:

Motivi dionisiaci ad ispirazione dell’arte barocca:

Se anche l’arte barocca traeva spunti dai modelli classici, stesso fenomeno nel medioevo poteva aver influito sulla iconografia di Re Artù per il mosaico di Otranto da un messapico Re Artos coinvolto in ritualità e miti di tipo dionisiaco?
Dalla demonizzazione anche dei pagani culti dionisiaci di menadi-baccanti con le loro danze sfrenate e riti di tipo orgiastico deriverà nel medioevo l’iconografia della strega che cavalca il caprone e dei suoi sabba nel medioevo presieduti da un caprone:
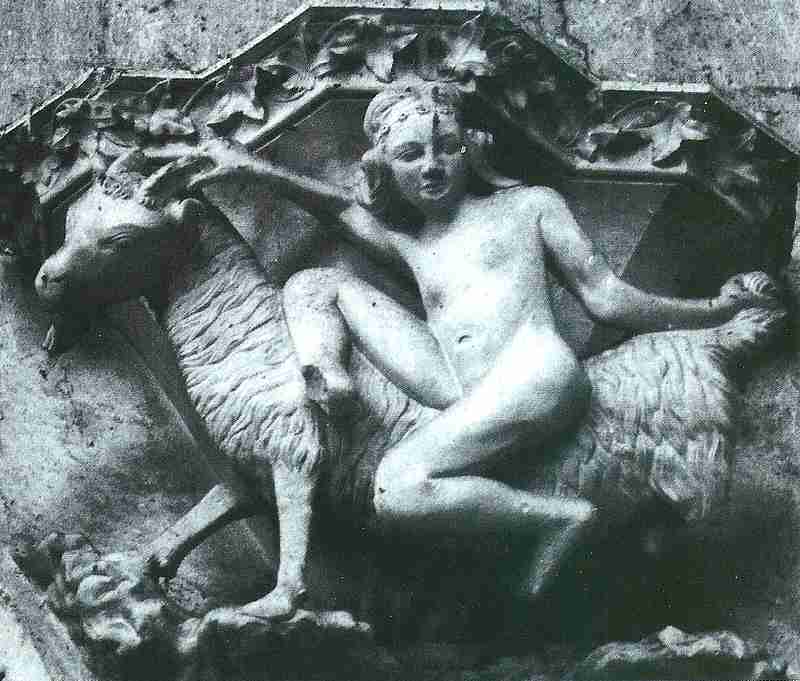
Nonché un più generico ricorso al caprone come simbolo allegorico della lussuria:

Ma l’animale cavalcato da Artù è una capra o un caprone?
Premettiamo che come segni distintivi di dimorfismo sessuale il caprone appare in natura con i testicoli sporgenti nella parte posteriore (come sopra nella allegoria della lussuria), la capra con le mammelle anche magari gonfie di latte nella parte posteriore.

Le mammelle sono tanto più in evidenza quanto maggiore è il loro quantitativo di latte prima della mungitura.
Da questo punto di vista non facile dire se si tratta di un caprone o di una capra per il caprino cavalcato da Artù.
Il caprone (detto becco o irco anche) ha una barba maggiore sotto il mento e corna solitamente più lunghe della capra della medesima sua razza. Nel mosaico di Otranto alcuni caproni son evidenziati dalla lunga barba sotto il mento alcune volte anche rimarcata di colore più scuro.

Nel caso del caprino di Artù essa è assente. Inoltre a giudicare dagli schizzi del mosaico dei primi dell’ottocento, precedenti ai grandi restauri che furono fatti in quel secolo, le corna del caprino di Artù dovevano essere leggermente più lunghe delle attuali.
Non prendiamo pertanto qui una decisione netta sulla questione del preciso sesso del caprino montato da Artù, anche se dovessimo dire a volte solo caprone o solo capra in riferimento ad esso in questi scritti.
Parlando però di eroi/dei associati alla capra, non possiamo non citare qui la famosa mitica capra Amaltea che nutrì Zeus nella sua infanzia sull’isola di Creta. Al suo corno si ricollegava miticamente il simbolo della cornucopia, il grande corno vuoto pieno di prodotti deliziosi della terra da cui emergono frutti e fiori delizie della terra, simbolo di abbondanza (simbolo di facile comprensione, il corno posto tra terra e cielo è simbolicamente un bethilos fallico).

Dal punto di vista tassonomico nella rappresentazione del felide di Otranto come sopra detto si possono pure ravvedere alcuni elementi comuni alla lince (lynx in latino), altri però sono dissonanti.

La singolare enigmatica iconografia di Re Artù in Otranto ha visto dare una prevalenza alla pista allegorica nei tentativi ermeneutici compiuti dagli studiosi, ma questo potrebbe avere oscurato il riconoscimento di un sostrato di ispirazione nei motivi artistici legati ai culti dionisiaci dell’antichità con la loro tipica iconografia, fermo restando che a quel caprino la tradizione cristiana avrebbe comunque potuto dare valori allegorici, (se visto come caprone magari allegoria di lussuria con cui il personaggio cavalcante si identifica, segno di viziosità, o al contrario allegoria di virtù se si intende la cavalcata come capacità di tenere tali passioni a freno).
Immagini o descrizioni di ritualità dionisiache relativamente ad Artas e alla feste e riti in Messapia dove assai si diffuse la religione dionisiaca, trasmesse nel tempo localmente, possono aver influenzato l’iconografia musiva idruntina di Otranto o anche la nascita di leggende da una loro libera interpretazione nei secoli successivi? Nonché la scelta tra tutte le imprese di Artù di cui nel medioevo cantavano bardi e trovatori proprio di quella della lotta contro un grosso felide (“Cath Palug“)?
Per approfondire sul felide di Artù vedi anche questo approfondimento su “Il “Detto del Gatto lupesco”“.
Nel mosaico di Otranto poi compare un’altra immagine sulla quale abbiamo discusso in questo precedente articolo come possa essere correlata o esser stata correlata al ciclo arturiano e al magico Graal, e dove anche per essa abbiamo mostrato interessanti elementi riconducibili ad un’iconografia dionisiaca:

Eppure quel mosaico risaliva indubbiamente al medioevo nella sua fattura, l’epoca in cui nel Regno normanno del sud Italia le saghe del ciclo bretone arturiano circolavano ampiamente con i poeti cantastorie del tempo. Forse quella figura era sfuggita ad ogni tentativo ermeneutico proprio perché nessuno vi aveva ricercato confronti con modelli iconografici greco-romani, (e potremmo dire messapici, anche osservando che la Messapia, il Salento, sorge a metà strada tra Atene e Roma). Un possibile lessico non alieno ad una rappresentazione anche del Re Artos del V sec. a.C. dei salentini.
Era forse allora una ripresa in Salento nel tempo del mosaico di Otranto, l’XII secolo d.C., della figura del Re locale messapico attestato nelle fonti greche e romane, magari documentato in Salento ancora da più antichi mosaici o altro materiale archeologico noto o fiabe, una ripresa suscitata dall’omonimia con il protagonista della saga letteraria di gran fama giunta dall’Inghilterra, quel Re Artù che lì in Inghilterra da eruditi cristiani era stato costruito nei secoli ed anni recenti ad usum nazionalistico sulla base del medesimo famoso storico Re Artos messapico, su cui circolavano in antichità intere monografie, come vedremo, tale era la sua fama, che però ai nostri giorni non sono giunte? (Confidiamo speranzosi però nell’archeologia e nelle scienze bibliografiche).
Fu per queste similitudini che del vario materiale circolante all’epoca, oralmente o meno, del ciclo bretone si optò a Otranto per l’avventura di un Re Artù che affronta un gatto, il Gatto di Palug della saga arturiana, ma il tutto rappresentato secondo un lessico iconografico locale?
Nel mosaico medioevale idruntino non manca l’ispirazione per diverse figure anche a modelli classici greco-latini: ad esempio per la figura dello spinario nel clipeo del mese di marzo, della Dea Tellus nel clipeo del mese di maggio, del titano Atlante, delle amazzoni tiratrici di arco che si tagliavano un seno per tirare meglio secondo la leggenda, del centauro-sagittario, e così vi vediamo rappresentate direttamente dai miti antichi più o meno attraverso la mediazione dei bestiari medioevali sfingi leonine alate (che chiamiamo “sfingi greche”) la coda rigonfia con ciuffo in punta qualifica tali figure come leonine, due figure semi-leonine a testa umana piuttosto grottesche (che chiamiamo “sfingi egizie”, “manticore” nei bestiari medioevali) la coda rigonfia con ciuffo in punta qualifica tali figure come semi-leonine (una di esse sembra esser stata ritratta nel corso di una metamorfosi avendo ancora un piede e mani umane come la testa o semplicemente trattasi di creatura teratomorfa), cerbero, il grifone, serpenti cornuti/draghi, arpie/lamie (grossi uccelli con testa di donna), basilischi, forse anche la centicora essere quadrupete con corna che poteva ruotare completamente rappresentato in un goffo essere che si afferra un lungo corno che ha sulla testa con la zampa come magari per ruotarlo (è nei pressi dell’Arca di Noè) ma a differenza della classica iconografica nei bestiari della centicora non ha però zampe da capra, ecc. Esseri poi chimeriformi innesti di parti differenti di differenti animali; ma anche gli alberi talvolta son nel mosaico sorta di innesti di specie diverse e producono frutti di diverse specie assieme.
Il dubbio degli eruditi salentini del Rinascimento
L’idea era allora che agli eruditi otrantini non sfuggirono queste somiglianze tra i due personaggi, che in Salento si volle allora rappresentare nel mosaico idruntino il re Artù delle saghe medioevali ma secondo schemi e storie autoctone del famoso re Artos di cui ipotizziamo all’epoca in Salento si conosceva più di quanto sappiamo noi oggi, per memoria orale e/o per fonti letterarie, e che poi negli ambienti culturali ruotanti intorno al monastero di San Nicola di Casole si sia trasmesso quel dubbio sulla vera identità ed origine della figura del Re Artù d’Inghilterra, e poiché tramite il mentore Sergio Stiso, come diremo, il mago Tafuri era legata alla cultura della biblioteca di quel monastero, quel dubbio venne da lui messo per iscritto come sopra abbiamo mostrato.

Io ero quasi lì lì per escogitare una corazza romanzesca protettiva per esporre la mia apparentemente ardita tesi, quando come per magia, a Soleto, nel cuore del basso Salento, anni fa, una sera d’estate in cui si dissertava in Largo Osanna del leggendario alchimista cittadino, il mago Tafuri, illuminante fu per me imbattermi davanti al testo di un articolo esposto su un tre piedi in legno; era l’articolo di un giornale locale in cui lessi quel passo per me meraviglioso: “In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù – e fosse lo medesimo o un altro de quel Artù Re del Inghilterra nol so (…)” dove quell’erudito salentino di epoca rinascimentale chiamava un re di Terra d’Otranto proprio “Artù”, mostrandoci come ben l’antico re Artos, re di un regno in Messapia, se non anche re dell’intero Salento, era equiparato da lui lessicalmente, come giusto che sia, al nome Artù!

Tafuri aveva anche viaggiato a lungo tra Italia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Spagna, Grecia, forse anche Asia Minore, ed era stato membro dell’ “Academia Secretorum Naturae” (Accademia dei Segreti), fondata a Napoli nel ‘500, per appartenere alla quale era necessario dimostrare di aver effettuato una nuova scoperta scientifica, sconosciuta al resto dell’umanità, nell’ambito delle Scienze naturali. Tafuri un personaggio dalla poliedrica cultura e dagli universali interessi, alchimia inclusa, come giusto deve essere, figlio della terra salentina ed erudito in greco e latino, attraverso il suo insigne maestro di Zollino (Lecce), Sergio Stiso, anche su testi della importante biblioteca dell’Abbazia di San Nicola Casole a Otranto, presso la quale si ipotizza si formò anche il sacerdote Pantaleone autore su commissione del vescovo Gionata del mosaico otrantino. Il fatto dunque, che in un tale personaggio storico, Artas, un intellettuale cinquecentesco salentino aveva sviluppato ed espresso un dubbio identico a quello scaturito in me evidentemente a partire da medesime osservazioni, ma con lui ben più vicino all’ambiente culturale in cui qualche secolo prima era stato impresso in tessere musive quel REX ARTURUS a Otranto mi corroborava nella necessità di approfondire quella suggestiva omonimia.
Già una frase del tipo: “il Salento è la terra di re Artù”, non conterrebbe alcuna falsità, alcuna imprecisione storica, poiché in tempi antichi, e le fonti antiche non mancano, il Salento messapico vide la presenza e il correlato regno di un re, un dinasta, ricordato come Artos, o anche Artas, la cui traduzione in latino sarebbe proprio Arturus, e quindi un Re Artù!
Da qui partiamo per tentare nuove ipotesi esplorative e conoscitive. Con un percorso euristico.
Il virgolettato riportato è tratto dall’ “introduzione” di un manoscritto del 1571 scoperto nella biblioteca dell’Abbazia di Cava dei Tirreni. Si tratta di un “pronostico”, (per i figli di Giovanni Del Tufo Marchese di Lavello), scritto da Matteo Tafuri, (o Tafuro), noto astrologo, “mago” nel senso rinascimentale del termine. Il “Mago Tafuri” nacque a Soleto nel cuore del basso Salento nel 1492, e scomparve probabilmente tra il 1584-1585, fu medico, filosofo, astronomo, alchimista, astrologo e negromante.
“Il padre del Tafuri era il pritopapas, l’arciprete greco di Soleto”, ringrazio lo studioso locale Francesco Manni per questo dato, il quale anche mi precisa che: “Il cognome originale, con cui si firmava, era tafuro. Molti cognomi poi venivano definiti col genitivo, tipo dei tafuri. Successo per tanti cognomi. Attanasio, attanasi, manno, manni, ecc.”.
Soleto il suo paese natale dove ancor oggi gli anziani in bilinguismo parlano come lingua madre, oltre al dialetto romanzo, il griko (un dialetto grecanico come ancor oggi un dialetto grecanico si parla nel sud del Bruzio), tanto che quell’isola linguistica relitta di borghi di cui Soleto fa parte nel cuore della provincia di Lecce, tra Maglie e Lecce, connotati da tale bilingusmo viene chiamata Grecìa salentina.
E’ il suo un passo che andrebbe molto approfondito, e di cui oggi possiamo iniziare a coglierne tutta l’importanza in seno agli studi arturiani che qui stiamo esponendo e dipanando.
E’ già interessante qui sottolineare come al Re Artù salentino (Artos), Tafuri riconduce l’ insegnamento di un mentore che fu un mago pitagorico, un aspetto che subito ci riporta in ambiente messapico antico dove sappiamo, sempre dalle antiche fonti greche a noi giunte, diversi messapi furono seguaci di Pitagora (tra VI e V sec. a.C.). Il pitagorismo oltre che nella vicina colonia ellenica di Taranto si era diffuso anche nel resto del Salento; in realtà, possiamo dire, diffondendosi in sud Italia e tramandandosi con continuità, per tanti aspetti della sua visione matematica della natura, (e quindi anche della musica), fino ai nostri giorni.
Aristosseno di Taranto (IV – inizi III sec. a. C.), come riportato da Porfirio nella sua opera in greco intitolata “La Vita di Pitagora”), riportava che “tra i seguaci di Pitagora vi furono – (ndr: oltre a greci italioti, gli elleni delle colonie magno greche del sud Italia) – anche Lucani e Messapi e Peucezi e Romani.”.
Così scriveva invece Giamblico (fine III-IV sec. d. C.) nella sua opera in greco “Sulla vita di Pitagora”: “alla setta pitagorica aderirono anche gli stranieri, Messapi e Lucani e Peucezi e Romani”.
Pertanto non è improbabile che un re messapico vissuto durante la vita di Pitagora, o dopo, possa aver avuto dei maestri, dei mentori pitagorici. Non dimentichiamo che la Messapia era vicinissima via terra e via mare a centri come Crotone (nel Bruzio) e Metaponto (in Lucania), come anche a Taranto che era praticamente in terra Messapica, colonie magno-greche intrinsecamente caratterizzate dalla presenza fisica (le prime due), e dalla diffusione dell’influente e prestigioso insegnamento pitagorico. Si aggiunga poi l’attrazione culturale che il mondo ellenico magno-greco esercitava inevitabilmente sui Messapi.
E nel mondo politico/amministrativo del sud Italia grande fu il fascino del pitagorismo. Pensiamo anche solo al grande stratega Archita di Taranto, (Taranto, 428 a.C. – 360 a.C), che fu da gran illuminato saggio alla guida della polis di tarantina, delle cui invenzioni resta forte nella tradizione salentina quello della “trozzula” in legno, la raganella chiamata in italiano per il suono che ricorda quello delle rane, un gioco per bambini, ma anche uno strumento inserito nei riti cristiani della Settimana Santa di Pasqua.
Per il periodo in cui visse Artas (V sec. a.C.), ben esso poteva dunque aver avuto come mentori proprio dei filosofi pitagorici, in accordo con quanto affermato dal Tafuri, per l’ Artù salentino (Artas).
I giovani principi, destinati al trono, già in antichità venivano affidati a saggi filosofi come loro mentori; è il caso ad esempio, nella non lontana Macedonia, del giovane Alessandro, che poi diventerà Alessandro Magno, cui fu affidato come maestro niente meno che il grande filosofo Aristotele!
Il Tafuri non chiama Merlino il mago dell’Artù salentino, ma gli da un nome forse confuso e deformato, forse da approfondire meglio e con attenzione! Un nome che parrebbe tratto fantasiosamente da un noto personaggio delle saghe del ciclo carolingio (“chanson de geste”), Gano da Magonza appunto, che è tra i paladini del Re Carlo Magno, (i suoi più importanti cavalieri); non era però né un negromante né un pitagorico, ed è persino ancora presente come figura, come personaggio anche nell’ “opera dei pupi” del teatro delle marionette siciliane, e dunque forse già ben noto nel sud Italia, già in epoca medioevale, grazie anche alla diffusione del ciclo carolingio, e l’attività dei cantastorie, i bardi che si spostavano di paese in paese. A riprova della diffusione del ciclo carolingio, il corpus delle saghe e leggende medioevali ruotanti intorno alla figura di re Carlo Magno (742-Aquisgrana in Germania, 814), re dei Franchi e dei Longobardi insediati anche nel sud Italia con l’esteso ducato di Benevento che comprendeva alcune aree della Puglia, e imperatore del Sacro Romano Impero, non sono rari nel sud Italia, in Sicilia, come in Puglia, toponimi e locuzioni proverbiali derivate dal ciclo carolingio, ancor oggi oggetto delle celebri rappresentazioni dell’Opera dei Pupi. Vi è ad esempio un grande dolmen, nel Salento, tra Ostuni e Fasano, in contrada Moltalbano, chiamato dalla fantasia popolare “Tavola dei Paladini”. Scene della famosa Rotta di Roncisvalle evento di maggior fama nell’epica cavalleresca della “chanson de geste” comparivano sul mosaico pavimentale medioevale della Cattedrale di Brindisi. Così un rivo nei pressi di Otranto è chiamato Canale Carlo Magno, una leggenda locale lo dice sgorgato da una fonte apertasi nella roccia quando il Re Carlo Magno passando da lì a cavallo nei suoi spostamenti assetato gettò la sua spada irato per l’arsura del luogo ma questa colpì la roccia là dove miracolosamente l’acqua inziò a sgorgare dissetandolo. E anche i resti del Tempio greco di Era a Metaponto hanno visto la tradizione popolare attribuire alle alte colonne la funzione di tavolo dei Paladini, immaginati alti più di 5 metri. Da questo nasce il nome “Mensole Palatine”, poi italianizzato in “Tavole Palatine” e “Colonne Palatine”. Il sito è conosciuto anche con il nome di “Scuola di Pitagora” o “Tomba di Pitagora” in onore al matematico e filosofo greco che qui trascorre gli ultimi anni della sua vita.
Il ciclo arturiano, e il ciclo carolingio costituiscono i due più importanti cicli di saghe cavalleresche diffuse nel mondo europeo medioevale, e quindi anche in Salento nel medioevo. Erano tra loro indipendenti, ma finivano spesso inevitabilmente per influenzarsi vicendevolmente nella continua arricchente evoluzione che di bocca in bocca, di autore in autore, i due cicli subivano.
Ma mentre è solida la base storica del ciclo carolingio, Carlo Magno è anche una ben precisa figura storica ben documentata da fonti e archeologica senza ombra di alcun dubbio, non altrettanto si può dire per Artù, e per ogni altro elemento storico e geografico relativo alla sua vita così come emerge dalle saghe medioevali note!
In ogni caso il mago del Re Artù salentino ha una connotazione già subito riconducibile al mondo messapico, era un Pitagorico, che come tale riteneva simbolicamente “la figura rotunda esser mobile et la quadra ferma et stabile”.
E a questo mago pitagorico mentore dell’Artù salentino, (ispiratore forse del mentore mago Merlino del fiabesco Artù d’Inghilterra, di cui si narra nei romanzi medioevali), Tafuri riconduce, all’interno della dottrina pitagorica, su cui lui stesso era ben edotto, la nascita della Tavola Rotonda, che invece la tradizione letteraria medioevale a noi giunta lega al nebuloso Artù d’Inghilterra!
Merlino (Merlin; Merlinus) mago chiaroveggente, consigliere di re Artù inglese, fa la sua prima comparsa in letteratura con le opere medioevali di Goffredo di Monmouth. E’ in Merlino che nel ciclo arturiano si individua l’artefice della Tavola Rotonda. In particolare la prima menzione della Tavola Rotonda appare nell’opera di Robert Wace, un poeta normanno, che con la sua opera intitolata “Roman de Brut” (completata nel 1155) si basava sulla “Historia Regum Britanniae” di Geoffrey of Monmouth. Bruto di Troia infatti è un mitico personaggio fantasioso cui, come vedremo, Geoffry ricondurrà la fondazione del regno di Inghilterra. Per l’introduzione di questo elemento Wace menziona delle rappresentazioni precedenti che dipingevano il seguito di Artù. La Tavola Rotonda non avendo un posto privilegiato, garantiva l’uguaglianza di tutti coloro che avevano il diritto di sedere ad essa.
Tafuri attribuisce questa invenzione al mentore del re Artù di Terra d’Otranto, un mago pitagorico che Tafuri chiama, come abbiam visto, Gano di Magonza. Il nome ci ricondurrebbe al ciclo carolingio, dove esiste un Gano da Magonza, che non è però un mago.
Forse allora la scelta di quel noto nome, Gano de Magonza, per il mentore di Artù, è guidata dalla volontà di esaltare il ruolo di mago del personaggio? Il termine “mago” echeggia in quello della città qui chiamata in ballo Mago-nza; così quel nome, Gano, potrebbe derivare o ricordare quello delle streghe, uno dei cui nomi nel sud Italia è “janare”, (“jana” in Sardegna vuol dire strega/fata; in Salento a San Foca vi è una località costiera chiamata “La Jannara”). Al maschile lo stregone sarebbe dunque: “jano”.
Nome della strega derivato o da quello della dea italica Diana o da quello del dio italico Giano, (Janus). Sempre che i teonimi italici Diana e Giano non siano etimologicamente collegati.
(Altri nomi della strega nel Salento: macara, masciara, striara – nell’ hinterland di Lecce le fanciulle e le giovani fidanzate son chiamate sovente “strie”! E mi piace ricordare che la ingiuria popolare degli abitanti di Soleto è ancora “macari“, cioè stregoni, proprio pare per la fama di quel loro illustre concittadino, Matteo Tafuri intorno al quale sorsero tante leggende.
Sulla base di quanto riferisce il Tafuri, possiamo allora immaginare che forse la tradizione/suggestione della Tavola Rotonda fu non a caso tanto forte nei secoli per i salentini: a tal proposito ricordiamo qui che è nota l’esistenza nei secoli passati in Piazza Sant’Oronzo a Lecce di una grande misteriosa pietra megalitica chiamata la “Pietra Rotonda”, (in vernacolo locale probabilmente “Petra Tunna“), una grande pietra tonda; forse solo circolare come una grande macina, o forse pulvinata, subsferica come alcuni grossi massi calcarei scolpiti naturalmente da fenomeni carsici superficiali in Salento. Difficile pensare che si potesse trattare soltanto di una sfera lapidea di catapulta o di bombarda poiché diverse di esse erano presenti e utilizzate a fini anche decorativi negli spazi pubblici del Salento, pertanto piuttosto comuni e di dimensioni non tali da poter diventare un punto di riferimento fondamentale come era nel caso della “Petra Tunna”. Anche se non sappiamo quale fosse l’originaria funzione di questa pietra, abbiamo la sensazione che potesse apparire come una grande tavola circolare di pietra ricordante la leggendaria Tavola Rotonda dei cavalieri dei cicli cavallereschi, infatti Scipione Ammirato, il nobile leccese divenuto storico ufficiale dei Medici, scriveva che nel ‘500 presso la “pietra rotonda” convenivano i soldati a ragionare di armi e ad infiammarsi col racconto delle proprie e delle altrui imprese, onde erano comunemente chiamati “i soldati della pietra rotonda”. Una associazione, vien dunque da pensare, con la figura dei cavalieri della tavola rotonda, tanto tipica dei cicli medioevali cavallereschi.
Forse era un arcaico megalite appartenuto alla cultura megalitica della protostoria salentina, forse un’ antichissimo altare circolare monolitico, forse il basamento o un rocco di una colonna, (siamo nei pressi del Teatro Romano di Lupiae, l’antica Lecce), chissà. Era un monumento così importante, presso il quale pare si davano appuntamento anche gli innamorati, che da essa aveva preso il nome l’ isolato di casupole, lì nei pressi presente, “l’isola della pietra rotonda” appunto chiamato.
Questo famoso megalite da secoli ormai è scomparso e di esso si sono stranamente perse le tracce nonostante costituisse un importante punto di riferimento al centro della antica città. Era ubicato nel punto in cui da Piazza Sant’Oronzo si diparte Via dei Templari, (anche chiamata “via degli scarpari” i calzolai), detta così dall’esistenza di una cappella proprietà dei monaci cavalieri dell’Ordine dei Templari. Fondamentale sarebbe ritrovarla quella pietra ciclopica o ripristinarne in loco una simile altrettanto monumentale. (Vedi: di Mario Cazzato, “Guida della Lecce fantastica”, Congedo Editore, Galatina, 1991).
Anche alla luce del passo del Tafuri, oggi quel megalite assume un particolare e nuovo interesse suggestivo.
Approfondiamo la figura storica del Re Artù salentino (Artas chiamato in messapico, Artos in greco)

Un re, un basileo messapico di cui trattano diverse fonti antiche greche a noi giunte, da cui apprendiamo che Artos aveva stipulato rapporti di amicizia e collaborazione militare con Atene: intrattenne con gli ateniesi stretti rapporti diplomatici e fornì loro truppe militari messapiche al tempo della Guerra del Peloponneso, ciò nel 413 a.C. per la precisione secondo gl storici, quando egli sedeva su un trono di Messapia; era appellato con il titolo di “Megas”, Grande, Artos il Grande, e in suo onore in Messapia si tenevano persino delle feste chiamate in riferimento a lui: Megalartie. Certamente oltre che saggio e stimato fu anche un gran condottiero. Descritto come “davvero gentile (…) grande e illustre [in greco mègas kai lampròs]”. (Per le fonti letterarie antiche sul Salento rimandiamo sempre al meraviglioso testo intitolato “I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine”, a cura di Mario Lombardo, Galatina, Congedo Editore, 1992).
Interessante questo passo sul Grande re messapico, di Ateneo di Naucrati (il nome della città egizia in cui visse), autore greco, vissuto tra il II e il III secolo d.C., nell’ opera “I Sofisti a Banchetto”:
“Mentre Ulpiano stava ancora scherzando, in tal guisa Cinulco esclamò: «C’è bisogno di pane [artos in greco], e non mi riferisco al re [in greco leggiamo: basileus] dei Messapi in Iapigia, sul quale vi è anche uno scritto di Polemone. Ne fa menzione anche Tucidide nel libro VII [delle “Storie”], nonché Demetrio, il poeta comico, [Demetrio Comico (fine V – inizi IV sec. a.C.)], nella commedia intitolata Sicilia, con queste parole: “Da lì per l’Italia col vento di Noto traversammo il mare verso i Messapi; Artos avendoci accolti ci ospitò nobilmente. B. Un ospite davvero gentile (…) lì era grande e illustre [in greco mègas kai lampròs]”. Non di questo Artos c’è ora bisogno, ma dei pani inventati da Demetra … »” (in parentesi quadre le note del redattore).
Nella stessa opera di Ateneo, da un passo riportato da Dinoloco (V sec. a. C.) leggiamo: “Panòs indica il pane [artos in greco] per i Messapi (…) anche i romani chiamano pan [panis] il pane [artos]”
Sempre presso la medesima opera, come anche nel Lessico della Suida (o Suda è un lessico ed un’ enciclopedia storica del X secolo scritta in greco bizantino riguardante l’antico mondo mediterraneo), e nel Lessico di Fozio I di Costantinopoli, (detto il Grande; Costantinopoli, 820 circa – Armenia, 6 febbraio 893; è stato un bibliografo e patriarca bizantino), tutte opere in greco, sotto la voce Artos, leggiamo:
“Artos: il pezzo di pane; è anche il nome di un tiranno [tirannon in greco] dei Messapi, che peraltro – dice Polemone – gli ateniesi fecero loro prosseno”; prosseno (proxenos); la prossenia era una convenzione concordata per mezzo della quale un personaggio eminente, ospitava gli ambasciatori stranieri a proprie spese, ed era incaricato dell’accoglienza e della protezione dei cittadini stranieri, specie ospiti in veste pubblica. In cambio ne riceveva prestigio, riconoscenza dallo stato conferente e di titoli onorari.

Esichio ancora nel V o VI sec. d. C., nel suo “Lessico”, opera in greco, sotto la voce “Artas”, scrive che era il re dei messapi grande (“megas” in greco) e splendido come si apprende da Tucidide. (splendido come anche lo dice Demetrio). E sotto la voce analoga Artos, lo qualifica quale l’ospite degli Ateniesi, sempre per il passo di Tucidide.
Eustachio di Tessalonica (XII sec. d. C.), (nota: quindi siamo nello stesso secolo in cui fu realizzato il mosaico di Otranto e grande impulso letterario ebbe la saga del ciclo arturiano), nel suo “Commento ad Omero, Iliade”, opera in greco, scrive che: “in Iapigia, nella regione dei Messapi, presso i quali inoltre vi fu un re chiamato Artos. E la festa di un certo Artos soprannominato “il Grande” [megalon in greco], prendeva da lui il nome Megalartia”.
Il nome “megalartia” dovrebbe dunque essere messapico, per cui vediamo come termini greci, come “megalon”, “grande”, erano probabilmente diffusi anche tra i Messapi, presenti nella loro lingua, ancora per molti aspetti nel complesso misteriosa.
Ma riportiamo il passo di Eustachio più esteso:
«Sembra che a Scolo in Beozia [una regione dell’ Ellade] si prendano particolare cura del pane. Perciò dicono che lì è stata eretta una statua di culto di Demetra [dea madre greca e anche messapica, corrispondente alla dea Cerere dei romani, protettrice dei cereali, il cui nome è ad essa legato] Megalartos [dai grandi pani] e Megalomazos [dalle grandi focacce]. Ugualmente anche in Iapigia, nella regione dei Messapi, presso i quali inoltre vi fu un re chiamato Artos. E la festa di un certo Artos soprannominato “il Grande” [megalon in greco], prendeva da lui il nome Megalartia».
Traiamo dalle fonti antiche anche questo passo trasmessoci da Ateneo: “E nel libro primo della sua Replica a Timeo egli [Polemone] afferma che nella città della Beozia, Scolus, vi sono immagini venerate di Megalartus e Megalomazus“. Tali due nomi vengon tradotti da taluni come “gran pagnotta” e “grosso dolce d’orzo”.
Non sappiamo se si trattasse di rappresentazione di Demetra, la dea madre, fatte di pane. In ogni caso alla mente ci giungono subito le suggestioni dei pani a forma di donna, con un uovo bollito inserito nel grembo, o a forma di gallo/gallina sempre con uovo bollito intero incastonato, simbolo di fertilità, che si preparano e consumano in tutto il Salento come rito pasquale. Son chiamati questi pani simbolici “cuddhure” in dialetto salentino.
Nell’ immaginario popolare greco, il legame Artas, Artos, nome del re, con quello del pane, contribuì di sicuro anche ad accrescere il carattere sacro che ipotizziamo ammantò la figura di Artas.
Interpolando le due ultime fonti fornite, quella di Eustachio che scrive nel XII sec. d.C., e quella di Ateneo che visse tra II e III secolo d.C., possiamo ipotizzare con buona probabilità che il passo riportato di Eustachio sulla festa messapica delle Megalartie per Re Artos il Grande, fosse contenuto anche esso, come la prima parte del passo di Eustachio, nel testo di Polemone, intitolato “Replica a Timeo”. Del resto questo è più che probabile dato che sempre Ateneo ci aveva informato che Polemone scrisse proprio una monografia sul Grande Artas, un re su cui si diceva ogni bene, e nulla di negativo, come vediamo dalle fonti greche riportate.
Dall’ insieme di queste fonti, trasmesse dagli autori greci nel corso dei secoli, a partire dai tempi stessi in cui visse Artas, fin in epoca medioevale-bizantina, emerge la figura di un re di altissimo spessore e grande fama, tanto in patria, quanto all’ estero, in tutto il mondo ellenico. Amico e alleato degli Ateniesi. Potente e molto stimato, e dai nobili ospitali costumi. Un sovrano così famoso da essere definito il Grande, (Megas), tanto all’estero quanto in patria, dove persino gli si tributavano delle feste specifiche, da lui e dal suo epiteto di Grande, chiamate Megalartie. Non ci fu nella storia dei Messapi alcun dinasta storico più famoso e più grande di lui, sulla base almeno delle fonti letterarie giunteci. Più mitici invece figure sempre importanti come quella del mitico fondatore eponimo Messapo di cui le fonti antiche sempre narravano.
Tutta la cultura messapica è intrisa da quel nome, che era di certo un nome proprio di persona, forse appartenuto anche non ad uno solo, ma a più re, ARTAS in messapico, e che ritroviamo un po’ ovunque nell’epigrafia messapica disvelata dagli studi archeologici, in tante città messapiche, nell’epigrafia funeraria, e dedicatoria alle divinità, persino tra le incisioni sulla Grotta della Poesia a Roca Vecchia (Melendugno).

Le epigrafi messapiche potevano essere a volte incise, o dipinte, o impresse su creta. Vedi per l’epigrafia messapica di Ciro Santoro, “Nuovi studi messapici”, I-III, Congedo Editore, Galatina, 1982-1984, e di Francesco Ribezzo, “La lingua degli antichi Messapii”, A. Tessitore e C., Napoli 1907, rist. anastatica a cura di Maria Teresa Laporta con prefazione di Ciro Santoro, Congedo, Galatina, 1994.
La stessa fama del re Artas il Grande, favorì probabilmente la diffusione maggiore tra la gente di quel nome; forse diede luogo anche allo sviluppo di una sorta di cognome.

Fondamentale è dunque in Europa, anche proprio il contributo della cultura messapica più precisamente messapico-greca, per la irradiativa diffusione attraverso Roma, del norme Arturus, Artorius, e quindi Artù. Roma conquistatrice di Messapia e del connesso mondo magno-greco ellenico del sud Italia, ne fu a sua volta da questo mondo conquistata, e ormai sempre più si va riconoscendo e scoprendo anche il grande contributo della cultura messapica su quella romana. Tanto i romani ebbero in considerazione i Messapi che un loro imperatore, l’ Imperatore romano Marco Aurelio (Roma, 121 a.C., Sirmio, 180 a.C.), grande filosofo e scrittore anche, vantava di discendere per parte di madre dal re messapico Malennnio (figlio di Dasummo), mitico fondatore della città di Lupiae (Lecce).
A Otranto un monumento di cui restano dei cippi marmorei con epigrafi era dedicato all’imperatore Marco Aurelio. Per approfondimento vedi questo mio post facebook e i miei commenti ad esso.
Di fronte alla vista di quelle epigrafi romane a Otranto, oggi visibili poiché i loro cippi furono impiegati come piedritti su cui posare l’arco di ingresso di un palazzo nel centro storico, non lontano dalla Cattedrale, al pensiero della conquista romana di quella città intorno al 266 a.C., e alla sua precedente storia messapica, nonché al pensiero che la Cattedrale romanica del mosaico con Artù è sorta sulla acropoli di quella città messapica così importante per controllare il Canale d’Otranto, viene da fantasticare che re Artas frequentò certamente quei luoghi in vita, e i palazzi messapici del potere cittadino che dovevano essere proprio su quella acropoli. Tanto più se Artas coordinava operazioni di polizia nel Canale d’Otranto contro la pirateria. La cattedrale fu edificata, come ha rivelato l’archeologia, sui resti di un villaggio messapico, di una domus romana e di un tempio paleocristiano; fu fondata nel 1068. Lo scavo archeologico ha rivelato sotto il pavimento musivo del XII secolo i resti di una basilica paleocristiana con dei mosaici pavimentali più semplici. Sono state ritrovate anche sepolture messapiche, resti di recinti funerari di epoca ellenistica e di epoca romana; praticamente quell’altura ha attestazioni ad oggi documentate archeologicamente a partire dal V-IV secolo avanti Cristo (da “Otranto forma urbis dal primo giorno” di Pierpaolo Cariddi, Edizioni Esperidi).
Re Artas viene descritto, presentandolo come dinasta dei Messapi, della Messapia, nelle fonti, non specificando una particolare città, e ciò può permetterci di immaginare una unità politica dei messapi, e delle loro principali città. Forse tra i meriti di Artas, vi era anche quello di esser riuscito a consolidare e istituzionalizzare meglio questa unità tra le città di Messapia? La sua statura politica e strategica militare evidentemente gli permetteva di esercitare una influenza interna in tal senso, e la stima e ammirazione che riceveva dalla potente Atene, come vedremo, contribuiva anche di riflesso ad esaltarne ancor di più la grandezza interna agli occhi dei suoi sudditi.
Lo studio dei frammenti oggi rimasti e dell’epigrafia, fa credere che il “dinastes” Artos di Messapia fu impegnato in operazioni volte a sconfiggere, nei mari che bagnano la Puglia, la pirateria, che infestava quelle acque di grande importanza commerciale, soprattutto lo stretto strategico del Canale d’Otranto tra la Penisola italiana e quella Balcano-greca; da qui probabilmente anche l’importanza attribuita dagli ateniesi al Re Artas, con cui svilupparono forti e solidali rapporti, perché mantenesse quelle acque controllate e sgombre dai pirati.
Fonti antiche coeve ad Artas, lo storico greco Tucidide (ante 455 a.C. – ca. 400 a.C.) per la precisione, nella sua opera intitolata “Storie”, ci parlano di un antico trattato di amicizia (“palaia philìa”) tra Messapi e Ateniesi, in coerenza anche al quale, nel 413 a. C., i generali ateniesi Demostene ed Eurimedonte, in occasione della spedizione in Sicilia contro Siracusa, attraversato lo Ionio, approdarono sulle coste salentine e vi imbarcarono 150 lanciatori di giavellotto messapi forniti da Artas, (o anche nella variante Artos in altri autori, sempre il medesimo), principe messapico (chiamato “dinastes”, sovrano). In quell’occasione i generali ateniesi furono onorati ospiti di Artas. Le operazioni erano quelle in seno alla cosiddetta Guerra del Peloponneso che vedeva in conflitto sanguinoso tra loro le due più potenti città stato greche, Atene e Sparta, (quest’ultima patria della colonia magno-greca di Taranto atavica nemica dei Messapi cui aveva strappato parte delle terre).

“ [413 a. C.] Demostene ed Eurimedonte, essendo ormai pronto l’ esercito in raduno per la spedizione a Corcira (l’ isola di Corfù) e nel continente, traversarono con l’intero esercito lo Ionio fino al Capo Iapigio (il Capo di Leuca, punta sud estrema della Puglia). Quindi, salpati nuovamente, operarono uno sbarco alle isole Cheradi, un distretto della Iapigia, dove reclutarono per l’imbarco sulla propria flotta circa centocinquanta lanciatori di giavellotto Iapigi di stirpe messapica; e dopo aver rinnovato antichi legami d’amicizia con Artas, che in qualità di sovrano, aveva fornito alcuni giavellottisti, giunsero a Metaponto, sulla costa italica”. (Passo tratto dalle “Storie” di Tucidide).
La questione della corretta ubicazione del luogo di approdarono, definito da Tucidide alle isole che chiama Cheradi, è tutt’oggi controversa. C’è chi le individua nelle isole poste di fronte a Taranto, cosa alquanto improbabile dal punto di vista dei rapporti geopolitici dell’epoca anche se poi si tento di identificarle con queste Cheradi della fonti antiche, chi le identifica in altre isole sempre ubicate lungo le coste occidentali della Penisola salentina, ora a Porto Cesareo, ora a Gallipoli, ora a Ugento.
Le consistenti fortificazioni delle città messapiche in Età del Ferro, come anche quelle possenti della città di Roca Vecchia nell’ Età del Bronzo, testimoniano la necessità di difendere beni e persone, e testimoniano le continue guerre, gli assedi, e le scorribande da cui gli abitanti del Salento dovevano difendersi, sia per inimicizie possibili interne, sia per fronteggiare attacchi esterni, tanto via terra, quanto via mare.
E dal mare veniva e nel mare soprattutto vi era all’ epoca il flagello delle pirateria, dramma secolare nell’Adriatico, e soprattutto proprio nello strategico Canale d’Otranto.
Dalla storia di Roma, comprendiamo che la pirateria nell’Adriatico e nel Canale d’Otranto fu in epoca antica soprattutto di matrice illirica. Era l’Illiria la regione che dall’attuale Albania, inclusa, si estendeva in territori balcanici della ex Jugoslavia, comprendendo il Montenegro, la Croazia, la Dalmazia ecc.; una vasta regione che a Sud, nella regione dell’ Epiro, entrava in contatto con il mondo ellenico. L’abitavano, all’epoca, genti di lingua indoeuropea.
Dal 230 a.C. al 229 a.C., Roma ingaggio una vera e propria guerra, nota come la “prima guerra Illirica”, contro il regno d’Illiria per combattere la pirateria che flagellava i traffici commerciali greci e romani e delle genti italiche. Pirateria che la regina di Illiria, Teuta, favoriva.
Il basso Adriatico vide nei secoli ripetutamente il flagello della pirateria. Riportiamo in merito questo passo dello studioso naturalista romano Plinio il Vecchio che ci ricorda l’ idea di Marco Varrone di realizzare nel Canale d’Otranto un ponte tra Salento e l’ Illiria-Epiro (l’ odierna Albania), quando comandava la flotta di Pompeo contro i pirati nel 67 a.C., le sue competenze di comando nella guerra contro i pirati riguardavano il basso Adriatico.
“Otranto (…) al confine tra il mare Ionio e l’Adriatico, per dove è più breve il tragitto per la Grecia, intercorrendo un’ampiezza del canale di mare non più ampia di 50 miglia fino alla città di Apollonia che sta di fronte. Per la prima volta Pirro re dell’Epiro progettò di ovviare a questa interruzione con un transito a piedi grazie a ponti gettati; dopo di lui Marco Varrone quando era a capo della flotta di Pompeo nella guerra contro i pirati, ma altre preoccupazioni legarono le mani all’uno ed all’altro.” (Plinio, I secolo d. C., Naturalis historia, III).
Apollonia, famosa città portuale e colonia greca in Albania, punto di partenza della Via Egnatia che conduceva fino a Thessaloniki e Byzantium in Tracia; una via romana di comunicazione costruita nel 146 a.C. su ordine di Gaio Ignazio, Proconsole di Macedonia, da cui prese il nome; con tale opera gli antichi romani realizzarono, a partire dalla seconda metà del II secolo a.C., una millenaria direttrice di comunicazione est-ovest tra il basso Adriatico e l’ Egeo settentrionale.
Questo però ci fa capire quanto Atene, e più in generale gli elleni, greci e magno-greci, già nei secoli passati, potevano essere riconoscenti nei confronti di chi avesse liberato il Canale d’Otranto, dalla pirateria. Come appunto pare fece il Grande Artas, anche per questo riconosciuto probabilmente come grande, grande comandante militare, oltre che sovrano! E nelle fonti antiche Artas è chiamato tanto basileo quanto tiranno, il che ci fa pensare congiungesse in sé la natura di monarca legittimo, dinasta ereditario, quanto quella di uomo d’armi, e condottiero.
Artas probabilmente tutelava gli scambi commerciali nel Canale d’Otranto, interessati anche dal traffico di navi ateniesi e di polis alleate da Atene, proteggendone la navigazione, contro l’insidia delle scorrerie di pirati. Per questo Atene gli era riconoscente e alleata. La Messapia aveva poi una posizione strategica importantissima sul Canale d’Otranto, a tal fine, e inoltre una intensità importante di rapporti, e in parte anche di origini con il mondo Illirico stesso, che era baricentro della pirateria nel Canale d’Otranto e nell’ Adriatico tutto.
Artas tutelava gli scambi mercantili con un’azione di polizia del mare che proprio in Adriatico è attestata, letterariamente, lungo la rotta del Canale d’Otranto per i convogli mercantili diretti in Magna Grecia, nell’età della Guerra del Peloponneso, che vede appunto coinvolto lo stesso Artas, come si legge dal passo citato di Tucidide.
Come già espresso, sopra, è il poeta comico Demetrio che ci informa di questi aspetti, tramandandoci di un dinasta locale, di nome Artas, che appunto vigilava perché tali convogli approdassero senza danni nella sua terra dopo aver attraversato in tutta sicurezza, (condizioni del mare ed atmosferiche permettendo!), il Canale d’Otranto: “di qui diretti in Italia, spinti dal vento di noto / attraversammo il mare puntando sulla Messapia; / Artas, accogliendoci, ci ha ospitato liberamente”.
(Per approfondimento consigliamo il testo “Hesperìa, 13, Hellenikòs Kolpos , supplemento a Grecità adriatica” a cura di Lorenzo Braccesi, Benedetta Rossignoli, Edizioni «L’Erma» di Breteschneider, 2001).
Tucidide ricordava l’antico trattato di “philìa”, di amicizia, degli ateniesi con Artas, che fu rinnovato dagli strateghi ateniesi Demostene ed Eurimedonte nel 413 a. C.
Di tale antico patto pare sia rimasta traccia su un frammento epigrafico attico mutilo, (IG I, 53), della seconda metà del V sec. a. C., del quale si son interessati ampiamente gli studiosi L. Braccesi, C. Pagliara, M. Lombardo ed altri. Il testo contiene proprio un trattato di philìa tra Ateniesi ed un contraente il cui nome era proprio di cinque lettere, quante sono quelle del nome Artas, illeggibili a causa di una lacuna nella conservazione dell’ epigrafe. Vi si legge “ricetto ai pirati”, e “la pirateria contro gli Ateniesi e gli alleati”. Per cui ne è stata data la lettura di un impegno del contrante a non dare ospitalità a pirati nelle proprie terre, né a praticarvi egli stesso la pirateria contro gli Ateniesi e gli alleati, e possiamo aggiungere ed immaginare, a vigilare e compiere nell’area marina di influenza e controllo azioni di polizia e pulizia contro la pirateria, probabilmente in collaborazione con forze ateniesi e degli altri alleati della potente Atene. Per Artas, e per i Messapi in generale, era fondamentale per accrescere il loro potere e la loro sicurezza controllare lo stretto tra Mare Adriatico e Mare Ionio, lo strategico Canale d’Otranto, che nel suo tratto più stretto vedeva da un lato Otranto, antica Hydruntum alla foce del fiume Idro, nel Salento, e dall’altro l’ Isola di Saseno e la baia di Valona (Aulona). I Messapi avevano tutto l’interesse ad un controllo dell’ isola di Saseno, o all’ instaurazione di accordi con le genti locali di quelle prossime terre albanesi dedite alla pirateria; interesse a spazzar via la pirateria, o a controllarla, e non si può neppure escludere, data l’invidiabile posizione del Salento, che anche nel Salento, talune genti, insediate lungo la costa, potessero essersi dedicate all’attività di pirateria.
Ora emerge la possibile figura storica di re Artas che con il suo esercito e la sua flotta militare pattugliava il Canale d’Otranto, dalla sua terra privilegiata in tal senso per una tale azione di controllo, la Terra d’Otranto appunto, antica Messapia.
Un Artas che si era guadagnato rispetto, e grande nomea forse proprio per aver sconfitto i pirati che soprattutto operavano nello stretto tra Penisola italiana e i Balcani.
Per Atene erano importanti questi accordi diplomatici con l’occidente, e nell’ ottica di una penetrazione commerciale verso l’Occidente fondamentale era un’operazione di repressione della pirateria lungo quella che è la via obbligata di ogni comunicazione con la Magna Grecia, cioè lungo il Canale d’Otranto.
In antichità nel Canale d’Otranto pare che nell’ isola di Saseno (Sason presso gli antichi greci e romani, è così citata dal poeta latino Lucano del I sec. d.C., ad esempio), isola illirica nell’odierna Albania, davanti la baia di Valona (Vlorë in albanese oggi – “Aulona” chiamata in passato), e quindi immediatamente al di là del Canale d’Otranto per i Messapi, vi fossero basi di pirati. Un vero e proprio covo di pirati è attestato su quell’isola “Sasonis piratica statione nota”.
Da “La pirateria nell’Adriatico antico. Hesperia, 19”, (Edizioni «L’Erma» di Breteschneider, 2004), riportiamo questo illuminante questo passo:
“Sulla baia di Valona: H. Myrto”, in “Albania archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi”, I (A-D), Bari 1998, 42-45
«Un covo di pirati è attestato nell’isola di Sason (Sasan-Saseno), all’imbocco di Aulona (Vlorë – Valona) [nota del testo: “(…) Sasonis piratica statione nota”. “Sulla baia di Valona”: H. Myrto, in “Albania archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi”, I (A-D), Bari 1998, 42-45° ]: dato che non se ne parla in relazione alle guerre illiriche, svoltesi alquanto più a nord, è presumibile che l’attività piratesca della zona sia da collocare al di fuori dell’àmbito cronologico di esse. [nota del testo: il fatto che il geografo greco Strabone (Amasea, ante 60 a.C. – Amasea (?), 23 d.C. circa) VI, 3, 5, C281, ricco di informazioni sulla rotta che aveva come punto di riferimento anche l’isola si Sason, non accenni alle attività piratesche dei suoi abitanti lascia comunque pensare che il problema fosse risolto da tempo]. Altre due centrali di pirateria non “grande” ma “piccola” furono Corcyra Nigra (Korcula-Curzola) e Melita (Mljet-Meleda) [nota del testo: ne parla Appiano (Il secolo), nel suo testo intitolato “La conquista dell’ Illirico”]»).
L’isola di Saseno è anche visibile da Otranto al di sopra della linea di orizzonte sul mare nelle giornate in cui il cielo è particolarmente terso.
Impossibile non rilevare qui, coincidenza o meno che sia, la suggestione linguistica tra il toponimo Valona/Aulona e il nome della mitica Avalon del medioevale ciclo arturiano!
Immaginiamo che le opere oggi perdute su Artas, come quella di Polemone, ben trattassero di questi fatti, qui solo da noi intuiti e ipotizzati. E se dunque Artas avesse sconfitto davvero i pirati di “Sason”, e il nome di quegli insidiosi pirati assalitori “Sasonis” (caso gentitivo: di Saseno), fosse stato presente nelle fonti che trattavano di Artas giunte nelle mani di eruditi medioevali, soprattutto ecclesiastici, ciò avrebbe potuto stimolare la fantasia di un erudito che doveva inventare la figura di un re condottiero impegnato contro gli invasori “Sassoni”, invece, dell’Inghilterra e provenienti dal nord Europa!
Nel bisogno di creare la figura di un re mitico difensore delle genti locali, per spronare gli autoctoni a prendere le armi, a ritrovare l’orgoglio per ricacciare via gli invasori germanici passati Sassoni, Angli, Frisoni, Iuti o nuovi, i Normanni (le genti del nord, da cui il loro nome, anche chiamati Vichinghi) autori inizialmente soprattutto di azioni di sanguinaria pirateria contro i ricchi e indifesi monasteri, la figura di un leggendario re Artos che aveva sconfitto i pirati Sasenidi (dell’ isola di Saseno), nella baia di Aulona (Valona), dove poi forse era scomparso, re di una terra di mezzo, tra due mari come la Messapia, termine che etimologicamente pare avere proprio questo significato in greco, ben poteva ispirare la figura di un difensore re Artù campione della guerra contro i Sassoni invasori della sua terra, un regno isolano, la Britannia, una terra tra le acque del mare quindi. Regno esteso anche sul continente, in particolare nella francese Bretagna, abitata da genti della stessa etnia celtica vivente in Britannia. Anche la Francia settentrionale subì le azioni di pirateria di queste genti germaniche, e come la Britannia, alla fine una regione del nord della Francia (che dai conquistatori prese il nome di Normandia) fu definitivamente conquistata dai Normanni.
I Normanni si dedicarono alle scorrerie a partire dall’inizio del IX secolo. Dotati di navi leggere senza ponte e senza remi, le drakkar cioè “dragoni” (e “drago” è termine di origine greca), ornate da un serpente di mare intagliato sulla prua, batterono le coste della Francia, dell’Inghilterra fino alla penisola Iberica, all’Italia e alle isole del Mediterraneo occidentale, passando solo in secondo momento all’occupazione ed insediamento fisso. Inizialmente pagani e dediti alle razzie, ma in seguito allo stanziamento in Francia si convertirono al Cristianesimo. Ottimi guerrieri, tanto che venivano richiesti come mercenari perfino dall’Impero bizantino, erano specializzati nel combattimento a cavallo e utilizzavano principalmente la spada.
Un’ altra possibilità per ispirare in un autore medioevale inglese un legame con il termine etnico dei “sassoni” invasori d’Inghilterra, negli scritti antiche sul Salento, potrebbe trovarsi nel toponimo salentino, (attestato dalle antiche fonti): “Sasinum”, “Sasina portus”, “Saxina”. (Vedi anche in “Gli Studi Storici in Terra d’Otranto” a cura di Luigi G. De Simone (1835-1902), stampato a Firenze nel 1888, Tipografia Galileiana di M. Cellini E.C.). Plinio il Vecchio (23/24-79 d. C.), nella sua opera “Naturalis Historia”, parla di questa località salentina che chiama “portu Sasine” che alcuni studiosi collocherebbero a Porto Cesareo.
In patria poi Artas, dati i rapporti spesso tesi e bellicosi con la vicina colonia spartana magnogreca di dori insediatasi a Taranto in territorio messapico, è probabile che si distinse anche per la sua attività diplomatica e/o militare contro i tarantini a tutela del suo popolo.
La storia dei Messapi dal V al III secolo a.C. è costellata di alleanze più o meno effimere contro gli Italioti o al fianco degli Italioti. Una di quieste fu l’alleanza sorta per iniziativa iapigia intorno al 473 a.C. in funzione antitarantina e antireggina, che portò alla momentanea vittoria dei Messapi sulle due potenti città magno greche e una spedizione punitiva iapigia contro Reggio. Gli storici greci ricordano che i Messapi sterminarono l’esercito di Tarentini e Reggini impiegando proficuamente la loro cavalleria. La disfatta di Taranto e Reggio fu terribile, Erodoto narra così dello sterminio di Tarentini e Reggini: “fu questa la più grande strage di Greci e Reggini che noi conosciamo, che dei Reggini morirono 3000 soldati e dei Tarantini non si poté nemmeno contare il numero” (Erodoto).
Nel 473 a.C. Taranto subì dunque una sconfitta clamorosa per mano degli Japigi, e l’avvenimento ebbe una forte eco in tutto il mondo greco tanto che Aristotele precisa che l’avvenimento “accadde un po’ dopo che i Persiani invasero la Grecia” e aggiunge che fu anche a causa di tale sconfitta che Taranto mutò il suo regime da aristocratico a democratico.
Se vi avesse partecipato a quella battaglia un giovanissimo Artas, all’età minima di 15-20 anni, nel 413 a.C., quando ricevette gli strateghi ateniesi, avrebbe avuto tra i 75 e gli 80 anni! Non possiamo escludere che fu un sovrano longevo e che si era già distinto da principe proprio in quella epica riscossa messapica!
Lo scritto scomparso, ad oggi purtroppo ancora, di Polemone su Arta poteva essere la fonte chiave di aneddoti e storie per la genesi della saga arturiana. Forse tale scritto era nelle mani ancora di alcuni studiosi locali salentini nel medioevo tempi in cui dal monastero di San Nicola di Casole e non solo passavano testi antichi d’ogni sorta, che venivano studiati, copiati, e conservati.
Quali sono gli eventi che resero così grande e celebre, persino oltre mare, nell’Ellade e ad Atene, Artas, il più noto e documentato dalle fonti re di Messapia!?
Artas un re storico, documentato dalle fonti antiche, tanto celebrato in patria e all’esterno, e definito il Grande, e mitizzato già in Messapia, dove in suo onore si celebravano della grandi feste, chiamate sempre sulla base del suo nome e del suo titolo di “Megas”, Grande, le feste delle “Megalartie”.
E’ lecito domandarsi se “le Megalartie” eran legate solo al re Artas, erano solo una sua celebrazione, o riguardavano tutti i possibili re Artas (con “Artas” divenuto quasi in Messapia un possibile titolo nobiliare; come Cesare, che dal nome del grande personaggio e condottiero Caio Giulio Cesare, diventa nome epiteto dell’imperatore romano, il Cesare!), o divinità messapiche con quel nome?
Interessante e qui comunque sottolineare come ad Atene si svolgeva annualmente una importante festa chiamata “Megala Dionysia”, (“le Grandi Dionisie”), tra il 10 e 15 del mese di Elafebolione (che andava dalla seconda metà di marzo alla prima metà di aprile circa; il nome del mese era legato alle Elafebolie, feste della caccia al cervo in onore di Artemide). Ad Atene veniva celebrato Dioniso Eleuterio, cioè Dioniso proveniente dal demo di Eleuthere, secondo la tradizione Dioniso sarebbe arrivato ad Atene proveniente da questa località che si trovava al confine tra Attica e Beozia, da lì sarebbe arrivato il suo culto. Queste feste, in cui si svolgevano anche processioni e sacrifici, vennero fondate o riorganizzate dal tiranno Pisistrato nel 535 a.C.
(Nota culturale territoriale salentina: ricordiamo che il colle più alto nel basso Salento, tra Otranto e Gallipoli, è chiamato Serra di Sant’Eleuterio, dal nome di un santo cristiano; il sito non è molto lontano dalla città di Parabita, dove nella cripta dedicata a Santa Marina un’ epigrafe in metallo racconta una tradizione secondo cui lì in passato si venerava la Dea Iside).
Questo parallelismo è estremamente interessante per noi che stiamo sviluppando una teoria a partire dal mosaico di Otranto che vede l’ipotesi di celebrazioni rituali che si svolgevano in Messapia e che equiparavano la figura dell’eroe locale Artas, (re storicamente realmente esistito, o anche già titolo regale richiamante un mitico Artas locale), a quella di Dioniso.
Abbiamo visto come di queste feste chiamate Megalartie di re Artos dei Messapi in Japigia, scriveve ancora nel XII sec. d.C., Eustachio, dunque ai tempi del mosaico di Otranto, riportando frasi da testi ben più antichi, e probabilmente da Polemone, l’autore che ad Artos messapico aveva dedicato persino una monografia, ma che è probabile ne dedico spazio anche in altre sue opere, ad esempio nella sua “Replica a Timeo”, il grande storico greco delle vicende anche mitologiche del sud Italia.
A sentire poi quanto scriveva il dottissimo Matteo Tafuri, nel ‘500, (sue le suggestive parole con cui abbiamo esordito questo lavoro), studioso strettamente collegato, come abbiam visto, al sapere dell’ Abbazia idruntina di Casole, nella sua epoca ancora taluni sapevano nel Salento di particolari dell’Artù di Terra d’Otranto, che nelle fonti frammentarie e poverissime a noi giunteci invece sull’Artos re messapico mancano. Ad esempio, che era stato edotto sulla filosofia di Pitagora, dato che alla setta dei pitagorici apparteneva il suo mentore, come ci informa il Tafuri. Pertanto, data la connessione cronologica nell’antica Terra d’Otranto messapica, tra re Artos e la diffusione del pitagorismo in Magna Grecia e anche tra i messapi, e la connessione spaziale tra la messapia di Artos, e la Terra d’Otranto di cui parla Tafuri, non poteva che essere il Re Artos dei messapi, l’ Artù di Terra d’Otranto del Tafuri! Tra gli altri particolari, Tafuri ci informa che l’ Artù salentino anche era legato all’invenzione di una tavola rotonda. Dati ulteriori sull’Artù salentino-messapico giunte al Tafuri tramite la tradizione orale locale e/o letteraria, e tra questi testi vi era forse proprio anche il perduto ad oggi testo di Polemone interamente dedicato ad Artas!? Non v’è dubbio che un simile testo sarebbe stato caro e trasmesso con cura per secoli, fino al medioevo, proprio nella medesima terra salentina, dato che trattava del grande re locale, e data la continuità culturale, e la mai interrotta alta tradizione erudita nel Salento, dai tempi della Messapia romana, di Ennio e di Pacuvio (grande tragediografo latino nato a Taranto e parente di Ennio), fino al Medioevo, tramite l’erudizione cristiana bizantina e latina, che preservò e tramando l’antico sapere.
Polemone scrisse circa 200 anni dopo Artas; le Megalartie ma anche il suo stesso titolo di “Megas” ci evidenziano la figura di un sovrano celebratissimo forse già in vita ed elevato probabilmente a livelli di divinizzazione. E’ probabile che pertanto Artas fu inserito in un sostrato mitico-religioso locale in parte preesistente.
In Messapia si festeggiava ogni anno la “Feste delle Bisbaia [Bisbee]”, festa della potatura delle viti, in messapico “bisbes” era il nome del falcetto da potatura. Artas forse in certe feste, e/o miti raccontati da Polemone o altri autori si identificava con Dioniso?
Da Esichio (V o VI sec. d. C.), nel suo “Lessico”, opera in greco, leggiamo: “Bisbes: così i Messapi chiamano il falcetto per tagliare le viti, e chiamano festa delle Bisbaia [Bisbee]” quella che noi chiamiamo klaudeteria [festa della potatura]”
C’è chi ha ipotizzato che il termine “bisboccia”, che nella frase “fare bisboccia” derivi dal nome di quella festa messapica indubbiamente dionisiaca dato il legame con la viticoltura, così come il termine “baccano”, deriva dal nome dei baccanali, le rumorose feste in onore del dio Bacco/Dionioso in ambiente italico dove ci si ubriacava pesantemente con le ancor oggi ben immaginabili conseguenze. “Fare bisboccia” è termine utilizzato anche in Salento e che è correlato proprio all’azione di bere vino e divertirsi solitamente insieme agli amici.
Il nome Artù
Il nome Artas, (e sue strettamente collegate varianti), compare diffusissimo nell’epigrafia messapica, soprattutto funeraria, scoperta dall’archeologia, ed in innumerevoli siti messapici (Ostuni, Ceglie Messapica, Manduria, Alezio, Ruvo, Gravina, Vaste, Ugento, Oria, ecc. – “Artorius” a Canosa ), a dimostrare la diffusione che il nome Artas aveva presso il popolo messapico e per tutto il corso della sua storia attraverso i secoli, forse proprio per il ricordo del grande re, forse per il valore sacro del nome legato alla divinità Artemide, venerata anche presso i messapi (Artemis, a lei erano dedicati anche santuari) e a cui era sacro l’orso (“árktos” il nome dell’orso in greco); ad Artemide certamente era legata la dea chiamata in lingua romana Artio e correlata proprio all’orso. “Potnia Theron” (dal greco “Signora degli animali”) è un termine usato per la prima volta da Omero nell’Iliade, come attributo di Artemide. Il nome Artù (Artos) suona anche come il termine pane (“artos“) in greco, e questo ad ulteriore incremento della sacralità di un tale nome regale.
Il teonimo Artemide si ritiene legato etimologicamente a quello dell’ orso; era una dea madre, signora della Natura e delle belve, cui era sacro l’orso (arctos, in greco, arctus in latino). Gli Orsi bruni, molto più numerosi e diffusi di oggi, vivevano nella penisola Balcanica, come in sud Italia, nelle aree selvagge e boscate. Oggi in Italia si registrano solo pochi individui relitti sull’Appennino abruzzese, da proteggere e far diffondere massimamente.
Artita, Artia è il nome femminile corrispondente che pure appare in area messapico.
Il genitivo del nome messapico Artas è Artahiaihi in messapico, il nominativo Artahias.
Tra i luoghi Gravina (ARTIA), Ruvo (ARTOS da influsso greco sul nome messapico Artas, genitivo).
In latino anche Artius, e in greco Artios,
Troviamo nell’epigrafia messapica il nominativo del nome personale individuale “artas”, (anche “artos”; probabile genitivo messapico “artahi”), come anche il collegato gentilizio nominativo “artahias”, (genitivo del gentilizio “artahiaihi”), talvolta con τ, tau, per la “t”, tal altra con θ, theta, tal altra con il simbolo grafico dell’alfabeto messapico ta, simile ad una ψ a tridente, detto “tridente a base quadrata”; probabilmente non sottendenti pronunce diverse, seppure tali varianti grafiche possono comparire in epigrafi di zone diverse della Messapia. La variante “artia” ed “artita” a Gravina; “artorres” a Oria. La tau per la t, è tramandata anche nella trascrizione greca del nome messapico, come è in “Artas”, nome del famoso dinasta messapico di cui scrisse Tucidide.
Altre attestate varianti onomastiche si avvicinano ancor più di più al teonimo Artemide.
Per “Artas” messapico, attribuito ad un dinasta, (sebbene sia certo che si tratti per “artas” in messapico di un antroponimo diffuso), alcuni studiosi hanno ipotizzato che potesse anche trattarsi di un titolo regale o principesco attribuito al sovrano. In ogni caso è più che probabile che fatta salva l’ importanza del Grande Artas storico, più sovrani messapici ebbero il medesimo importante nome dall’ intrinseco valore etimologico divino legato al dio orso, e alla dea orsa primigenia.
In ogni caso presso i Messapi si sviluppò a partire dal nome proprio “artas”, il gentilizio “artahiaihi”, il nome cioè di una famiglia (stirpe, gens in romano), che veniva ereditato come un cognome. Tutto questo lascia immaginare un lungo uso come nome personale individuale di Artas, prima di essere usato come gentilizio, un suo diffuso e prolungato che lo studio e la ricerca nel campo dell’epigrafia messapica ha ben confermato. (Vedi dello studioso Ciro Santoro “La nuova epigrafe messapica IM 4.16, I-III di Ostuni ed i nomi in art-”).
Per l’ etimologia del nome proprio Artos e sue varianti, (come del teonimo Artemide), occorre ricordare che originariamente i nomi erano degli appellativi, ed il legame con l’ orso, (“arctos” in greco), sembra a tal fine molto probabile.
Nomi in art-, sia maschili che femminili, son in antichità molto diffusi, e attestati in Italia, Gallia, Africa, Illirico, ecc., su epigrafi latine, greche, etrusche, ed in fonti letterarie. A Taranto (“Artimia”), a Pozzuoli (“Artius” – ritenuto di probabile origine messapica). In nomi etnici in Illiria e di principi illiri. E ancora in toponimi come il fiume Artatus, e l’isola illirica Artion.
Artorius, -a , antroponimo attestasto numerose volte in Italia, Gallia, Africa, Illirico. È corrispondente latino al messapico Artorres.
Numerosi nomi in art- sono attestati nell’ onomastica celtica, e di aree celtiche: Artanus, Artenus, Artiacus, Artidius, Artius, Artognou.
Presente oggi in Italia è anche il cognome Arturo, attestato pure in Puglia e Sicilia, e ancor di più in Calabria.
E anche in area celtica tali nomi possono essere etimologicamente ricondotti ad orso, in gallese orso si traduce “arth”, nell’antico irlandese “art”, (“harthz”, in basco, forse da parastrato o abstarto come si dice, in linguistica, cioè influsso da lingue geograficamente prossime); celtico-gallico“artos”!
Taluni studiosi ricordano però anche che “art” in irlandese vuol dire roccia, da cui deriva il termine inglese earth che vuol dire terra. Questo potrebbe anche spiegare il perché spesso in ambiente celtico, i monumenti megalitici son associati facilmente da leggende locali diffuse popolarmente, e anche presenti nel ciclo bretone letterario, a re Artù.
Il nome della dea Artemide appare già dal XIII sec. a.C., in documenti micenei in Lineare B, il sistema di scrittura sillabico usato dai micenei, la cui lingua era già il greco. La lingua che emerge dalla scrittura lineare B, il suo dialetto miceneo, il più antico dei dialetti greci noti, più antico di diversi secoli dei dialetti greci trasmessici dai più antichi testi letterali, quelli dei poemi omerici (l’Iliade e l’Odissea), era proprio la lingua delle genti, micenee appunto, che occupavano il territorio dell’Ellade nell’ Età del Bronzo, e che appartiene alla famiglia dialettale arcado-cipriota, (più recenti sono i dialetti delle famiglie dialettali in cui il greco è diviso in diverse famiglie dialettali, quella eolica, quella ionica, quella dorica, e appunto la più antica antiche di tutte, quella aracado-cipriota). Il miceneo appare in definitiva l’antenato del dialetto arcadico che era parlato anche nel I millennio a.C. nel cuore della zona montuosa del Peloponneso che si chiamava Arcadia, e antenato del dialetto che era parlato nella lontana Isola di Cipro, eccentrica rispetto al mondo egeo, posta molto più a oriente. Si trattava poi di una scrittura strettamente imparentata alla Lineare A per i simboli usati. La Lineare A era il sistema di scrittura proprio della civiltà dei minoici, (così chiamati dal nome del loro mitico re Minosse), la civiltà che nell’ Età del Bronzo si sviluppò con baricentro l’ Isola di Creta , e che grande influsso ebbe sui micenei. La loro lingua, originariamente però non era il greco, e lo divenne solo dopo la conquista micenea di Creta!
Artemide era una dea indigena dell’ Arcadia, lì venerata anche nella forma di orsa, e orsi si credevano gli stessi arcadi, come nell’etimologia del loro nome. Probabilmente in origine antiche tribù totemiche che avevano nell’ orso il loro animale totem. Per l’origine di Artemide, con il suo nome e i suoi attributi l’attenzione di alcuni studiosi la colloca più nell’area illirica e in quella greca, che in quella dell’Asia minore, o in Lidia, dove pure fu venerata. Così alcuni studioso ritengono un prestito dal greco del nome Artemide, all’area celtica, per la dea chiamata Artionis (o Artio), di cui si legge il dativo “Artioni” in un’ epigrafe latina di dedica, incisa sulla base in metallo correlata alla statua in bronzo che mostra un grande orso, dietro al quale c’è un piccolo albero, e che sta di fronte a una donna seduta su una sedia. Quest’ultima sembra tenere della frutta sul suo grembo, che serve forse a sfamare l’animale. Questa statua è stata trovata nei pressi di Berna, in Svizzera. Alla stessa dea rimanda anche un’altra iscrizione, proveniente però dalla città di Treviri, nell’odierna Germania.
E’ forse non trascurabile l’ importanza, certo nota anche ai romani, oltre che ai greci che ne scrivevano monografie su di lui, del re messapico Artos il Grande. E la significativa diffusione nel mondo romano del nome Artorius, oltre che grazie alla stella Arturus, di influenza greca, si deve proprio alla grande fama del re messapico. E’ con i romani, che il nome Artorius giunse anche nel mondo celtico, dove è attestato, con sue varie varianti zonali, come quello di Artemide, nell’ epigrafia, e in rare fonti scritte, per l’epoca imperiale e l’alto medioevo nelle aree celtiche europee d’oltralpe.
L’Artù bretone, sebbene portante un nome proprio diffuso dai romani, nelle cronache fantasiose dei primi testi scritti medioevali su di lui, è detto difensore delle genti locali, oltre che contro i sassoni invasori, anche contro l’ Impero romano. Par quasi un’ eco dell’ inimicizia iniziale degli indipendenti Messapi contro Roma, che lì portò a far cadere le plurisecolari ostilità contro Taranto, per unirsi a Pirro re dell’ Epiro, per frenare le mire espansionistiche romane! Un’ ostilità che ancora echeggia in alcuni epiteti griki, di cui abbiam dissertato avanti. (Osserviamo qui che come termine onomastico, come pare dall’ epigrafia messapica, presso i Messapi, si era persino diffuso il nome Roma, attestato da epigrafi già del V-VI sec. a.C.).
E’ evidente che il nome maschile Artas, Artos, in latino diviene Artus, Arturus, Artorius, e quindi in volgare romanzo italiano: Artù, Arturo.
Il testo perduto su Re Artos dei Messapi scritto da Polemone
Sempre le antiche fonti narrano che quel re messapico, Artas detto il Grande, era così famoso che addirittura esisteva un intero libro monografico a lui dedicato. Si trattava di un’ opera di Polemone di Ilio, detto anche il Periegeta, autore di epoca ellenistica, (visse infatti ai tempi del re del regno egizio ellenistico di Tolomeo V Epifane, che regnò dal 210 a.C. al 180 a.C.). Con il termine greco periegesi s’intende quel filone storiografico, soprattutto di epoca ellenistica, che, intorno a un itinerario geografico, di cui riporta descrizioni fisiche, dà una quantità di notizie storiche, mitiche, religiose ed antiquarie, su popoli, persone e località, verificate, quanto possibile, dall’esperienza diretta. I suoi scritti contenevano molte notizie di carattere mitologico, e nel complesso erano animati da un forte interesse di natura scientifica. Un re tanto grande e famoso appunto, quell’ Artas, che gli autori antichi ellenistici, e certamente anche già altri prima di loro, vi avevano raccolto e tramandato numerosi dati e racconti, e sul quale grande fu nei secoli successivi, probabilmente, anche l’insieme di dati trasmessi e rielaborati nella fucina della tradizione orale.
Polemone scrisse la sua opera diversi decenni dopo re Artas il Grande, motivo per cui vi era stato tempo sufficiente perché ai dati forniti dai suoi contemporanei e trasmessi dalle fonti si aggiungesse una stratificazione fatta di un tessuto mitizzante su quell’ importante personaggio che contribuì probabilmente ad arricchirne e certamente a rendere ancor più interessante la sua figura, già di per sé certamente carismatica e avventurosa per le sue gesta in vita.
Purtroppo però l’opera di Polemone è ad oggi perduta! E per questo già diversi eruditi salentini dei secoli passati se ne rammaricavano; così ad esempio lo scrittore Gasparo Papatodero, sacerdote della Cattedrale di Oria, scriveva nella sua opera edita nel 1775, e intitolata “Della Fortuna di Oria, Città in Provincia d’ Otranto nel Regno di Napoli, dal principio della sua fondazione fino ai tempi, ne’ quali fu ai Romani soggetta, Dissertazione”, che: “Polemone aveva scritto un’ opera intorno al Re Arta, la quale se per l’ingiuria de’ tempi non si fosse smarrita, avremmo, credo, bellissime, e curiose notizie intorno alla nostr’ Oria, e intorno a questo Re così famoso”.
Opere che da antichi papiri o manoscritti potrebbero ancora tornare a noi, negli studi archeologici e archivistici. Ma quanto di quel sapere sui messapi, sul Salento antico era ancora conservato e tramandato, trascritto e oralmente, in epoca medioevale, al tempo dell’Abazia otrantina di San Nicola di Casole e nella sua famosa biblioteca!? Non si dimentichi che l’ambiente culturale otrantino e del Salento tutto, ai tempi della realizzazione del mosaico, era arricchito dalla presenza di questa importantissima abazia, che fu un faro per tutta la cultura europea a livello storico, artistico, culturale, scientifico, filosofico, teologico e politico. Studi umanistici e scientifici insieme. Una sorta di cittadella della scienza. Nel monastero venne creata una biblioteca, con numerosissimi volumi greci e latini. Era all’epoca una delle biblioteche più ricche d’Europa. Crocevia per gli scambi culturali tra Oriente e Occidente. La fama di Casole si estendeva ben oltre i confini del Salento. Vi fu lì creata anche la prima casa dello studente nel mondo occidentale. Testi di lingua latina e di lingua greca, che lì anche venivano trascritti/copiati e così salvati e diffusi. Ma non mancavano anche approfondimenti di testi e cultura ebraica.
Difficile dire se popolarmente era ancora diffusa la fama dello storico re salentino Artos al tempo del mosaico di Otranto, per certo possiamo però dire che era ben conosciuto dagli eruditi locali, intrisi nello studio e trascrizione delle opere greche e latine antiche. E chissà che non fosse ancora nelle loro mani proprio l’opera di Polemone, o parti di essa, sul re Artos! O altre opere antiche sempre narranti di quel re Arta salentino.
Così allo stesso modo ci chiediamo se non fu quell’opera, o anche altre opere sul grande re messapico, a ispirare leggende orali in ambienti alto-medioevali bretoni, gallici e britannici, dove la cultura mediterranea, greco-latina, si diffuse prima con il dominio dei romani e poi con l’opera di monaci e sacerdoti cristiani, e in quegli ambienti culturali furono messe per iscritto le prime saghe in gran parte fantasiose volte a rinobilitare la storia locale, e che attingevano a piene mani con fantasia alla storia e mitologia greca e romana e biblico-cristiana, e in quel background trovarono posto i primi racconti scritti su re Artù, ad oggi noti, e precedenti di alcuni anni e secoli al mosaico di Otranto.
Ma ancora oggi, dopo secoli di meticolose ricerche, sempre più studiosi hanno perso la speranza di trovare una storicità, un fondamento in quelle terre nordiche, al mitico Artù altomedioevale, mentre altri hanno invece rintracciato sempre più influssi mitici classici mediterranei nella saga arturiana.
Ci fu un reale re Artù in Inghilterra?
Nelle fonti antiche e archeologiche in Bretagna e Inghilterra, è sporadica la comparsa di qualche nome nelle fonti altomedievali come nelle epigrafi che si richiami in qualche modo al nome Artù, nulla però che parli davvero e con la giusta enfasi di un re altomedioevale con quel nome, e ciò è davvero molto strano, anomalo se fu davvero un re così famoso. E così quelle comparse sporadiche si spiegano facilmente con la diffusione del nome proprio Arturus, Artorius in quelle terre a seguito della prolungata dominazione romana.
Per alcuni studiosi, Artù potrebbe essere un personaggio ispirato a “Cu Chulainn” , un protagonista di poemi epici irlandesi, ma questa ipotesi non spiegherebbe molto di Artù a partire neppure dal suo nome. Altri hanno immaginato correlazioni con un possibile dio del pantheon celtico, forse il simbolo della terra stessa (“Art” roccia, da cui la parola inglese “Earth” terra), poi trasformato dalla leggenda in un essere umano. Coloro che invece credono che Artù sia stato comunque in origine un personaggio storico vissuto realmente in Inghilterra lo collocano nel VI secolo d.C. e lo immaginano come il re o il capo di una tribù britannica impegnata nella resistenza contro gli invasori Sassoni e di altri gruppi, altri lo credono essere una versione mitizzata ispirata al re Riotamo (scritto anche Riutimus o Riotimus) un leader militare romano-britannico realmente esistito che era attivo intorno all’ anno 470 d.C. e che combattè contro i Goti in alleanza con l’Impero Romano ormai in declino. Sbarco con diverse sue navi sul continente per dar manforte a Roma contro i Visigoti, ma intercettato da questi nonostante il suo esercito di migliaia di uomini fu sconfitto prima che riuscisse ad unirsi alle forze militari dell’ Impero romano.
Egli è chiamato dalle fonti antiche “re dei Britanni”. diverse son le fonti storiche che ne attestano l’ esistenza e questa sua sfortunata impresa bellica. Di lui parla anche lo storico e burocrate romano del VI secolo Jordanes (o Jordanis anche scritto). L’entità del regno di Riotamo resta comunque poco chiara, e i punti di incongruenza con la leggende di Artù son parecchi, dato anche che Artù viene detto combattere contro i romani, mentre Riotamo era invece loro alleato.
Genti germaniche Sassoni, Angli, Iuti e Frisoni, tra V e VI sec. d.C. dal continente invasero infatti la Britannia, ormai priva della difesa delle legioni romane. L’ Impero Romano d’Occidente era caduto nel 476 d.C. (E il caso volle che si chiamasse Romolo Augusto l’ ultimo imperatore, proprio come il primo leggendario re di Roma, Romolo). L’ Impero Romano d’Oriente invece continuò invece fino al 1453 anno della caduta di Costantinopoli sotto l’imperatore Costantino XI, lo steso nome dell’ imperatore Costantino I che aveva fissato in Bisanzio la Nuova Roma, da lui battezzata Costantinopoli, e diviso in due partì l’ Impero. Una scintilla istituzionale di quegli imperi continuò a brillare però nei fatti nelle sopravvissute sino ad oggi istituzioni della chiesa romana, quella d’occidente, e in quella d’oriente, come nei regni che si riconobbero legati a quelle istituzioni religiose nel corso dei secoli.
Già nel IV sec. gli Scoti (o Scotti) antico popolo celtico originario dell’Irlanda, invase le aree settentrionali dell’isola inglese abitata dai Pitti, e che i romani avevano battezzato “Caledonia” (probabilmente ispirati dal nome della regione del mito erculeo greco del cinghiale Calidone).
Dagli Scoti il nome Scozia preso da quella regione.
Dagli Angli deriva il nome Inghilterra assunto dalla Britannia, e il nome di anglo-sassoni oggi sinonimo di inglesi.
Lo stesso nome “Arthur”, in inglese, non fornisce indicazioni sulla sua origine. Vi è chi sulla base dello stesso nome suo “Arthur”, in inglese, che ben deriverebbe come ricordato dal latino “Artorius”, lo ipotizza esser stato un “Comes Britanniarum”, ovvero un rappresentante locale dell’Impero Romano. Altri dal nome lo collegano al gaelico “Arth Gwyr” (“Uomo Orso”), o ancora al già citato “Art” (roccia in irlandese), come se fosse un suo epiteto o soprannome di battaglia se non un nome proprio.
Un principe britanno chiamato “Arturius, figlio di Aedàn mac Gabrain Re di Dalriada” viene citato dall’ agiografo Adomnan da Iona scrittore della “Vita Columbae” (“Vita di San Colombano”), opera del VII secolo d.C. (San Colombano vissuto dal 542 circa, al 615, fu un monaco missionario irlandese, noto per aver fondato da abate numerosi monasteri e chiese in Europa), ma nulla oltre il nome comunque diffusosi con l’Impero romano in Inghilterra permette di individuare il leggendario Re Artù con questo poco famoso principe.
Lo pseudo-storico Nennio, nella sua “Historia brittonum” (opera del IX secolo d.C.) racconta che il “dux bellorum” (“signore della guerra”), di nome Artù, era il comandante dei Britanni durante una importante battaglia contro i sassoni; e negli “Annales Cambriae”, compilati qualche tempo dopo, nel X secolo, (“Annali gallesi”, si osservi come il nome latino “annales” richiami la tradizione latina di Ennio), una cronaca di eventi datati, commissionata da Hywell, re del Galles, si narra che quel generale Artù sarebbe morto in battaglia nell’anno 538 d.C.
Ma se quel Re Artù fosse esistito davvero secoli prima, sarebbe alquanto strano che invece altri storici vissuti nelle poche in cui si collocava l’esistenza di questo nebuloso Artù, tra cui Gildas il Saggio (un abate e storico britanno che predicò anche in Irlanda oltre che in Inghilterra, fondatore di monasteri è vissuto dal 494 circa al 570; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica) e il Venerabile Beda (monaco e meticoloso storico inglese vissuto dal 673 circa al 735), invece non fecero alcun cenno a un tal famoso condottiero con quel nome (o sue varianti) nelle loro diverse opere ben giunte sino a noi. Gildas poi approfondì anche gli eventi disastrosi che ebbero luogo in quelle terra dopo il ritiro delle legioni romane dall’Inghilterra, e neppure per quegli eventi si menziona mai di un eroico Re Artù, o condottiero di quel nome o epiteto difensore dei britanni.
Tra la fine del V sec. d.C. e l’ inizo del VI sec. d.C., la popolarità del nome Artù sembra crescere e non meno di sei principi britannici furono battezzati Artù, ma nessuno di essi sembra esser stato abbastanza importante da aver potuto dar origine alla leggenza, così la fama di un leggendario re Artù sembra comunque diffondersi in narrazioni orali gallesi e forse anche scritte a partire dal 600 d.C. circa. Se così, dobbiamo immaginare che nell’area britannica la leggenda vi fu diffusa sempre probabilmente ad opera di monaci eruditi alcuni secoli prima di Nennio.
A questo punto fondamentale è ricordare che tutta la cultura monastica che porta, diffonde e consolida il cristianesimo nelle due Bretagne, (la Britannia e la Bretagna), nel corso dell’ alto medioevo proveniva in gran parte dall’Italia, e con tale cultura lì affluivano i classici greci e latini, quando non vi fossero già presenti da epoca imperiale romana. Tutta l’ erudizione, e l’ insegnamento del leggere e scrivere dei rudimenti dell’alfabetizzazione passava dai monasteri cristiani in continuo contatto con Roma e l’Italia tutta.
Non dimentichiamo che Goffredo di Monmouth affermò di aver attinto ad una fonte speciale per la sua storia. A quanto pare l’ amico Walter, arcidiacono di Oxford, “uomo esperto di storia dei paesi stranieri” gli aveva fornito “un certo libro molto antico scritto in lingua britannica” e Goffredo si appella a questo libro proprio in riferimento ad Artù.
Era questo, se realmente esistito, (e non una trovata letteraria secondo il comune topos dell’invenzione del rinvenimento di un vecchio testo manoscritto, di solito di autore anonimo, per dare rilevanza e l’autorità degli antichi a quanto di lì in poi si narra), un testo più antico dal quale, come fonte, aveva tratto dati anche Nennio che per la sua opera dice di aver attinto ad ogni fonte disponibile di scrittori romani, irlandesi e inglesi ed anche da “le tradizioni dei nostri anziani”, “ammucchiando – nel suo testo come lui stesso scrive – tutto ciò che ho trovato”?
Effettivamente nella saga arturiana vediamo spesso il riferimento a fonti precedenti, oltre a questo caso Goffredo di Monmouth, vediamo ad esempio anche il poeta Robert Wace, che per la introduzione del tema della Tavola Rotonda, dice di averlo tratto da una precedente raffigurazione di Artù con i suoi, e così Chètrien de Troy ci fa capire che la stroria di Perceval e il Graal era già nota al suo mecenate Filippo d’Alsazia che espressamente aveva commissionato a Chértrien, poeta della sua corte, di metterla per iscritto.
Artù che emerge dall’ opera di Nennio e Goffredo viene dunque creduto come vissuto tra V e VI sec. d.C., e apparirebbe per la prima volta nella letteratura gaelica, ma la questione è problematica poiché le poesia gallesi furono trascritte tra il XII sec. e il XIV sec. d.C., sebbene si pensa siano state originariamente composte nei secoli VII o VIII, dunque trascritte a partire dall’epoca in cui scrive Goffredo di Monmouth, quindi a causa di conseguenti incertezze sulle possibili influenze di Goffredo e Nennio sugli autori che le posero per la prima volta per iscritto dalla tradizione orale, o che le ricopiarono con aggiunte e adattamenti che non si possono escludere, non possono essere ritenute prove dirette dell’ esistenza di Artù, sconosciuto agli storici che vissero invece nella sua presunta epoca!
In un antico poema in questa lingua, “Y Gododdin” (circa del 594 d.C.), il poeta britannico Aneirin (535-600), un bardo, scrive di uno dei sudditi del regno chiamato Gododdin, (sorto agli inizi del V secolo nella Britannia nord-orientale dopo l’abbandono dei Romani), che lui “nutriva i corvi neri sui baluardi, pur non essendo Artù”.
Ad ogni modo, questo poema è ricco di inserimenti posteriori e non è possibile sapere se questo passaggio sia parte della versione originale o meno. Se sia ad esempio un’ aggiunta che si riferisce alla tradizione di nutrire i corvi sulle torri di città sede della corona, come oggi ancora a Londra, cui spettava al re badare, raffigurato come Artù, anche perché si credeva che alla presenza dei corvi era radicata la solidità della monarchia e del regno, o una aggiunta influenza
Così stessi problematica per altri riferimenti ad Artù in poemi gallesi coevi. Alcuni poemi di Taliesin (un bardo nelle corti di re britannici della zona del Galles.): “The Chair of the Sovereign”, che ricorda un Artù ferito; “Preiddeu Annwn” (“I Tesori di Annwn”), cita “il valore di Artù” e afferma che “noi partimmo con Artù nei suoi splendidi labours”; poi il poema “Viaggio a Deganwy”, che contiene il passaggio “come alla battaglia di Badon con Artù, il capo che organizza banchetti/conviti, con le sue grandi lame rosse dalla battaglia che tutti gli uomini possono ricordare”. Il riferimento è all’ epica vittoriosa battaglia di Badon contro i Sassoni di cui scrisse Nennio: “Artù combatté contro di loro, insieme ai re britannici, di cui era il capo in battaglia”.
Nennio parla di dodici battaglie di Artù, e i luoghi sono tutti assolutamente oscuri. Qui si evidenzia il suo ethos cavalleresco cristiano, e il suo grande valore militare. Il monaco Nennio riferisce che nella battaglia a “Mons Badonicus”, “morirono novecentosessanta uomini in un giorno, in seguito a un singolo attacco di Artù, e nessuno li fece cadere eccetto lui”.
Nessuno dei luoghi delle battaglie di Artù fornito da Nennio è incluso nell’ elenco di città britanniche forniteci da lui stesso, motivo per cui si ritiene che il monaco prese i nomi dei luoghi in cui si svolsero le battaglie da un poema antico che celebrava le conquiste di Artù. Si ma di quale Artù? Forse Artos messapico?
Sulla battaglia di Badon poi vi è totale silenzio nelle “Anglo-Saxon Chronicle” che sono una raccolta di annali in antico inglese che racconta la storia dei anglosassoni. Il manoscritto originale della Cronaca è stato creato alla fine del IX secolo, probabilmente nel Wessex, durante il regno di Alfredo il Grande. Più copie furono fatte dell’originale e poi distribuite ai monasteri in tutta l’Inghilterra, dove sono stati aggiornati in modo indipendente. In un caso, la cronaca era ancora in fase di aggiornamento attivamente nel 1154.
Così allo steso modo riferimenti ad Artù appaiono in numerose opere agiografiche di santi del V secolo, ma è molto probabile che si tratti di aggiunte successive poiché queste vite furono messe per iscritto dal XI sec. a.C. Ad esempio la vita di san Iltud, che sembra essere scritta verso il 1140, dove si dice che Artù fosse un cugino di quell’uomo di chiesa. Molte di queste opere dipingono Artù come un fiero guerriero, e non necessariamente moralmente impeccabile come nei successivi romanzi. Secondo la Vita di san Gildas (morto intorno all’anno 570), opera scritta nell’XI secolo da Caradoc di Llancarfan, Artù uccise Hueil, fratello di Gildas, un pirata dell’isola di Man. Strano che invece Gildas che fu uno storico non menzioni invce per nulla Artù! Attorno al 1100 Lifris di Llancarfan asserisce, nella sua Vita di san Cadoc, che Artù è stato migliorato da Cadoc. Artù compare anche nel racconto in lingua gallese “Culhwch e Olwen” (messo per iscirtto tra XIV e XV sec. d.C.).
Gli antichi testi altomedievali, in lingua gaelica, chiamano Artù “ameraudur” (“imperatore”, prendendo il termine dal latino). Nella “materia di bretone” medioevale si dice che Artù non solo ripristinò l’ ordine in Britannia sconfiggendo gli invasori Sassoni e altri gruppi, ma fondò anche un impero, annettendo l’ Irlanda, Scandinavia, e ampie regioni della Francia, sconfisse in battaglia persino l’imperatore di Roma, e liberò per sempre il suo paese dalla minaccia dell’ invasione romana. La prima opera che presenta Artù come re dalla reputazione internazionale è la “Storia dei re di Britannia” di Goffredo di Monmouth.
Tutto questo non corrisponde in alcun modo alla storia!
E’ evidente sempre più nella saga di Artù l’intento storiografico patriottico e volto a ravvivare l’amor patrio in tempi difficili, come già aspirato espressamente da Nennio, e forse da eventuali autori più antichi alle radici della genesi del fortunato mito di Artù in Britannia.
Nell’ XI secolo Artù era già considerato dagli inglesi un eroe nazionale, e le sue imprese – diffuse dalle canzoni dei Bardi – erano note non solo in Gran Bretagna, ma anche in Irlanda, nel nord della Francia, e nella lontana Italia: lo dimostra un bassorilievo sulla “Porta della Pescheria” detta, del Duomo di Modena, realizzata si pensa fra il 1099 e il 1120, che rappresenta il re Artù e i suoi cavalieri che salvano la regina Ginevra da alcuni malfattori. La Porta della Pescheria, deve il nome al fatto che nei pressi si trovava un banco per il commercio del pesce.
Si mostra nell’archivolto la scena bellicosa di Artù bardato a cavallo, “Artus de Bretania”, e i suoi cavalieri e servi al seguito che assalgono un castello in cui Mordred tiene prigioniera sua moglie Ginevra con l’aiuto anche di alcuni suoi servi. Delle epigrafi scolpite indicano i nomi di diversi dei personaggi; se per Artù non vi sono problemi, altri nomi paiono potersi ricondurre a varianti di quelli di Ginevra e del perfido Mordred.
La Porta in questione è stata realizzata nella fase iniziale di costruzione del Duomo che risale al XII secolo, quindi costituisce la prima testimonianza iconografica a noi giunta dei racconti arturiani ed è anteriore di almeno vent’anni all’opera di Goffredo di Monmuouth. Già però di Artù aveva scritto l’autore Nennio e non solo lui!
Nel corso dei secoli si sono raccolte numerose narrazioni eroiche e mitiche sulla figura di Artù che circolavano oralmente portate da mercanti, soldati, pellegrini, chierici e menestrelli in ogni nazione, tra cui l’Italia e l’archivolto è una prova di questo. L’episodio specifico della liberazione di Ginevra potrebbe precede ogni redazione scritta quindi in tal caso potrebbe essere giunto a Modena per via orale attraverso i narratori franco-bretoni. A meno che non sia giunto con il testo scritto grossomodo coevo o di poco precedente della “Vita Gildae” (“La Vita di San Gildas”), scritta da Caradoc di Llancarfan nel XI sec. d.C., dove compare la descrizione di un episodio molto simile a quello scolpito a Modena: la sposa di Artù tenuta prigioniera in un castello da un malfattore che l’aveva rapita con la forza. La città è cinta d’assedio da Artù, che reclama la restituzione della moglie; ma la città fortificata è circondata da vaste paludi e da un fiume impetuoso che la protegge e inoltre il malfattore può contare sull’aiuto degli abitanti della regione. La guerra si protrae a lungo senza esito, finché San Gildas interviene come mediatore, fa restituire ad Artù sua moglie “Guennevar” (Ginevra), la pace è ristabilita e il monastero del Santo riceve importanti donazioni. Le similitudini tante, anche se vi son differenze in alcuni dei nomi; forse perché la narrazione di Caradoc era ormai entrata nelle versioni narrative orali dei bardi? ed non si può escludere comunque una comune derivazione del testo di Caradoc nella “Vita di san Gildas” e del soggetto del bassorilievo da un racconto orale allora molto popolare in Europa.
Nel’ opera “Vita Gildae”, Artù non è qualificato come re, ma come “tyrannus”, parola che indica un capo militare, (stesso titolo che troviamo nelle fonti antiche per re Artos di Messapia). La “Vita Gildae” è sicuramente anteriore alla “Historìa Regum Britanniae” di Goffredo di Monmouth, nella quale Artù comincia a comparire come re.
Osserviamo come però la rappresentazione in quell’archivolto del Duomo di Modena non ha nulla di evidentemente misterioso e simbolico come nel caso del Rex Arturus che sarà pochi decenni dopo raffigurato dai sapienti idruntini nel mosaico pavimentale, come mostra innanzitutto l’ enigmatica scena di Artù a cavallo del caprone (o capra) con la lince.
Pare che le romanze arturiane continentali fossero popolari già almeno nel 1050, epoca in cui visse un nobile di Normandia di nome Artù, a dimostrazione della fama del nome.
Goffredo di Monmouth era gallese, e contemporaneamente a lui le prime opere in gallese furono messe per iscritto, fissando così tradizioni orali raccontate dai bardi dei secoli precedenti, per cui non è facile dire quanto Goffredo sia stato ispirato da loro che in tal caso sarebbe stata una fucina di rielaborazione ed arricchimento del mito nel tempo o viceversa.
Fatto sta che elementi chiave come il Santo Graal e la Tavola Rotonda mancano ancora in Goffredo e dunque nelle fonti scritte in Britannia e vanno rintracciate nelle fonti continentali.
Nella sua prefazione all’ opera dello scrittore Sir Thomas Malory “La Morte d’Arthur”, l’ editore William Caxton, era il 1485, osserva che Artù “è più noto oltremare [e] la esistono più libri sulle sue gesta nobili, di quanto non accada in Inghilterra … in olandese, italiano, spagnolo e greco, nonché in francese”.
Persino già in epoca medioevale divenne una questione di mistero la storicità di Re Artù, nelle stesse terre di cui si favellava avesse avuto il suo regno in epoca altomedioevale.
Non a caso “un mistero per il mondo, una tomba per Artù” recitava un verso di un poema gallese medioevale che descriveva i luoghi di sepoltura dei grandi guerrieri del passato della Britannia. La formulazione enigmatica è stata tradotta in vari modi, come “impensabile una tomba per Artù”, oppure “pensiero poco saggio una tomba per Artù” (Anoeth bid bet y Arthur). Il significato è però eloquente: nessuno conosceva il luogo, sempreché sia esistito, in cui fu sepolto il famoso re Artù!
E così quando William Caxton il pioniere della stampa inglese pubblicò nel 1485 l’opera dello scrittore Sir Thomas Malory “La Morte d’Arthur”, fu sollecitato ad elencare nella sua prefazione le prove dell’ esistenza di Artù: vari racconti, fonti precedenti e reliquie varie, tutto materiale di scarso valore archeologico oggi in termini di prova di storicità! Poi tante reliquie erano state create nel tempo, dei falsi per ravvivare l’ ethos nel codice cavalleresco, anche operazioni queste ordite a tal fine e per ragioni di captazione di prestigio da parte di sovrani. (Vedi: di James Peter e Thorpe Nick “Il libro degli antichi misteri” edito da Armenia nella collana Miti senza tempo, 2005).
Lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, (1547 – 1616), fa dire a don Chisciotte nel suo famoso romanzo “Don Chisciotte della Mancia”: “Non hanno letto lor signori – rispose don Chisciotte – gli annali e le storie d’Inghilterra in cui sono trattate le gesta del re Arturo, che noi comunemente nel nostro volgare castigliano chiamiamo il re Artù, intorno al quale esiste in tutto il regno di Gran Bretagna l’antica leggenda che quel re non sia morto, ma che per virtù di incantesimo si sia convertito in corvo, e che col volgere degli anni dovrà ritornare a regnare, riconquistando il suo regno e lo scettro? Tant’è vero che da quel tempo ad oggi non si troverà un solo inglese che abbia ucciso mai un corvo.”
A questa leggenda forse si collega la profezia secondo cui la monarchia sarà salda in Inghilterra finché i corvi vivranno sulla Torre di Londra, motivo per cui lì son regolarmente nutriti, protetti e accuditi ancora oggi affinché non abbandonino quel luogo.
Nella Torre di Londra fu anche rinchiuso Arturo Plantageneto figlio illegittimo di re Edoardo IV d’Inghilterra, sospettato di tradimento. Morì nel 1542, e fu sepolto nella medesima Torre. Ciò anche mostra com e il nome Arturo ebbe grande fortuna tra i nobili inglesi a seguito della affermazione di successo della fiaba di re Artù.
Nella grande enciclopedia universale musiva di Otranto non poteva mancare certo la raffigurazione di un grosso corvo, quello che nella leggenda biblica è legato all’Arca di Noè, ed effigiato nel mosaico nei pressi dell’ arca nella navata centrale.
Lo studioso Robert Graves deduce dai miti antichi greci, come da quello di Re Artù, che il corvo era un animale nel quale si credeva andasse l’ anima del re sacro dopo il suo sacrificio.
Non dimentichiamo in queste considerazioni quanto il Salento fu collegato per tutto il medioevo al resto d’ Europa in seno a quel vero e proprio nastro trasportatore culturale rappresentato dai flussi di pellegrini diretti in Terra Santa, tanto che proprio da Otranto si prevedeva il passaggio, in quella che fu una delle più importanti guide per pellegrini del medioevo, che dava informazioni utili per il viaggio. Si tratta dell’ “Itinerarium a Burdigala Jerusalem usque et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque”, usualmente noto come “Itinerarium Burdigalense” o “Itinerarium Hierosolymitanus”. E’ il più antico racconto conosciuto di un itinerario pellegrinale cristiano e fu scritto nel 333-334 d.C. da un anonimo pellegrino durante il viaggio da Burdigala, l’attuale città francese di Bordeaux, fino a Gerusalemme, dov’era diretto per venerare il Santo Sepolcro.
Nelle fonti medioevali all’Artù bretone si attribuiscono i titoli di “dux bellorum” (in latino), comandante di eserciti nelle guerre, vittorioso in numerose battaglie, e il titolo di “tiranno”, che è un medesimo titolo che troviamo nelle fonti greche che parlavano proprio dell’ Artas messapico!
Anche in ambiente normanno, (e più in generale qui intendiamo quei regni che dalle conquiste normanne presero sviluppo), tale nucleo di leggende non mancò di essere inserito in maniera ancor più forte in una ideologia cavalleresca, cui ben si prestava il concetto ad esempio di unione collaborativa nei buoni valori dei cavalieri della Tavola Rotonda.
La materia arturiana divenne così uno strumento importante, una macchina di propaganda per la diffusione e affermazione di un complesso di valori importanti per affrontare le sfide che l’impegno delle Crociate implicava contro le forze avverse orientate a distruggere la civiltà romano-cristiana. E non è un caso che nobili crociati, come Filippo I di Fiandra, commissionino e indirizzino da mecenati ai loro poeti di corte specifici romanzi nella materia arturiana. Del resto anche già il grande poema epico di Virgilio, l’Eneide, era la celebrazione e esaltazione delle origini di Roma, ma con correlata finalità politica legata ai tempi e ai mecenati in cui e per cui l’opera venne realizzata.
La fama assunta dalle leggende su Artù in Inghilterra, portò i sovrani medioevali del luogo a operare per far associare la loro figura a quella del leggendario Re, anche al fine di smorzare la possibilità che il favoloso Re Artù divenisse un simbolo per un riscatto identitario e per scacciare i nuovi conquistatori, che dai normanni in poi quei sovrani potevano esser considerati dal popolo.
Se si aggiunge a tutto questo l’importanza e ricchezza economica che nel medioevo derivava alle chiese dalla presenza in esse di importanti reliquie, ricchezze e potere che spingevano ad oggi ben note falsificazioni di reliquie, (come anche per altri episodi erano già noti i monaci dell’ abbazia che citeremo qui di seguito), comprendiamo quel mix in cui si colloca l’operazione architettata dal re Enrico II d’Inghilterra insieme ai monaci dell’ Abbazia di Glastonbury nell’Inghilterra sud-occidentale, quando sulla presunta rivelazione di un segreto fatta ad Enrico da parte di un vecchio bardo inglese dotto di storia sulla ubicazione nei pressi dell’Abbazia della tomba di Artù, combinata con una visione in sogno del luogo esatto in cui scavare avuta dai monaci, si simulò il ritrovamento della tomba di Artù e di sua moglie Ginevra, insieme ai loro corpi, corredi funerari vari, e epigrafi indicanti l’identità dei corpi e che identificava quel luogo con la mitica Avalon dimora finale di Artù. Con tutti gli onori i loro resti furono traslati nella chiesa in una gran tomba di marmo. Questi fatti si collocano negli anni precedenti alla partenza del figlio di Enrico, Riccardo Cuor di Leone, per combattere nella Terza Crociata, quando, nel marzo 1191, Riccardo regalò al re normanno Tancredi di Sicilia una spada che dichiarò essere la vera Excalibur, ritrovata nell’Abbazia di Glastonbury.
Robert Graves ricorda che la discesa agli inferi di Re Artù, di cui si narra nel ciclo bretone, lo associao agli eroi di parecchie mitologie che disceso agli inferi, come appunto Teseo, Eracle, Dioniso e Orfeo, e in Italia Enea.
Re Edoardo I d’Inghilterra, nel 1278, ordinò che la tomba di marmo fosse spostata in posizione di maggiore rilievo davanti all’ l’atare maggiore. Come avvenne con una grande cerimonia, a cui parteciparono anche re Edoardo e la sua regina. Nel 1184, infine chiesa e edifico monastico furono mandati in fumo da un incendio.
La tomba di re Artù non si trova in nessun luogo, e ciò rafforzava anche il mito che lo voleva ferito esser stato condotto da sua sorella Morgana nella misteriosa isola di Avalon dove continuava a vivere, da qui le antiche ballate che favoleggiano che sarebbe tornato nel momento del bisogno per salvare la terra del suo regno.
Il teologo e filosofo francese Alano di Lilla (in altino Alanus ab Insulis, che morì nel 1202) ricorda come ai tempi suoi quella credenza fosse ancora così viva e comune in Armorica (una regione che comprendeva la penisola della Bretagna nel nord della Francia) che il contraddirla avrebbe portato pericolo di lapidazione.
Queste credenze nel ritorno di Artù in territori bretoni continentali e in quelli britannici insulari, portarono le genti di altre aree allo sviluppo di locuzioni proverbiali notissime, come “Arturum expectare”, per indicar quando si aspetta ciò che non può né avvenire, o anche come “speranza brettone” sinonimo di speranza vana ed assurda.
A questa vana speranza si trovano frequenti accenni nei trovatori di Provenza, ma anche in Italia, come si trova testimonianza, solo ad esempio, nel poema latino “De divertiste fortunae et philosophiae consolazione”, del poeta Arrigo da Settimello, composto circa nel 1192-1193.
Con il simulato ritrovamento della tomba i sovrani inglesi tentarono di fermare queste pericolose rivoluzionare idee popolari del ritorno di Artù contro gli invasori, che allora erano considerabili quei nuovi sovrani stessi agli occhi del popolo. Artù era così dimostrato morto con il simulato ritrovamento del suo corpo tombato, e i sovrani fecero di più si identificavano ora con lui e ne favorirono anche la diffusione del mito tra la gente, foraggiando poeti e cantastorie. Una forma di indiretta propaganda regale attraverso l’ arte!
“Loegria” il regno del fiabesco Re Artù, “Locria” il regno di Re Artas?
“Loegria” (o anche varianti “Logris”, “Logres”) è nel ciclo medioevale arturiano il nome della terra di Artù, il nome del suo regno. Anche questo toponimo trova parallelismi nella chiave di lettura messapica con cui stiamo sottoponendo a screening le leggende arturiane?
Ebbene sì. Partiamo da quanto riferisce il geografo medioevale Guidone, negli inizi del XII sec. d.C., (lo stesso secolo in cui fu realizzato da Pantaleone il mosaico della Cattedrale idruntina), nella sua opera in latino, intitolata “Geografia”; egli scrive: “la regione salentina che anticamente fu chiamata Locria”!
Da fonti più antiche greco-latine si legge che nella costituzione definitiva del popolo dei salentini si ebbe anche la partecipazione di genti Locresi, che prendevano certamente il nome da quello della antica regione ubicata nella Grecia centrale, da cui provennero, la Locride (“Locris”), attualmente inglobata fra le province (“nomoi”) di Beozia e Ftiotide. Anticamente si divideva in due aree la Locride Opuntia a oriente, che si affacciava sul golfo dell’Eubea e che andava dalle Termopili a Larymna, e la parte occidentale, detta Locride Ozolia, che si allungava sul golfo di Corinto fino a Naupatto.
Così leggiamo dallo scrittore Verrio Flacco (I sec. a.C. – I sec. d. C.), nella sua opera in latino intitolata “Sul significato delle parole”: “i Salentini traevano il nome dal mare [salum] ed erano Cretesi ed Illiri, i quali in mare avevano fatto amicizia e alleanza coi Locresi, di quella regione d’Italia, che …”. Maggiori dati gli apprendiamo dallo scrittore latino Varrone (116-27 a. C.), che, nella sua opera “Antiquitates Rerum Humanarum”, scrive: “si dice che la nazione salentina si era formata a partire da tre luoghi, Creta, l’ illirico e l’Italia. Idomeneo – (detto Lyctio, dal nome della sua città cretese Lyctus, è una figura della mitologia greca, figlio di Deucalione e nipote di Minosse; fu re di Creta. Nota dello scrivente n.d.s.) – esule dalla sua terra per delle sventurate vicissitudini, dopo la guerra di Troia, con un grosso suo esercito, cui si aggiunse un altro esercito di illiri, in mare si unì, per la somiglianza delle loro condizioni e progetti, ad un folto gruppo di profughi locresi, con cui strinse patti di amicizia e si portò a Locri (Locros). Essendo stata abbandonata la città per timore di lui, occupò la città [urbs] e fondò diversi centri [oppida] tra i quali Uria e la famosissima Castrum Minervae. Divise l’ esercito in tre parti e in dodici popoli. Furono chiamati Salentini, poiché avevano fatto amicizia in mare [in salo].”
(Per approfondimento sulle città in terra iapigia di Uria e Yria rimando a questo mio articolo post).
Virgilio nell’ “Eneide” sembra riferirsi alla terra salentina quando scrive “qui i Locresi di Naricia posero le mura”, probabilmente nel significato di: avevano costruito una loro città.
Nell’ “Eneide” leggiamo più estesamente: “Queste terre d’Italia e questa riva/ vèr noi vòlta e vicina ai liti nostri,/è tutta da’ nimici e da’ malvagi/Greci abitata e cólta: e però lunge/fuggi da loro. I Locri di Narizia/qui si posaro; e qui ne’ Salentini/i suoi Cretesi Idomeneo condusse;/qui Filottete il melibeo campione/la piccioletta sua Petilia eresse.”
Opure in un’altra traduzione: “….Qui i Locresi di Naricia posero le mura/e Idomeneo con armi cretesi occupò i campi Salentini…”
Riportiamo anche il testo latino originario: “…Hic et Narycii posuerunt moenia Locri/et Sallentinos obsedit milite campos/Lyctius Idomeneus…” (Virgilio I° sec. a.C: Aenaeis, libro III vv. 399-401).
Uria, (nome interessante che ha la stessa radice di “urbs” che vuol dire “città” in latino – per antonomasia l’ Urbe fu Roma), corrisponde probabilmente alla salentina odierna Oria.
Da quelle fonti par dunque di capire che vi fosse nel Salento già una città chiamata Locri (“Locros”), da non confondere con la colonia magnogreca di Locri Epizefiri nell’odierna Calabria. Forse, non sbaglia, allora, lo scoliasta che scrive in greco negli “Scoli a Dionisio Periegeta” (di epoca bizantina, ma contenenti materiali più antichi): “scoglio Iapigio. Si riferisce allo scoglio di Leuca; esso è infatti nella regione Iapigia. Tale scoglio si trova vicino Locri [Locron, in greco].”
In ogni caso, al di là della verità originaria, resta il fatto per noi comunque importante che in epoca medioevale circolasse il dato, errato o meno, che il Salento in antichità si fosse chiamato anche “Locria”! Ma il dato par comunque fondato anche da studi numismatici sul ritrovamento in Salento di rare monete, coniate in terra salentina, che avevano legenda “ORRA LOCRON”, dove “Orra” è il nome proprio della città messapica di Oria. (Vedi: “La Corografia fisica e storica della provincia di Terra d’ Otranto” di Giacomo Arditi, stampato a Lecce nel 1879-1885, nel paragrafo dedicato ad Oria, dove nelle note rimanda all’opera dello studioso Luigi Maggiuli, “Monografia numismatica della provincia di Terra d’Otranto”, edito in Lecce nel 1870, e ci informa delle monete trovate a Oria di cui si occupò lo studioso locale Gasparo Papatodero, sacerdote della Cattedrale di Oria, nella sua opera edita nel 1775, e intitolata “Della Fortuna di Oria …”).
Della presenza di una città chiamata “Orra Locrensis” in Salento indicata dalle monete con la leggenda “Orra Locron”, e attribuibili alla città di Oria, leggiamo anche in “Gli Studi Storici in Terra d’Otranto” a cura di Luigi G. De Simone (1835-1902), stampato a Firenze nel 1888, Tipografia Galileiana di M. Cellini E.C.
Dal testo dello studioso Ettore Pais, “Il Sud prima di Roma. (Storia della Sicilia e della Magna Grecia)”, tomo secondo, Ediz. Capone, Capone Editore, Lecce – 2008, riportiamo questo per noi interessantissimo passo: “Il Pauli [Carl Eugen Pauli (1834 – 1901) è stato un linguista tedesco] infatti, il quale con molta diligenza ha testé studiati i rapporti tra gli alfabeti ellenici più antichi e quelli usati dalle popolazioni d’Italia abitatrici delle coste dell’Adriatico, è venuto al risultato che, (…), quello de’ Messapi non deriva, come con il Kirchhoff si soleva ammettere, dall’alfabeto tarantino bensì dal locrese. Ed è oltremodo notevole che il Pauli sia venuto a queste conclusioni indipendentemente dalla tradizione letteraria, che egli non studia e non riferisce, relativa alle origini locresi dei primi abitatori della penisola sallentina.”
Dalla presenza di locresi già da tempi precedenti alle vicende che coinvolgevano Idomeneo, intersecando tutte le fonti, possiamo dire che tutto il territorio, che poi verrà chiamato Salento, aveva nome Locria, o solo magari una zona controllata da una antica città chiamati Locri (Locron) dal nome delle genti che l’avevano fondata e vi abitavano. In quell’area sorse poi Uria (Oria), dopo l’arrivo di Idomeneo, che per questo venne chiamata anche talvolta sulle sue monete “Orra Locron”. Il legame con i greci Locresi dei territori del sud della Puglia precede dunque la stessa fondazione della colonia di Locri Epizefiri nell’odierna Calabria, datata nel VII secolo a.C., sempre fondata ad opera dell’arrivo di greci Locresi.
Circostanze tutte queste che combacerebbero con le tesi di quanti, (e tra questi Gasparo Papatodero nella sua opera intitolata “Della Fortuna di Oria (…)”, del 1775), hanno individuato in Oria, da vari studi compiuti, la sede principale di Re Artas, dove le fonti antiche raccontavano della presenza, probabilmente sulla sua rocca, di un “basileion” un palazzo reale di un dinasta messapico (“dinastes”)!
Il geografo greco Strabone (64/65 a.C. – post 23 d.C.), nella sua opera in greco intitola “Geografia”, ricorda infatti che ai suoi tempi ancora, nella città messapica di Ouria [l’attuale Oria], ubicata al centro dell’istmo tra Brindisi e Taranto, si poteva osservare ancora la reggia [“basileion”, palazzo del basileo, del re], di un certo dinasta. Strabone non ne dà il nome, ma è possibile ipotizzare che si trattasse proprio di Artas, il famoso sovrano messapico, “dinastes”, come lo definì Tucidide. La reggia doveva ergersi con tutta probabilità, in posizione strategica anche di vedetta e dominanza, sulla rocca della città di Oria.
L’archeologia sta confermando questo dato e vi ha ritrovato sulla rocca di Oria preziosi raffinati grandi mosaici pavimentali policromatici con raffigurati leoni e serpenti risalenti al V-IV sec. a.C. Era forse proprio il palazzo di Artas!?

Forse uno dei più antichi mosaici d’Italia.
Riporto qui copia/incolla questo articolo in merito alla scoperta del CNR (Centro Nazionale Ricerche)
———–
Eccezionale scoperta archeologica a Oria
01/10/2012
Nel corso dei lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti dell’Episcopio di Oria, un centro messapico ubicato tra Brindisi e Taranto, la Soprintendenza archeologica di Taranto ha portato alla luce significativi resti di un imponente edificio di epoca alto-ellenistica. I risultati sono stati presentati di recente. Lo studio ha visto impegnato l’Ibam-Cnr
Nel 2011, nel corso dei lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti dell’Episcopio di Oria, un centro messapico ubicato tra Brindisi e Taranto, la Soprintendenza Archeologica di Taranto ha portato alla luce significativi resti di un imponente edificio di epoca alto-ellenistica, tra cui quelli di un mosaico policromo a ciottoli raffigurante l’assalto di un leone a un cervide, che non trova confronti in nessun centro antico dell’Italia meridionale o della Sicilia (…)
Nel primo ellenismo nessun’altra testimonianza di orizzonte ‘coloniale’ raggiunge la finezza e l’alto livello dei mosaici a ciottoli attestati in Grecia e in Epiro, né di quelli ritrovati a Pella, capitale del regno macedone. Il mosaico di Oria, realizzato con materiali d’importazione, si inserisce, invece, pienamente in quella tradizione figurativa, trovando significativi confronti, anche per la scelta del tema iconografico, nei mosaici a ciottoli policromi di Eretria, Pella, Atene e Corinto. Sulla base dei confronti tecnico-stilistici e iconografici, è stato possibile avanzare l’ipotesi di una datazione nell’ultimo trentennio del IV secolo a.C. e di una sua realizzazione da parte di artisti di formazione greca. L’insieme dei rinvenimenti nell’area acropolica permette di ipotizzare che la realizzazione dell’ambiente mosaicato sia da inquadrare in un intervento edilizio di portata notevole, con ricorso anche a maestranze greche, databile nell’ultimo trentennio del IV sec. a.C. Tale datazione appare congruente con quanto sappiamo della vicenda storica dei rapporti tra i Messapi e i Greci, che conosce un’importante svolta positiva con il trattato di pace e amicizia stipulato poco prima del 330 a.C., al tempo della spedizione in Italia di Alessandro il Molosso, re dell’Epiro e zio di Alessandro Magno. A tale evento fanno seguito diversi decenni di prosperità e di stretti rapporti economici e culturali, ma anche di cooperazione politica dei Messapi con Taranto e i ‘Condottieri’ greci chiamati dalla città a difesa dalle aggressioni romane, Cleonimo prima e Pirro poi.
L’ intervento edilizio testimoniato dai rinvenimenti oritani, con la costruzione nell’area acropolica di Oria, di un edificio monumentale comprendente ambienti dotati di raffinati rivestimenti parietali e pavimentazioni musive, rinvia all’esistenza, nel centro messapico, di istanze socio-politiche e socio-economiche di livello elevato, dotate di rapporti e legami forti con omologhi ambienti greci e in grado di attivarli per la sua realizzazione.
Un edificio che si può proporre, seppur con cautela, di identificare come il basìleion di cui serba memoria il Geografo di età augustea Strabone, quando, nella sua descrizione della Messapia, fa menzione di Oria aggiungendo che in essa “ancora oggi si mostra la reggia (basileion) di uno dei dinasti” .
———–
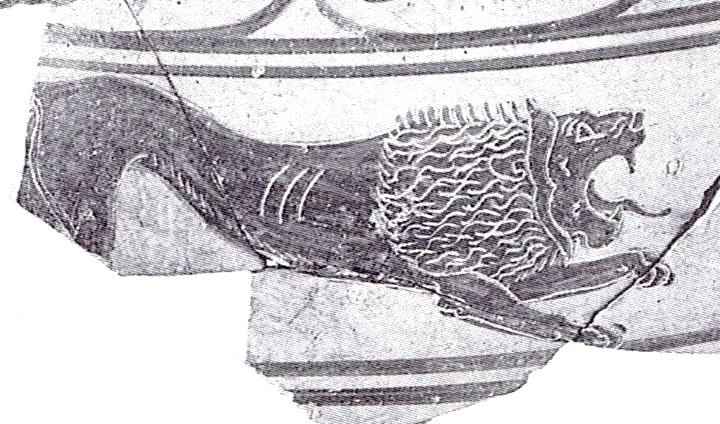
(Vedi testo “Archeologia dei Messapi” a cura di Francesco d’Andria, Edipuglia, Bari 1990).
L’arte del mosaico è dunque antichissima in terra Salentina, dalla reggia forse dello stesso Re Artos ad Oria, al mosaico pavimentale idruntino di Re Arturo. Non possiamo escludere che ancora nel medioevo si mostrassero in ruderi di regge messapiche, o altri edifici messapici o romani, mosaici, o anche dipinti su pareti, con cicli figurativi relativi ai miti e cerimonie con Artas-Dioniso che qui stiamo ipotizzando, e che potevano contribuire all’ispirazione anche e soprattutto di quelle parti del mosaico idruntino che qui stiamo analizzando.
E se il regno in cui era ubicata Oria era chiamato “Locria”, e se Artas è Artù, non meraviglierebbe più che il regno di Re Artù sia poi stato chiamato “Loegria”!
E questo eviterebbe quelle forzature storico-toponomastiche in terra di Britannia a cui sin ad oggi si è ricorso per collocare quel regno arturiano chiamato “Loegria” (variante “Logris”) di Re Artù in Britannia.
Ma verrebbe da dire a questo punto per quanto riportiamo nelle righe successive: ecco la prova provata !
E’ interessantissimo, illuminante, far notare che Goffredo di Monmouth nella sua pseudostoria intitolata “Historia Regum Britanniae” (“Storia del Regno di Britannia”), sostiene che quel reame arturiano prese quel suo nome “Loegria” da un leggendario re chiamato “Locrinus”, Locrino, che ere il figlio più anziano di Bruto di Troia.
Quest’altro “misterioso” personaggio, Bruto di Troia per l’Inghilterra non è menzionato in nessun testo classico o fonte storica ed è considerato ormai da tutti gli studiosi pura invenzione. E’ descritto come discendente dall’eroe troiano Enea e presentato come primo re e fondatore del regno della Britannia; questa fantasiosa figura di Bruto assolutamente pseudo-storica apparve per la prima volta nell’opera attribuita a Nennio del IX sec. d.C. intitolata “Historia Britonum”(“La Stroria dei Britanni”), e dopo fu ripresa nel XII sec. d.C. da Goffredo di Monmouth nella sua opera incentrata sullo stesso tema.
Si pensi che Artù, forse persino praticamente per la prima volta, viene citato proprio nell’opera di Nennio, e poi quindi in quella di Goffredo, questo qui lo sottolineamo per far capire in quale contesto pseudo-storico sia collocata la sua figura già nelle prime opere che lo menzionano con “precisione”.
Erano operazioni politico-letterarie per tentar di dar lustro ai luoghi e loro genti; un’ epica inventata prendendo a piene mani dal mondo greco e latino, e quindi dall’intermedia civiltà messapica cerniera geografica e culturale tra Grecia e Roma che aveva influenzato e lasciato tracce sia nell’uno che nell’altro mondo culturale. Un modello che tentava di calcare le orme del grande poeta latino Virgilio autore dell’ “Eneide”, opus magnum, incentrata sull’eroe Troiano Enea a celebrazione delle origini di Roma.
Enea è legato da tradizione antica al Salento: narrano le fonti antiche che scappato con il padre Anchise da Troia data alle fiamme dai greci, raggiunse l’Italia diretto nel Lazio, sbarcando per la prima volta su terra italica, dopo aver attraversato il Canale d’Otranto, ai piedi della rocca su cui vi era l’ Athenaion, il famosissimo santuario della Dea Atena, (la Dea Minerva per i romani). Egli era un semi-dio poiché figlio della dea della bellezza Afrodite (Venere per i romani), per questo l’insenatura in cui sbarcò fu chiamata Porto di Afrodite (o Porto di Venere). Con sé Enea portava il sacro Palladio di Troia che aveva recuperato prima del viaggio: si trattava di una statuetta in legno della vergine giovinetta armata Pallade Atena, amuleto che dava invincibilità alla città che lo custodiva in essa. E su quel Palladio fu eretta poi Roma dalla invincibile forza. Virgilio ne narra dello sbarco in Salento di Enea nella sua “Eneide”.
Virgilio fu un faro guida per tutti gli scrittori del medioevo, si pensi solo ad esempio alla metafora del poeta Dante Alighieri che fa proprio di Virgilio la sua guida nel suo “Inferno”.
Bruto invece è un nome ricorrente nella storia romana, anche perché è il nome proprio del famoso fondatore della Repubblica a Roma, Lucius Iunius Brutus, che secondo la tradizione romana fu anche uno dei primi due consoli. Da qui l’invenzione medioevale di un Bruto di Troia come fondatore di un fantasioso regno di Inghilterra, e suo primo re, già in epoca antica, figura ibrida che fonde i due eroi Enea di Troia che è alle origini di Roma e Bruto che è il fondatore della repubblica a Roma.
E’ evidente la mistura cui Nennio e poi Goffredo in diretta continuità attingono per le loro fantasiose narrazioni assolutamente pseudo-storiche, in cui poi mescolano leggende popolari della tradizione locale per rendere il prodotto finale più digeribile e riconoscibile dalla gente dei luoghi.
Anche quel nome Nennio di quel nebuloso scrittore di cui si sa pochissimo, vien da porsi la domanda, a questo punto, se non sia un soprannome, uno pseudonimo che echeggiava il grande Quinto Ennio (239 a.C.-169 a.C.), l’eccelso poeta latino nato in Messapia, messapo di origine e di grande conoscenza della cultura semi-perduta del Salento arcaico. Anche perché Ennio fu autore del primo poema nazionale del popolo romano, gli “Annales”, prima che fosse composta l’ “Eneide” (29-19 a.C.) di Virgilio. Ennio narrava la storia di Roma anno per anno, come spiega il suo titolo, a partire dalle sue origini! Dai frammenti rimastici si può comprendere come anche Ennio fosse un pitagorico o comunque edotto nella filosofia di Pitagora. Nel proemio degli Annales posto all’inizio della sua opera Ennio racconta che Omero stesso gli era apparso in sogno per rivelargli di essersi reincarnato in lui dopo avergli esposto la dottrina pitagorica della metempsicosi, ovvero della transmigrazione (reincarnazione) delle anime.
Forse anche nella mani di Nennio, che vuole scrivere come Ennio di origini e di storia nazionale, ma di una nazione che non ha grandi fonti di storia scritta, erano giunte anche proprio opere o maggiori passi di opere di Ennio, oggi perdute? Dove magari anche egli parlava della sua Messapia e del grande re “Artos” di Messapia, (latinizzato forse proprio in Arturus, dato che Ennio scrisse in latino le sue opere)!? Ennio era solito far riferimenti alla sua cultura. E/o nelle loro mani di Nennio era pervenuta l’opera di Polemone sul messapico re “Artos”, (come in greco sovente si riportava il messapico nome “Artas” di quel grande re)?
Entrambi animati dal glorificare le origini, famosa la frase di Ennio “moribus antiquis res stat romana virisque”, tradotta “lo Stato romano si fonda sugli antichi costumi e sui grandi uomini”. Nennio, forse, ispirandosi al grande vate latino, che il poeta latino Orazio definì “Ennius pater”, tanta la sua importanza per lo sviluppo della letteratura latina, coniò per sé lo pseudo-nimo Neo Ennio, in latino “Naeus Ennius”, contratto appunto in Nennio!
Nennio visse nel IX secolo d.C., l’Europa continentale aveva avuto tra VIII e IX secolo un grande difensore, Carlo Magno (742 – 814), che aveva fortemente combattuto proprio contro i Sassoni e le cui gesta come quelle dei suoi cavalieri, i paladini, cominciavano a divenire la base del ciclo carolignio, l’esigenza di dotare anche la Britannia di una figura eroica in chiave antisassone era crescente, possiamo immaginare, da qui una ulteriore molla alla finzione letteraria?
Il nome inventato di Locrinus, pare proprio inserirsi in questa logica di invenzione: se il regno di Artas era chiamato Locria, che diventa la “Loegria” di cui scrive Goffreddo come nome del regno di Artù, per spiegare l’origine di quel nome si inventa allora un re Locrinus che si colloca nel passato. Ma questo passaggio in ogni caso ha il pregio di darci con il nome del suo inventato fondatore Locrinus la vera radice del nome “Loegria”, “Locria” dunque! Ergo il Salento!
La Locria messapica diventa così nella fantasia riciclante di quegli scrittori britannici, come Loegria, una provincia contenente gran parte dell’ Inghilterra esclusa la Cornovaglia.
Negli studi arturiani ad oggi tutto questo materiale qui esposto è stato del tutto ignorato mancando la chiave di lettura messapica dell’origine di Artù che invece qui ho esposto. E così dove mancavano le risposte si son cercati termini nei dialetti di quelle terre, nel Galles, in Irlanda, in Bretagna, Inghilterra, Scozia, e dintorni, da cui far derivare quei nomi, non tenendo conto poi sempre neppure del fatto che gli stessi romanzi arturiani, con la loro straordinaria fama e carisma patriottico, (che è ciò che perseguirono Ennio e Goffredo in primis con l’ “operazione arturiana” di invenzione effettuata), hanno influenzato tradizioni, lingue e toponomastica; un’ influenza che, grazie anche ai temi cavallereschi toccati, si è poi estesa, ben più di quanto certamente mai potevano pensare i loro ideatori, a tutta la cultura europea.
E vien da chiedersi se nell’operazione di riciclaggio non sfruttarono il fatto, di cui si resero conto, che i testi su Artos messapico di cui erano venuti in possesso erano poco diffusi, se non rarissimi, e dunque poco noti, tanto da poter compiere indisturbati l’ “operazione arturiana” che salvo così dal’ oblio elementi della storia di Artos, è pur vero, ma al prezzo di strapparne l’identità cronologica etnica e geografica legata al Salento greco-messapico!
Il fascino e la fama dell’Artù letterario, lanciato sulla scena nel medioevo, furono tali che gli esegeti se ne stanno rendendo conto sempre più, anche laddove nella letteratura e storiografia medioevale del nord Europa si son ritrovano sporadici nebulosi riferimenti apparentemente più antichi a Nennio che accennano ad un Artù, analisi più attente vi hanno evidenziato il dubbio dell’inserimento forzato successivo in copie successive dei manoscritti originali. Altre volte i personaggi chiamati con nomi riconducibili a Artù, o sue varianti, (emersi anche nell’epigrafia in quelle terre), non avevano invece nessun attributo del Re Artù, e potevano ben essere effetto della presenza al seguito dei romani del nome Artorius, come già abbiam trattato.
Nel testo ottocentesco intitolato “Le monete delle antiche famiglie di Roma fino all’ imperatore Augusto, inclusivamente co’ suoi zecchieri dette comunemente consolari disposte per ordine alfabetico” di Giudice Gennaro Riccio (edito 1 gennaio 1843 da E.Cartiere del Fibreno- Editore), riportiamo qui di un conio repertato tra le monete di Oria (ORRA) nel Salento (antica Calabria), la sua descrizione. Essa aveva sul dritto la “Testa di Pallade”, e sul rovescio, come simboli presenti e legende: “Grappolo [d’uva], sopra [la scritta] ORRA, e sotto ΛΟΚΡΩΝ [“locron” traslitterando dall’alfabeto greco]”. In parentesi quadre parti aggiunte a nota dallo scrivente.

Molto diffusa nella monete coniate ad Oria è la presenza del grappolo d’uva, simbolo dionisiaco, che mostra l’ubertosità dei campi circostanti, ancor oggi ricchissimi di vigneti, e che ci richiama inevitabilmente ai locali antichi culti dionisiaci in Messapia. Tutto il sud Italia è terra di tante antiche pregiate cultivar di vitigni e uve da tavola. Tra gli antichi vitigni del Salento, e della Puglia tutta, ricordiamo qui ad esempio il Primitivo, il Negroamaro, la Malvasia nera, questi primi tre molto tipici del Salento, il Nero di Troia, ecc. ecc.
E’ interessante rimarcare qui, alla luce dei discorsi intrapresi l’antico legame viscerale che i locresi stabilivano con la pianta della vite, che potrebbe spiegare anche perché poi in Salento i culti del vino assunsero, come ipotizziamo, un valore molto alto nella società e religione del luogo.
Pausania, scrittore viaggiatore e geografo greco del II secolo d.C., nella sua “Guida alla Grecia” (X, 38, 1), riportava la tradizione locrese secondo cui sempre la cagna di Oresteo partorì il ceppo da cui nacquero i primi tralci di vite; ma vi aggiunge che, secondo questa tradizione locrese dal ceppo fuoriuscirono, in forma di rami (ozoi), anche gli uomini della stirpe di Locresi, che per questo motivo presero il nome di Ozolii, nome etimologicamente associato alla parola “ozos”, “ramo”. “germoglio di vite”. Altri particolari li offre lo studioso dei miti Robert Graves, che scrive: “Oresteo re dei Locresi Ozoli; ai tempi di Oresteo una cagna bianca partorì un virgulto che Oresteo piantò e che crebbe diventando una vite”, (da “Miti Greci”,Robert Graves, Longanesi, 1983).
In Grecia ad Atene si svolgeva una festa dionisiaca chiamata le Oscoforie: si svolgevano nel mese di ottobre, all’epoca della vendemmia, la parola oscoporie deriva da proprio oschoi, i tranci d’uva, nel mese di pionepsione (corrispondeva alla prima parte dell’autunno, da metà ottobre a metà novembre).
Secondo la tradizione dei cicli arturiani tredici erano i seggi intorno alla tavola rotando di cui uno vuoto riservato a chi avrebbe trovato il Graal. E’ immaginabile un riferimento al numero dei dodici apostoli di Cristo più il posto del Signore, in un parallelismo tra la Tavola Rotonda e quella dell’ Ultima Cena dei Vangeli, ma è interessanti qui citare nella chiave del parallelismo che stiamo sviluppando l’affermazione del geografo greco antico Strabone nella sua opera in greco intitola “Geografia”, relativa all’esistenza nella regione messapica di tredici principali polis, probabilmente città-stato, che fornirebbe un numero coincidente con i tredici seggi attorno alla tavola rotonda, nell’ ipotesi che le origini del suo mito affondassero nell’antico Salento, secondo quanto anche scriveva l’ erudito mago Matteo Tafuri. O anche facendo riferimento alle dodici tribù in cui fu diviso il popolo salentino da Idomeneo, secondo Varrone, ecco i dodici posti occupati della Tavola Rotonda.
Dal V secolo a.C. in avanti, soprattutto a causa degli scontri con Taranto, i Messapi sembrano in effetti costituire un’associazione di città-stato in funzione difensiva, assimilabile alle simmachie greche che vanno viste come forme rudimentali di associazioni internazionali momentanee e intermittenti perché legavano gli aderenti essenzialmente per il breve periodo di una guerra. Questi centri abitati autonomi, anche se non particolarmente estesi, potrebbero corrispondere alle tredici città del territorio alle quali accenna Strabone.
Nell’ ipotesi di una genesi legata ad Artas della Tavola Rotonda, 13 seggi sarebbero stati tanti quanti necessari per ognuno dei rappresentati capi delle tredici città-stato messapiche, in accordo alla accarezzata idea, da diversi studiosi locali, che vorrebbe “Grande” il re Artas, anche per esser riuscito a creare tra tutte quelle città-stato di Messapia una lega unita e collaborativa.
Artas viene descritto, presentandolo come dinasta dei messapi, della Messapia, nelle fonti, non specificando una particolare città, e ciò può permetterci di immaginare una unità politica dei messapi, e delle loro principali città.
Forse tra i meriti di Artas, vi era anche quello di esser riuscito a consolidare e istituzionalizzare meglio questa unità tra le città di Messapia? La sua statura politica e strategica militare evidentemente gli permetteva di esercitare una influenza interna in tal senso, e la stima e ammirazione che riceveva dalla potente Atene, contribuiva anche di riflesso ad esaltarne ancor di più la grandezza interna agli occhi dei suoi sudditi.
E nelle fonti antiche Artas è chiamato tanto basileo quanto tiranno, il che ci fa pensare congiungesse in sé la natura di monarca legittimo, dinasta ereditario, quanto quella di uomo d’armi, e condottiero.
Quando parliamo di tavoli e di riunioni di persone attorno a un tavolo nel sud Italia, (“Italia” che vedremo era originariamente il nome del sud della penisola prima di essere esteso ad includere l’intera Pensiola italiana), il pensiero corre subito ai cosiddette “sissizi”, i pasti comuni consumati dai cittadini che costituivano una vera e propria usanza normata, e che la tradizione antica afferma esser stati istituiti nel sud Italia dal re Italo, (il padre di re Morgete), giunto dall’ Arcadia e che fu re degli Enotri. Da questo leggendario re il sud Italia trasse il nome Italia, poi esteso a tutta la penisola che si estende dalle Alpi sino allo Stretto di Messina e al Capo di Leuca. Già Tucidide e Aristotele scrissero che “quella regione fu chiamata Italia da Italo, re arcade”. Stessa teoria etimologica sul nome Italia ci fornisce Aristotele, che nella stessa sua opera intitolata “Politica” narra anche che re Italo, “re degli Enotri”, “per primo istituito i sissizi. Per questa ragione ancora oggi alcune delle popolazioni che discendono da lui praticano i sissizi e osservano alcune sue leggi”. Fu un re legislatore, della portata di Solone per Atene e di Licurgo per Sparta questi vissuti diversi secoli dopo Italo. Re Italo fece passare gli Enotri, racconta Aristotele, da nomadi a sedentari e promulgo nuove leggi. Anche Licurgo (che si ritiene vissuto tra IX secolo a.C. e VIII secolo a.C., e che fu secondo la tradizione di Sparta, il suo principale legislatore, istyitui i sissizi presso gli spartani. Varie leggende antiche su re Italo lo collocano 16 generazioni prima della Guerra di Troia, che presumibilmente oggi si ritiene avvenuta attorno al 1250 o al 1194 a.C.
I pasti comuni servivano per aumentare tra i cittadini il senso di comunità, la solidarietà e l’amicizia reciproca.
Non possiamo pertanto escludere che tale usanza fosse stata presente o comunque venisse riaffermata al tempo di re Artas proprio al fine di favorire una maggiore coalizzazione tra i messaggi in vista degli impegni contro Taranto e forse anche contro i pirati dei mari. Azioni di pirateria che forse non vedevano esranea la stessa rivala Taranto.
Da qui potrebbe aver tratto origine la tradizione della “Tavola Rotonda” nei cili arturiani medievale, o anche di quella differenza tra tavola rotonda da tavola quadra di cui scriveva il Tafuri in merito all’ originario re Artù di Terra d’Otranto, Artas quindi!
Il pensiero non può allora che correre a quella che è una tradizione ancora viva nei paesi salentini, in particolare in quelli di Giurdignano, Uggiano la Chiesa, Minervino di Lecce, e loro frazioni, nell’entroterra di Otranto, ovvero la tradizione delle “Taulate de San Giuseppe”, (le tavolate di San Giuseppe), dove il giorno in cui si festeggia questo santo cristiano, il 19 marzo alcune famiglie organizzano dei pasti sempre con un numero dispari di commensali appositamente scelti dal capofamiglia che impersonerà San Giuseppe, o counque da colui che la famiglia che offre questo pasto decide deve impersonare, nel ruolo cerimoniale, San Giuseppe. Ogni commensale rappresenta per l’ occasione un santo vicino alla sacra famiglia, e ne assume il nome.
Tutto è fortemente ritualizzato, dalle possibili pietanze che comprendono frutti tanto della terra quanto del mare, di origine vegetale come animale, cibi sia crudi che cotti, al numero delle pietanze che deve essere di tredici. Vengono preparate con cura dalle donne di casa. Immancabile il pane per l’occasione in forma di ciambella, (uno per ogni commensale che poi portera a casa con sé), decorato sovente con al centro un arancia: è un chiaro simbolo solare nella sua forma circolare. I pani son decorati con le simbologie dei rispettivi santi-commensali. Le porzioni pietanze sono uguali per tutti. A partire dal giorno prima solitamente la stanza della casa che da sulla strada è decorata a mo’ di santuario in un tripudio di firi e immagini sacre, e si mostrano le pietanze che il giorno dopo saranno consumate nel rituale pasto. Chi farà le veci di San Giuseppe ha un caratteristico bastone decorato e fiorito, che è nell’ iconografia cristiana il tipico bastone fiorito di San Giuseppe. Battendo con questo a terra il capotavola scandirà, l’inizio e la fine del pasto, e il passaggio da una pietanza all’altra. Tra queste immancabili infine i dolci di pastella fritta, tra i quali tipico del giono di San Giuseppe è nel Salento la cosiddetta “zeppola”, pasta fritta con sopra al centro della crema pasticcera.
Nell’ antica Roma il 17 marzo si celebravano le “Liberalia”, feste in onore delle divinità del vino e del grano. Per omaggiare le divinità del vino, il vino scorreva a fiumi, mentre per ingraziarsi le divinità del grano si friggevano frittelle di frumento. Le zeppole di S. Giuseppe son pertanto proprio le discendenti di quelle storiche frittelle.
Le somiglianze tra Re Artas e la figura di Re Artù emergente dai romanzi medioevali è impressionante. La tradizione medioevale narra infatti di un grande re dei Britanni che sconfigge i nemici Sassoni, unifica il proprio paese, fonda l’Ordine dei Cavalieri della Tavola Rotonda e costituisce un governo ideale!
Abbiamo qui percorso i legami tra Locresi e terra salentina, per spiegare quel termine Locria che in fonti antiche, e persino ancora medioevali si associava al Salento. Ma non occorre dimenticare che pur sempre, anche nel non volere seguire questa pista, i Locresi restano legati al sud Italia per la presenza della loro colonia magno-greca, Locri Epizefiri, nell’odierna Calabria, nel chersoneso occidentale del sud Italia, il chersoneso orientale essendo il Salento invece; (il termine chersoneso, dal greco, è sinonimo di penisola). Per cui sempre e comunque una Loegria (Logris) detto il nome del regno di un re Artù, che avrebbe tratto nome da un precedente re Locrino (figlio di un Bruto di Troia) di stirpe troiana (come di stirpe troiana Enea alle radici di Roma), ci rimanderebbe sempre e comunque nel sud Italia!
I parellelismi con il mito greco-latino sono tantissimi nella letteraria saga medioevale di Re Artù
Un altro nome che potrebbe ricollegarsi all’onomastica messapica con radice “MOR-“, è quello di Mordred, che compare già nella prima fonte più attendibile in cui parla del Re Artù ubicato in Britannia, quella di Nennio, che ci informa che Artù e Mordred morirono insieme in una battaglia.
In sviluppi successivi, in opere di tipo storico o romanzato, Mordred viene presentato come figlio concepito da Artù che si era unito in giovinezza con sua sorella Morgana. Il mago Merlino consigliere e mentore di Artù, consiglia Artù di far uccidere, eliminare tutti i bambini di sangue nobile nati nel giorno della festa di primavera. Chiara è la similitudine con la strage degli innocenti ordita da Erode Antipa di cui parlano i Vangeli, per tentare di uccidere il piccolo bambini Gesù. Ma anche in questa storia è riconoscibile l’archetipo dell’arcaico sacrificio dei fanciulli al posto del re sacro, affinché egli potesse continuare a regnare per più anni, ritardando così il suo sacrificio rituale secondo il pensiero e una pratica religiosa molto arcaica in Europa e nel Mediterraneo. (Vedi studi di Graves e Frazer sopra citati). Ma Mordred sfuggì all’eccidio e divenne Sir Mordred, che entrato tra i Cavalieri della Tavola Rotonda diffuse la zizzania nella corte e quando Artù fu lontano con il suo esercito per una spedizione militare tentò con una congiura di impossessarsi del trono e di sposare la moglie di Artù, che riuscì a fuggire nella Torre di Londra. Tornato Artù, saputo del tradimento, gli eserciti nemici si scontrarono e un combattimento all’ ultimo sangue vide affrontrarsi Artù e Mordred, che vide perire quest’ultimo.
Vi vediamo qui temi mitologici e psicologici quali quello del mito greco di Edipo, che il re padre tentò di far uccidere appena nato per una profezia che indicava nel bambino la futura rovina del padre. E’ la paura del re di perdere il suo regno in favore del figlio o comunque di un nuovo re più giovane. Ma Edipo per una serie di vicissitudini divenuto adulto uccide il padre e sposa sua madre. emerge anche in quel mito greco il tema dell’ incesto, dell’accoppiamento con parenti prossimo su cui le popolazioni antiche posero dei tabù, anche imposti per gli svantaggi genetici che tale pratica forse aveva mostrato, con la nascita di bambini malformati o con strane anomalie teratologiche!
Lo stesso Re Artù bambino dopo la sua nascita viene preso dal mago Merlino e da lui allevato in una foresta; era il pegno fatto a Merlino, avere il bambino una volta nato, in cambio dell’ incantesimo che permise al padre, Uther Pendragon, di unirsi alla donna che bramava possedere sessualmente. L’incantesimo consistette nel far assumere per il tempo necessario a Uther le sembianze del marito della donna. E Merlino era molto bravo, da buon stregone, a mutare in forme e creature varie gli uomini e lui stesso.
L’allevamento di Artù nella foresta, che ricorda anche l’ infanzia nella foresta di Perceval, e l’opera di mentore da parte di Merlino, ricorda la formazione di grandi eroi greci ad opera del saggio Centauro Chirone, come Achille, Asclepio, Enea, Eracle, Teseo, Dioniso. Dioniso ad esempio fu cresciuto dalle ninfe dei boschi!
Il nome di Merlino suona perfettamente come latino, e parrebbe potersi mettere in relazione con il nome del merlo, un uccello nero molto comune nei boschi in Italia e Europa tutta.
Tornando alla leggenda dello scontro finale tra Artù e Mordred, Artù ne fu ferito gravemente, e sapendo che stava per morire, ordinò al suo compagno e cavaliere sir Bedivere di gettare Excalibur in un vicino lago. Bedivere obbedì suo malgrado e rimase sbalordito quando vide una mano di donna, quella della bellissima Dama del Lago (Lady of Lake) emergere dal lago e afferrare la spada prima che questa venisse inghiottita dale acque.
Quindi apparve una strana zattera con tre fate vestito di nero che presero in consegna Artù e lo condussero sull’Isola di avalon per curargli le ferite.
Un’ immagine quest’ultima ispirata dal mito greco di Caronte traghettatore delle anime dei defunti attraverso i fiumi infernali, e le tre tre fate nere, le tre parche dei miti latini, corrispondenti alle tre moire del mito greco, la triplice Dea femminile, Dea madre, nella sua veste di signora del destino degli uomini.
Anche nelle feste di Dioniso in Grecia talvolta il dio, (in forma di simulacro o della persone del re che faceva le sue veci), giungeva su una barca, ad esempio ad Atene dal mare, da cui poi prendevano le mosse dei cortei processionali. Echeggia il mito della barca del dio sole, un’ immagine mitologica molto antica e già ben presente presso gli egizi, dove il faraone era considerato come incarnazione del dio in terra. Ancora oggi nel Salento son frequenti le cerimonia religiose dove statue di santi e sante vedono parte delle processioni che lì portano in giro, percorrere dei tratti su barche in mare.
Ad Atene, nelle cerimonie dedicate a Dioniso, chiamate le Antesterie (dal greco “ánthos” che vuol dire fiore), che si svolgevano in febbraio-marzo e che Tucidide considera la più antica e la più importante festa in onore di Dioniso, l’ Arconte-re, l’ “Archon basileus”, la massima autorità politica della città, faceva le veci di Dioniso e si congiungeva sessualmente in un sacro luogo prestabilito, con la moglie, questa per l’ occasione assumeva il titolo cerimoniale di regina, la “Basilissa”. Questo rito propiziatore di benessere per tutti era quello della “ierogamia”, le nozze sacre, l’unione sessuale sacra, del dio maschio con la dea femmina, del dio padre cielo con la dea madre terra, impersonificati dal re e dalla regina reali o cerimoniali, quali anche sacerdoti e sacerdotessa.
La basilinna impersonificava la figura mitica di Arianna, figlia del re Minosse di Creta, che dopo aver contributo ad aiutare l’eroe Teseo (principe e poi re di Atene) a sfuggire dal labirinto di Minosse a Cnosso nell’ isola di Creta, fuggì con lui durante il suo ritorno ad Atene.
Teseo è impersonificato ovviamente dall’Arconte dati i loro comuni titoli regali, ma la sovrapposizione della figura di Dioniso, e il suo primato assunto nel tempo, sebbene anche Dioniso fosse un dio antico nel pantheon greco, spiegano forse quella versione del mito che vuole Teseo che abbandona Arianna su un’ isola, l’ isola di Nasso (da cui l’ espressione odierna “piantare in asso”, per indicare l’abbandono), dove Arianna incontra Dioniso con il suo corteo che si invaghisce di lei e la prende in sposa. Nella cerimonia che precedeva il rito della ierogamia, Dioniso giungeva con una barca dal mare, la barca veniva posta su un carro con quattro ruote e condotta in città con una tipica processione dionisiaca, con satiri nudi al suo fianco suonati flauti; sul carro veniva quindi fatta salire la regina, perché i due sacri sposi si recassero nel luogo della attesa ierogamia propiziatrice per tutta la comunità e la Natura.
Il rito dionisiaco della ierogamia ad Atene ci mostra come era ben possibile che Artas, che aveva il medesimo titolo di “basileus” che troviamo per l’arconte di Atene, impersonificasse nei riti dionisiaci in Messapia proprio Dioniso.
In questo percorso euristico, ci siamo fatti guidare dal principio dell’ associazione di idee soprattutto, ponendoci in un flusso di idee e similitudini, molte possono essere frutto di coincidenze, molte di convergenze antropologiche e di pensiero da universali umani che agiscono allo stesso modo seppur in luoghi e tempi differenti, altre possono però indicarci la strada di fatti e luoghi primordiali che hanno fornito ispirazione per la leggenda arturiana.
Così, ad esempio, qual nome, Bedivere, richiama per assonaza il bosco e il casale medoevale di Belvedere, una ricca di biodiversità ed antica foresta che si estendeva nel cuore del basso Salento ancora ben consevata nel XVIII sec. d.C. ed entro cui esisteva un grande lago, “la Padula”, anche chiamato Lago Sombrino ancora nell’ ‘800, prima che opere idrauliche non lo prosciugassero…in attesa di essere ora ripristinato. Alcuni toponimi sembrano attestare anche la presenza lì di antichi mulini, probabilmente dunque ad acqua, la cui energia, come anche quella del vento (vedi i mulini a vento nelle saline siciliane), e quella degli animali, era sfruttata in passato nel sud Italia per far girare le macine dei mulini.
Da qui parte poi l’ eventuale approfondimento di relazioni originarie o meno. Questo il metodo seguito in questo lavoro conoscitivo ed esplorativo al contempo sulla base delle tesi iniziali alla ricerca di prove a loro sostegno.
Inoltre degli elementi della saga arturiana abbiamo qui iniziato a considerare solo quelli più caratteristici e strutturanti, e se la tesi di partenza si dimostra ben supportata da un certo numero di prove allora si può iniziare a vagliarne altri che eventualmente debbano apparire come più originali e meno frutto di fantasiosi apporti contaminanti successivi.
Fratello di Bedivere e sempre cavaliere della tavola rotonda è “sir Lucan”, un nome che ci rimanda sempre ad ambiente italico, dove Lucano è un nome diffuso nel territorio romano, e Lucania (grossomodo l’odierna Basilicata) è il nome di una regione del sud Italia confinante con la Puglia.
La tradizione letteraria dei lussuosi banchetti nella corte di re Artù ci ricorda poi che re Artas, o un personaggio suo omonimo, pare fosse festeggiato in Messapia con intere feste a lui interamente dedicate e chiamate “MegalArtie”.
Excalibur nella antica Calabria (il Sud Puglia) terra del Calabrops e della sacra bipenne la Labrys (prima parte)
Piccolo abstract: EXCALIBUR la famosa spada di Re Artù? Deriva davvero da EX-CALIBI come sin ora proposto? O da EX-CALABRI? Qui una mia indagine indiziaria nel dubbio che sollevo: e se la leggendaria figura di Re Artù fosse stata forgiata da clerici esperti di cultura classica greco-latina, (come novelli Virgilio o Ennio che glorificarono le origini di Roma, ma per i Britanni), su quella del ben famoso Re Artù dei Calabri-Messapi Re Artos il Grande delle fonti storiche e sul quale circolavano in antichità intere monografie celebrative, famosa quella dello scrittore greco Polemone, ciò al fine di creare un passato fanta-storico eroico in una Britannia abbandonata dai Romani alle furie barbariche dei secoli bui del medioevo?
Cosa possiamo dire della mitica spada di Re Artù, nota come Excalibur, spada dai magici poteri, (come magici i poteri curativi e protettivi del suo fodero), di metallo tanto lucente da accecare i nemici in battaglia.
A dimostrazione di quanto sia suggestiva la teoria che stiamo sviluppando per le origini di Artù nell’area greco-messapica, area culturalmente intrisa della figura dell’eroe Ercole, e di come il nome della sua spada possa esser derivato invece da quello della clava-scettro reale, forse anche rituale tirso, che in Messapia, l’antica Calabria, probabilmente era chiamata con il termine greco “calabrops”, ricordiamo qui questa storia continentale, (dunque non messa per iscritto nelle isole britanniche ma sul continente europeo), tratta sempre dal ciclo arturiano medioevale: “un drago che stava devastato la campagna della Bretagna, [nel nord della Francia], era riuscito ad evitare con successo Artù, il re eroico che ha cercato stanato e combattuto i mostri della regione. Dopo aver ricevuto però delle istruzioni e suggerimenti da parte di ecclesiastici, grazie a queste Artù giunse alla grotta del drago, che quindi coraggiosamente lo attaccò! Artù viene allietato dall’incontro con quei santi uomini e si rallegrò con tutto il cuore per le indicazioni che aveva ricevuto da loro per trovare la grotta, tana del mostro, perché tante volte invece prima era andato via triste da quella regione dove nonostante le tante ricerche non era stato in grado di trovare il mostro, e ciò lo faceva arrabbiare con sé stesso, tanto come se fosse stato battuto in battaglia da quel mostro. Si armò quindi con una clava [in inglese leggiamo “triple-knotted club”, forse clava tre volte nodosa, o spiraleggiante tre volte] e ha difeso il suo torso con uno scudo coperto da una pelle di leone, e poi da solo ha attaccato quel nemico pubblico, lottando per tutti”. (Le fonti celtiche per la Leggenda di Re Artù, Coe, JB, Giovane, S., Llanerch Publishers, 1995, pag. 39).

Arthur combatte il drago per tutto il giorno. Anche se illeso, non solo è stanchissmo, ma non è riuscito a provocare al drago alcun danno serio. Quindi il re cerca l’aiuto di San Euflamm, che bandisce il drago. Questa storia si inserisce in quella serie di storie incluse nei racconti agiografici delle vite dei santi vite dei santi, dove Artù viene ritratto come inferiore agli uomini di Chiesa.
Le armi che qui compaiono son assolutamente tratte da quelle dell’ eroe Eracle/Ercole che aveva come suoi attributi proprio la clava, a volte con più nodosità susseguentisi nel suo sviluppo, e la pelle di leone, l’invincibile leone di Nemea che però lui semi-dio fortissimo figlio di Zeus aveva sconfitto. La pelle del leone di Nemea non poteva essere trapassata, era indistruttibile. Per questo indossandola Eracle era ancor più protetto nelle sue imprese da questa morbida corazza leonina!
La località di Nemea è nel Peloponneso; nell’ Età del Bronzo ancora il leone viveva, sin dai tempi paleolitici, nel sud dell’Europa, e i valorosi che lo sconfiggevano certamente portavano con loro la pelle del leone come indumento cerimoniale per distinguersi agli occhi della gente per il loro valore.
Nel mosaico di Otranto, nell’abside, troviamo Sansone eroe biblico lì indicato con il suo nome e mostrato mentre uccide un grosso leone secondo i testi vetero-testamentali: è il fortissimo Sansone una sorta di equivalente mitico di Ercole a livello biblico.
Ercole combatte contro tanti mostri e animali feroci, tra cui il cinghiale di Erimanto, l’ Idra di Lerna, il Leone di Nemea, i giganti nel sud Italia e anche in Salento, gli uccelli mostruosi del lago Stinfalo, centauri, ecc. ecc., e affronta il drago Ladone che custodisce l’albero dai pomi d’oro nel giardino delle Esperidi.

Vi è ben poco di puramente autoctono celtico dunque, osserviamo sempre più, nella leggenda arturiana medioevale, e tanto di mediterraneo e di cultura greco-messapica! Contrariamente invece a quanto hanno affermato numerosi studiosi sulla figura del fiabesco Artù di Britannia.
Innanzitutto è importante precisare che il primo nome con cui viene chiamata la spada di Artù nella letteratura del ciclo bretone pervenutaci è “Caliburnus”, in latino. Poi ne derivò da esso, in opere letterarie successive, il nome Excalibur divenuto ben più noto.

Nell’ opera intitolata “Morte Arthure”, datata a non prima del 1400, poema in versi basato sull’uso dell’allitterazione e scritto in “Middle English”, (il dialetto sviluppatosi in Inghilterra dopo la conquista normanna del 1066), si fa menzione di una spada chiamata “Clarent”, una spada di pace, opposta a quelle usate in guerra, ed utilizzata per cerimonie e per onorificenze di cavalierato, ma che fu poi rubata e usata da Mordred per uccidere Artù.
Il termine “Clarent”, ci richiama quello della clava di Ercole.
Clava in inglese si dice “club”.
Della spada mitica, spada simbolo scettro di Artù ne scrive il britannico Goffredo di Monmouth (Geoffrey di Monmouth), nella sua famosissima e per molti versi fantasiosa opera, prodotta intorno al 1136, e intitolata “Historia Regum Britanniae”, (un vero e proprio best-seller di successo del medioevo!). E’ lui che la chiama “Caliburnus” ed è sempre lui che la dice forgiata ad Avalon.
In ambiente bretone-britannico, Goffredo, e Nennio prima di lui, si devono considerare pare ad oggi i più antichi e certi autori che parlano del favoloso re Artù collocato in quelle terre in epoca alto-medioevale. Pertanto meraviglierebbe a prima vista constare che, nonostante la materia arturiana sarebbe dovuta arrivare ad Otranto proprio con la solida base testuale fornita da Goffredo e che si era diffusa in tutta Europa, Salento certamente incluso, a Otranto Rex Arturus non fu rappresentato con la magica sua fedele spada Caliburnus di cui narrava Goffredo, ma con un singolarissimo scettro pomoto o claviforme. Ma ciò che a Otranto sembra un mistero può essere invece la chiave di lettura per spiegare la vera anomalia, ovvero il perché di quel nome di quella spada-scettro!
Il bastone pomato, clavato di Artù a Otranto potrebbe essere proprio il bastone chiamato “calabrops” in greco; dal “Lessico della Suida” (X sec. d. C.), in greco, alla voce “Kalabrops (Καλαβροψ), leggiamo “bastone da pastore (βουκολικη’ ραβδοσ – bucoliche rabdos). E’ più pesante in cima, perché si incurva”. Analoghi lemmi nelle forme si segnalano nell’ “Etimologico Magno” e nel “Lessico di Zonara” (un lexicon, cioè vocabolario medioevale bizantino).
Non poteva non colpirmi subito, nel testo del professor Lombardo, così ricco di dati sull’antico Salento chiamato in passato Calabria (prima che questo toponimo fosse poi traslato in epoca bizantina ad indicare il Bruzio e quindi l’attuale regione che oggi viene indicata con quel nome!), anche proprio lo spazio dato a questo oggetto, a questo bastone da pastore chiamato con un nome così strettamente imparenato con quello antico di Calabria (Καλαβρια) e quello etnico di Calabri (Kαλαβροι; al maschile Καλαβρος, al femminile Kαλαβρα’ o Kαλαβρις).

La descrizione ci potrebbe ricordare il tipico bastone claviforme in legno, un bastone nodoso con la testa ben pronunciata diffuso proprio in Puglia, e nel sud Italia, e che nel nord della Puglia si chiama “paroccola”. Alcuni di questi bastoni erano anche enormi molto pronunciati in sommità: il pastore li usava anche per abbattere degli animali colpendoli al capo e per difendersi da belve selvatiche, con lupi, cinghiali e orsi al tempo ben diffusi in tutti la Puglia. E simili bastoni “paroccola” nel mosaico idruntino li troviamo in mano ad un pastore che nel tondo dedicato al mese di aprile, nella navata centrale, porta al pascolo le sue greggi, nelle mani di Caino come strumento con cui uccide Abele, e nelle mani di due cavalieri con scudo, nelle parti iniziali della navata centrale prossime all’ingresso, mostrati mentre duellano minacciandosi l’un l’altro puntando ognuno verso il suo avversario la parte rigonfia in punta del bastone clavato che tiene in mano. Nei tempi passati erano famosi alcuni maestri pugliesi della “scherma con il bastone”, oltre a quelli della “scherma con il coltello” o anche detta “pizzica-scherma” quest’ultima.

Valutiamo quale potrebbe essere l’ etimologia del termine pugliese, e più in generale diffuso nel sud Italia, di “paroccola”. Propongo questa etimologia dal greco “para + cala”, in greco “cala” è clava, e “para-” una preposizione con valore sminuente, nel senso di clava ma dal fusto più sottile, nel senso di intermedio tra clava e bastone, o “para” nel senso che si avvicina alla clava, (“para” infatti può indicare anche affinità, somiglianza, vicinanza).
La somiglianza della paroccola/calabrops è forte proprio con lo scettro singolare di Artù nel mosaico di Otranto, che è un alto bastone probabilmente tutto in legno con continuità, così appare dal mosaico, con grande rigonfiamento a pomo sferico superiore. Ben più grande questo pomo di quanto si conviene ad un normale scettro regale pomato in punta. Si veda a tal proposito lo scettro sempre pomato ma ben più discreto che tiene in mano il Re Salomone, indicato da una chiara legenda musiva e raffigurato ad Otranto nel presbiterio. Lo scettro pomato è simbolo regale, e tale è il valore di regalità dello scettro di Artù, ma esso ha dimensioni inusuali, ed inoltre par più una paroccola clavata pastorale tanto che sul pomo superiormente non spuntano da esso altri decori, come invece per lo scettro di re Salomone più decorato!
E i Messapi erano anche chiamati Calabri, e il Salento anche Calabria prima che per un errore, o comunque vicissitudini storico-amministrative, tale nome passasse ad indicare un’altra regione prossima (in epoca bizantina l’esarcato di Calabria fu esteso a comprendere tutta la dominazione bizantina nel Sud Italia, che però, a seguito dell’invasione longobarda nei secoli VI-VIII, si restrinse prevalentemente al solo Bruzio, la regione ciò attualmente chiamata da allora Calabria). Il Salento antico ha innumerevoli toponimi, alcuni possono esser nati in loco e/o per il luogo, altri possono esser derivati dal nome etnico di gruppi che vi si insediarono prima di amalgamarsi con le altre genti presenti. Nel caso del nome Calabria per il Salento, e Calabri per i Salentini bisogna evidenziate l’ esistenza della tribù storica chiamata dei “Galabrioi” nella vicina Penisola Balcanica in Epiro, forse un dato etnonimico indicativo degli antichi legami di flussi migratori tra le due vicinissime sponde.
Si pensi che esiste un cognome, “Calabro”, attestato oggi nel sud Italia, che ha la maggiore diffusione in Sicilia e Calabria, e la massima diffusione proprio in Puglia, ed in particolare nella zona dell’otrantino.
Il Calabrops poteva dunque essere in antichità un elemento connotante proprio i Calabri, non a caso così chiamati, e scettro dei loro re? I Calabri, i portatori del Calabrops?
Una nuova ipotesi etimologica dunque qui ne discenderebbe per i Calabri e il nome Calabria, il Salento dove erano insediati.
Un bastone clava, come la clava dell’eroe greco Eracle (Ercole per i latini), tanto legato alla cultura greco-messapica di Puglia.
Il bastone del pastore era simbolo della regalità dei re micenei, pastori di uomini, e il Salento è intriso di cultura micenea e minoica come raccontano le fonti antiche per la genesi dei popoli japigio-messapici, e come oggi mostrano anche le scoperte archeologiche. E nell’etimologia del bastone-scettro regale Calabrops, potrebbe esserci il nome dello scettro per antonomasia dei micenei e minoici, la sacra ascia bipenne chiamata Labrys, (o Pèlekys, o anche “Sagaris” in greco), scettro regale e strumento sacrificale, associata alla dea femminile (Artemide a Patrasso in Grecia ad esempio), e al dio maschile (Zeus in Caria e in Lidia, Dioniso in Tessaglia), di cui diviene simbolo. La labrys è stata ritrovata anche in Salento, incisa sulle pareti della Grotta della Poesia a Roca Vecchia, antica città minoico-micenea prima che messapica. Ascia bipenne pure presente tra i simboli dipinti in calce bianca ancora nel secolo scorso, per tradizione rinnovata che si perde nei secoli, sul cono dei caratteristici trulli della Valle d’Itria. Era il simbolo della dea e del dio, scettro di Zeus, e pertanto scettro reale.


Il bastone del pastore per la sua simbologia di guida e comando del gregge, nonché poi anche fallica, non a caso è poi divenuto simbolo del vescovo e non a caso è ancora lo scettro dei cosiddetti “capu-bastuni” (o “capu-vastuni”) , i capi delle ‘ndrine (dal greco “andros”, maschio, col significato di unioni di maschi) le fratrie della ‘Ndrangheta (termine che viene dal greco “uomo d’onore”, organizzazione di uomini d’onore, di virtù, dal famoso ideale greco “kalòs kai agathòs“, questa pare sia propria l’etimologia del nome di quella organizzazione para-statale che oggi agisce nell’ombra) nelle quali piaccia o meno ma sopravvivono o riecheggiano rapporti di fratellanza e mutuo soccorso con tanto di iniziazioni che possono trovare grandi similitudini con le organizzazioni cavalleresche medioevali.
Labrys legata come etimologia al Labirinto di Cnosso del mito di Teseo, Arianna con il suo filo e il mostro Minotauro. Teseo legato dal mito alla fondazione di Brindisi e lì in antichità ritratto proprio nel labirinto in un mosaico. Non dimentichiamo che pare fosse della Messapia proprio l’area orientale includente Otranto e Brindisi la prima area a definirsi Calabria terra dei Calabri, prima che il toponimo fosse esteso, e tanto più in epoca romana, anche alle aree occidentali della Messapia che erano quelle dove stavano i Sallentini. A sua vola anche il termine Salento fu poi esteso dalle aree occidentali occupate dai Sallentini ad indicare anche le aree orientali della terra di Messapia.
Nella stessa grotta costiera a Roca troviamo incisa sia la sacra Labrys in Età del bronzo sia il nome Artas in un’epigrafe del successivo tempo messapico!

Incisioni parietali sulle pareti della Grotta della Poesia piccola a Roca Vecchia (comune di Melendugno).
Le pareti della grotta ospitano incisioni ed epigrafi da epoca preistorica fino a quella messapica, passando per l’Età del bronzo. Si tratta di rappresentazioni di mani e piedi e di figurazioni antropomorfe, zoomorfe o astratte che trovano riscontro in analoghi santuari ipogeici della tarda preistoria, come la Grotta dei Cervi di Porto Badisco. Le attestazioni più recenti sono invece costituite da iscrizioni votive realizzate prevalentemente in lingua messapica e latina, in rari casi anche in lingua greca. Le epigrafi, datate tra la metà del IV e la fine del II sec. a.C., sono riconducibili sia a personaggi eminenti (vi compare un personaggio di nome Artas) che a gente comune e si rivolgono alla divinità maschile indigena Thaotor Andirahas, forma traslitterata in “Tutor Andraios” in latino. Nei testi di età repubblicana, gli unici integralmente traducibili, i dedicanti formulano una richiesta d’aiuto al dio, accompagnata dall’elenco dei beni promessi (vino, bestiame etc.) in cambio della protezione;
(vedi link dell’Università del Salento su Roca Vecchia).
Una mia ipotesi invece sull’etimologia del nome CALABRIA: il nome originario della spada di Artù era CALIBURNUS nei racconti del XII sec. d.C. in cui fa la prima comparsa letteraria nota la celebre arma, presto divenne EXCALIBUR. Indagando sulla mia pista di un’identificazione tra l’Artù fiabesco britannico e Artas concreto messapico-salentino-calabro ho scoperto l’esistenza in antichità di un bastone ricurvo in sommità chiamato CALABROPS, la suggestione forte la sua somiglianza con lo scettro di Artù nel mosaico salentino. Da qui l’ipotesi personale che il CALABROPS, simile all’attuale paroccola dei pastori pugliesi (bastone clavato in sommità), poteva dunque essere in antichità un elemento connotante proprio i Calabri, non a caso così chiamati, e scettro dei loro re. I Calabri, i portatori del Calabrops?

Riporto da Wikipedia questi passi sulle attuali ipotesi in merito all’etimologia del toponimo Calabria: “Il nome Calabria viene da Calabrī, da confrontare con i Γαλάβριοι (Galábrioi) della Penisola balcanica (dalla quale forse deriva anche l’etnico Calabrī). L’origine sembra essere una radice preromana *cal-/cala-[9] o *calabra-/galabra-, che compare anche in calaverna e calabrosa, nonché in Calabria, nome comune della pernice di monte (Lagopus muta), che significherebbe “roccia”, “concrezione calcarea o ghiacciata”. A sostegno di questa tesi Latham (1859) riporta tribù di Galabri o Calabri nelle regioni orientali dell’odierno Kossovo, ricche di giacimenti minerari di oro e di argento e afferma che Iapigi e Iapodi erano contigui ai Galabri e, “for all pratical purposes”, erano la stessa popolazione e che “word for word” Galabri è lo stesso che Calabri. Latham afferma inoltre che in Italia ci sono Iapigi chiamati Calabri, nei Balcani ci sono Iapodi anche detti Calabri. Con il nome di Iapigi venivano indicati anche i Messapi e i Calabri. È dunque probabile che migranti abili nelle tecniche minerarie abbiano popolato le zone dell’Italia meridionale prossime a giacimenti per loro interessanti. Quelli delle Serre (Pazzano) e quelli ricchissimi del monte Mula (anche qui oro e argento) furono coltivati anche in tempi remoti. “Mula” è uno dei molti toponimi calabresi derivati da antiche lingue del vicino oriente. Un’altra ipotesi vuole che il termine Calabria derivi invece dal greco antico kalón-bryōn ([terra] che fa sorgere il bene/il bello), ad indicare la fertilità del suo territorio. Ne fa riferimento, ad esempio, il poeta e storico cinquecentesco Francesco Grano da Cropani nel suo poemetto De situ laudibusque Calabriae (in realtà lui si riferisce al Bruzio), in cui, nell’elogiare le bellezze della Calabria, accenna anche alla presunta esistenza della suddetta origine etimologica (“[…] se è vero che nella lingua greca il termine kalon significa bello, e brio indica lo zampillare […]”).”
Per il nome Calabria vi son ad oggi in letteratura ipotesi etimologiche quali “monte (brin) selvoso (cal)”, “roccia-concrezione calcarea”, “faccio sorgere il bene” (nel senso di terra fertile, dal greco”kalon brion”), ecc., da cui il nome Calabri dei suoi abitanti.
«Il Bardetti (nell’opera “Della lingua de’ primi abitanti d’Italia”, Modena, 1772) pretenderebbe che CALABRI significasse abitanti di monte (brin) selvoso (cal)» [passo tratto da “Gli Studi Storici in Terra d’Otranto” a cura di Luigi G. De Simone (1835-1902), stampato a Firenze nel 1888, Tipografia Galileiana di M. Cellini E.C.].
Ad oggi le proposte etimologiche per il nome della favolosa magica spada di re Artù stabilivano un parallelismo con l’etimologia del nome dei “Calibi”, una antica e mitica tribù di fabbri dell’antichità, che viveva in Anatolia, nella Scizia, e a cui veniva attribuita l’invenzione della siderurgia, motivo per cui il loro nome in greco significava “ferro temperato, acciaio”, un termine passato al latino come “chalybs”, “acciaio”. E dunque il materiale di cui era fatta la spada di Artù. Per la forma invece del nome “Excalibur”, con cui la spada di Artù viene chiamata per la prima volta da Robert Wace, un poeta normanno, nella sua opera intitolata “Roman de Brut” (completata nel 1155) ispirata all’opera pseudo-storica sulla Britannia di Goffredo di Monmouth, (che aveva chiamato quella spada Caliburnus), si può immaginare derivato dal nome “ex + Calibi”, (“Calibi” il caso ablativo di “Calibs”), che vuol dire “dai Calibi”, quindi tradotto letteralmente il significato diventerebbe “forgiata dai Calibi”. Alcuni fano derivare Excalibur (Escalibur) dalla crasi delle parole latine, “ensis caliburnus”, interpretato come la “spada calibica”, cioè forgiata dai Calibi. Altre piste etimologiche dal latino riconducono alla capacità della spada e al suo aspetto come, per esempio, “ex calibro” che tradotto significa in perfetto equilibrio.
Ma volendo anche noi cercare un’etimologia del nome comparso in un secondo tempo in letteratura rispetto a Caliburnus, ovvero Excalibur, potremmo proporre ora l’origine da un “ex Calabri”, nel senso di arma forgiata dai Calabri, proveniente dai Calabri, (propria dei Calabri, tipica dei Calabri), e dunque dai Salentini nel Salento.
Il suono etimo “BR” che ritroviamo in Labrys compare in Brindisi dove indica “cervo”, in memoria si dice del suo porto a forma delle corna di un cervo o per la presenza di cervidi in zona, ma anche in Calabria. Pare che anche riferito ai cervidi il suo significato più antico è quello di radura luminosa dove i cervi pascolano al margine del bosco, valore di luce “brillantezza”, si potrebbe così spiegare perché compare in Labrys, l’ascia bipenne di metallo, e perché poi anche in Excalibur. Mentre l’etimo XL o CL forse indica legno, il palo di legno della Labrys? Per approfondire su questi etimi rimando a questo bell’articolo.
(…questo paragrafo continua, caricheremo al più presto le parti mancanti…)
L’origine della Fata Morgana e le leggende medioevali che narrano della sua presenza tra Penisola Italiana e Sicilia
Per l’origine della fata Morgana (Morgan le Fay), sorella di Artù nei miti arturiani, il suo nome potrebbe derivare (o comunque aver comune origine etimologica) dall’ etnonimo dei Morgeti, tribù ausonica, pre-messapica, di cui in Puglia restano tracce in toponimi come Murge, forse anche Morciano, Morigino, ecc., e in nomi con radice “MOR-”, di cui è ricchissima l’onomastica messapica emersa dagli studi epigrafici, forse anche proprio in teonimi, i nomi o epiteti di divinità locali, elemento questo ancor più importante nella genesi del nome di una “fata”. Morciano (Morcianum) forse toponimo prediale da terreni assegati dai Romani ad una persona di nome Morkos, nome messapico come rivela l’epigrafia messapica.
La “fata” è un termine che si diffonde soprattutto nel latino medioevo, (nel basso latino), e che correlato al termine “fato”, destino, e al verbo “fatate” che vuol dire far sortilegi, incantesimi, divinare, viene associato alla tre Parche (le tre Moire per greci), le divinità femminili immaginate come filatrici che regolavano il destino degli uomini. Dunque un nome asociato alla dea femminile di cui le parche erano una delle epifanie. Da qui il nome passo nella cultura popolare ad identificare divinità femminili e quindi anche sovente le ninfe della tradizione miotica greco/latina, soprattutto laddove esse attuavano prodigi per il bene o il male degli uomini.
I Morgeti si trasferirono in età antica in Sicilia dal sud Italia, lasciando lì anche tracce toponomastiche, vedi ad esempio l’antica città classica, oggi sito archeologico, di “Morgantina” (sue varianti nelle fonti: Morgantia, Morgantium, Morgentia, Murgantia, Murgentia). (Vedi in proposito anche il testo di Stefano L. Imperio “Alle origini del dialetto pugliese” Schena Editore 1990). Forse vi son legati anche etimologicamente nomi proprio attualmente ancora utilizzati come Morgante, e cognomi ancor oggi diffusi come Morgante, Morganti, (cognomi attestati questi anche in Sicilia, Calabria e Puglia), e Morgana (attestato soprattutto in Sicilia e anche proprio nei pressi dello Stretto di Messina.
Non è un caso forse dunque che in epoca medioevale fiorirono proprio in Sicilia e nella zona dell’Etna e dello Stretto di Messina ben più che altrove le leggende proprio sulla Fata Morgana. Fu anche lì come in Salento forse proprio una riaffermazione, riemersione con forza, di un sostrato culturale popolare legato alla figura fiabesca di un’ antica dea etnica locale, che fece anche da attrattore per la addensazione lì delle leggende arturiane dove Morgana che era la sorella di Artù era già non a caso maga quasi divina anche nella fiaba medioevale nei cicli arturiani. Fu questa attrattività in tal senso del luogo, dove la figura di Morgana aleggiava da millenni ormai in una terra di alta suggestione, quale quella dell’Etna, a rendere oltre a Otranto e il Salento con Artas, anche la Sicilia etnea luogo in cui si affermò forte la leggenda di Artù.
Non bisogna però dimenticare anche un aspetto storico che occorre rimarcare e che già lega alla Sicilia l’Artas storico messapico. Lo storico Tucidide, come ampiamente abbiam visto, racconta della partecipazione alle operazioni militari in Sicilia di re Artas con un contingente di 150 lanciatori di giavellotto al fianco degli ateniesi. La spedizione ateniese in Sicilia interessò la Sicilia orientale, dalla zona etnea sino soprattutto a Siracusa.
Non sappiamo se Artas vi prese parte personalmente in questa come in altre operazioni militari in Sicilia, o solo con suoi contingenti, in ogni caso nella storia di Artas non mancano appunto legami pertanto con campagne militari dirette in Sicilia.
In un vecchio poema francese intitolato “Floriant et Florète”, composto probabilmente già nel secolo XIII, l’ Etna appare come una sorta di regno fatato, castello dimora consueta di Morgana, luogo meglio noto col nome di “Faerie”, ossia paese delle fate. Lì Morgana conduce e fa educare Floriant, figliuolo di un re Elyadus di Sicilia, dopo la scomparsa del padre. Lì, annuncia la stessa Morgana, vi sarebbe andato a dimorare, come sua ultima dimora, Re Artù.
E la Sicilia come ricca ambita isola dai normanni ben si poteva qualificare nell’immaginario come potenziale Avalon. Non è escluso, come abbiam già sottolineato, che proprio la forte connotazione del luogo con tracce della cultura onomastica e mitologica morgetica, abbiano favorito poi insieme a Morgana, anche la collocazione della dimora finale di Artù in Sicilia.
Lì sullo stretto di Messina e nei mari prossimi all’Etna la tradizione popolare giunta sino a noi, (anche grazie a vari autori locali e non che dal medioevo ad oggi han messo per iscritto le dicerie locali o si son lasciati ispirare da esse), favoleggia della presenza della Fata Morgana che si spostava su un magico cocchio trainato da cavalli capace di volare come di scendere nelle viscere della terra e del mare; la Fata viene correlate popolarmente al fenomeno dei miraggi che sullo Stretto spesso si verificano, e durante i quali la sponda opposta della Sicilia vista dal continente italiano può apparire molto vicina ingannando chi guarda; è un fenomeno naturale, ma quando si verifica la gente dice “Guarda, la Fata Morgana”, e da lì il fenomeno fisico ha preso questo nome, oggi ovunque diffuso come quasi termine tecnico nell’ linguaggio fisico in ottica.
Lo stesso fenomeno dei miraggi si verificava nel Salento, soprattutto nelle località paludose dell’Arneo, una sorta di maremma salentina, ubicata nelle aree pianeggianti occidentali dell’arco Ionico, da Gallipoli nel basso Salento, fin quasi a Taranto; ne parla lo studioso locale Antonio De Ferrariis, detto il Galateo dal nome della sua città natale (Galatone, 1444 – Lecce, 1517), nella sua opera sul Salento chiamata “De Situ Japigiae”, tali ingannevoli apparizioni ottiche, miraggi vari in generale, venivano chiamate “mutate”, o “mutazioni”, dalla gente.
L’Arneo è per i salentini anche la terra attraversata dalla lunga e dritta “Via Avetrana” che dall’antico centro messapico di Nardò porta alla città omonima di Avetrana (nei secoli passati chiamata all’inizio dell’età moderna “Vetrana”). Ritengo che quel nome deriva da quello della strada che da Nardò portava all’ antico centro messapico di Manduria, e che trovandosi su tratti stadali che furono ripresi dai romani probabilmente sotto l’ imperatore Traiano, prese il nome di Via Traiana, da cui ritengo possibile l’origine di via Avetrana e quindi del centro di Avetrana che crebbe su di essa. Si distingue per questo tra gli storici locali nella nomenclatura delle strade romane salentine, tra la Via Traiano-Calabra che andava da Brindisi a Otranto, e la Via Sallentina o Traiano-Sallentina che andava da Otranto a Leuca e da Leuca a Taranto. Da Taranto a Brindisi correva invece la antica romana Via Appia, che terminava nel porto di Brindisi con due monumentali colonne romane di cui ancora ne resta in piedi una, e che son nel simbolo della città di Brindisi insieme alla testa di cervo maschio con corna.
Anche perché sebbene Messapia, Calabria e Sallento (Salento) fossero sinonimi, alcune volte già in epoca antica si tendeva a chiamare Calabria la porzione adriatica della Messapia, e Sallento quella ionica, tenendo conto che Capo d’Otranto il punto più ad est d’Italia si può ritenere correttamente il punto in cui si passa dal mare Adriatico al Mare Ionio, del resto da Otranto a Valona (Canale d’Otranto) si individua il punto più stretto del golfo del Mare Adriatico, la bocca in cui esso inizia dunque, (anche se una tradizione locale poetica vorrebbe che i due mari si incontrino a Leuca, più giusto allora considerare tutto il mare che lambisce il Salento da Leuca a Otranto, Canale d’Otranto di acque dunque ne dell’ Adriatico, né dello Ionio, ma di entrambi mari!).
Con questi miraggi nel cielo apparivano immagini di città lontanissime, di eserciti, carri, cavalieri ecc., che fluttuavano nell’aria, talvolta capovolti. Non è escluso che tali miraggi, come il moto nelle nubi mutevoli e le aurore boreali possono aver contribuito, allo sviluppo del tema mitologico e folcloristico, immaginifico, della cosiddetta “caccia selvaggia”, diffuso nell’Europa settentrionale, centrale e occidentale. La struttura narrativa di tutte le versioni del mito si fonda su questa premessa: un corteo notturno di esseri sovrannaturali attraversa il cielo (o il terreno), mentre è intento in una furiosa battuta di caccia, con tanto di cavalli, segugi e battitori al seguito. E’ un gruppo di spettri condotti dal Re della Caccia Selvaggia. In questo tema si innestò quello della caccia al cinghiale di Artù, denso come abbiam visto di influssi mitologici ed antropologici greco-mediterranei. Gervasio di Tilbury nel XIII secolo e due scrittori nel XV secolo assegnano il ruolo ad Artù di capo della caccia selvaggia. Gervasio di Tilbury (1155 – 1234) è stato un giurista, politico e scrittore inglese, appassionato di filosofia naturale, che visse per diverso tempo in Italia del Sud alla corte del re normanno Guglielmo II di Sicilia detto il Buono che dal 1166 salì al trono al posto di Guglielmo I di Sicilia detto il Malo, sotto il cui regno era stato realizzato il mosaico idruntino.
Il tema della caccia selvaggia presagio di sciagure, ci richiama alla mente un tema popolare con alcuni punti di somiglianza che ritroviamo nel sud Italia, in Lucania come in Salento, quello della cosiddetta “Messa dei Morti”: un contadino (uomo o donna) che andando a lavorare molto presto o tornando dopo il tramonto incontra una chiesa illuminata dall’interno nella quale si sta celebrando una messa. La chiesa appare affollata di persone, nonostante l’ora insolita e il testimone non riconosce nessuno ed il sacerdote sta celebrando volgendo la schiena all’altare. Alcune volte qualcuno degli astanti dice al nuovo arrivato di allontanarsi poiché è “La Messa dei Morti”, altre volte tra i presenti vi vede dei conoscenti o parenti scomparsi, il contadino che si trova di fronte ad un simile spettacolo inatteso, viene colto da panico e fugge via verso casa, dove poi viene colto da brividi febbrili e per alcune giorni rimane indisposto.
In Sicilia le leggende ruotano spesso intorno al nucleo tematico dell’ intervento della Fata ad offrir servigi o ingannare i conquistatori, come i normanni, o altri barbari prima di loro, che volevano conquistarla attraversando lo stretto. Ciò sembra dunque evidenziare la radicazione della presenza lì della fata Morgana a tempi ben più antichi. Forse era appunto il nome di una divinità femminile degli antichi locali Morgeti.
Riportiamo alcune di queste leggende.
L’ingannatrice Morgana si dilettava a beffare gli sfortunati uomini che desideravano giungere in Sicilia dal suo polo opposto.
Un giorno a cadere vittima fu un re arabo, il quale, giunto al capo estremo della Calabria, fu improvvisamente pervaso dal desiderio bramoso di raggiungere la terra magica e incantata che si era manifestata al suo sguardo. Mentre ragionava su come raggiungere quel luogo fantastico, in cui un imponente monte sputava fiamme e fumo, gli apparve una splendida donna. Costei, con parole ingannevoli, convinse l’uomo di avere la facoltà di dargli in dono quella terra ricca di meraviglie. Il sole era alto in cielo, l’aria limpida, la Sicilia sembrava proprio a un passo da lui. Il sovrano arabo, persuaso da quella illusoria vicinanza, si gettò in acqua per raggiungere l’altra sponda, ma annegò. Leggenda tratta dall’articolo al link.
Fu sua vittima anche un re dei barbari che aveva già conquistato terre nelle Penisola italiana, arrivato a Reggio Calabria, vide a pochi chilometri, sull’altra sponda, un’isola incantevole con le sue spiagge coperte di aranci e di ulivi, con un gran monte fumante, l’Etna , e una terra fertile e ricca. Il Re barbaro la bramava cupidamente, in groppa al suo cavallo, non possedeva neppure una barca, quella terra per lui era perciò irraggiungibile, ma una donna molto bella gli apparve: “Vedo che guardi con rammarico quella bella isola, la vuoi? Ecco che io te la do con le sue città, con le sue campagne profumate e coi suoi monti che eruttano fuoco. Guardala, è a due passi da te”. Era agosto, il cielo e il mare senza una bava di vento, una leggera nebbiolina velava l’orizzonte. Improvvisamente, a un cenno della donna, una cosa miracolosa apparve agli occhi del barbaro. La Sicilia era lì a due passi da lui. Guardando nell’acqua egli vedeva nitidi, come se potesse toccarli con le mani, i monti dell’isola coperti di ulivi, le spiagge tutte verdi di aranci e di limoni, le vie di campagna con gli asinelli che vi camminavano, il porto di Messina con le navi, i carichi sui moli e perfino i marinai che scaricavano le merci (ndr. era il fenomeno ottico del miraggio della Fata Morgana). Con un grido di gioia il Re barbaro balzò giù da cavallo e si buttò in acqua, sicuro di poter raggiungere con due bracciate l’isola desiderata, ma l’incanto si ruppe, e il Re affogò. Leggenda tratta dall’articolo al link.
“Un’altra leggenda racconta dell’incontro con la Fata fatto lì da Ruggero il Normanno che questa volta, a differenza del re berbaro in tempi precedenti, riuscì a non soccombere agli inganni di Morgana. “Il sovrano normannoi era stato scelto dai siciliani per prendere il comando della guerra che avrebbe sciolto l’isola dall’egemonia degli arabi, che ne avevano fatto una terra musulmana. Ruggero aveva accettato l’impresa, ma non disponeva di un esercito abbastanza numeroso. Anche stavolta Morgana volle aiutare lo straniero, materializzando sullo Stretto, un esercito invincibile e un cocchio pronto a traghettare Ruggero in Sicilia. Il normanno, però, rifiutò l’offerta perché, fervido credente, voleva liberare l’isola con il solo aiuto del Dio cristiano a cui si affidava; si allontanò da lei, per poi riprendere poco tempo dopo l’impresa senza il suo aiutò. L’epilogo della fiaba è nella storia. Nel 1061 Ruggero sbarcò a Messina e iniziò la decennale guerra contro gli Arabi liberando la Sicilia e facendone una prosperosa terra cristiana” (Testo tratto dall’articolo al link.).
Sembrerebbe che queste leggende vogliano legare o leghino la presenza lì di una Fata dal nome Morgana a tempi precedenti dunque all’arrivo dei Normanni!
Le ricerche etimologiche in merito al diffuso toponimo “murge”, lo riconducono a roccia, dal latino “murex, muricis” con riferimento al tipo di terreno di natura rocciosa e collinare. O a terra fertile.
“Murgia: zona collinare della Puglia. Variante apofonetica sicuramente ausonica della radice indoeruropea MARG = terra profonda e fertile. Si ripete nel nome di Valle Murcia della Roma antica.” (Dal testo “Alle origini del dialetto pugliese”, di Stefano Leonardo Imperio” 2° edizione, Schena Editore 1993). A Roma c’erano un santuario di Venere, nel quale la dea era chiamata Dea Murcia. Murcia il nome di un’ antica dea madre venerata dai latini.
Altra ipotesi etimologica: “il toponimo deriva dalla parola latina murex, che significa murice, roccia aguzza. Il nome “murgia” fa riferimento ad una voce italica di origine osca che è mutuata probabilmente dalle lingue preindoeuropee parlate in Italia meridionale prima della migrazione osca e che significa pietra. Sopravvive ancora nel suo significato originario nei dialetti calabresi settentrionali.” (Da Wikipedia alla voce “Murge”).
Diamo ora qualche dato in più sui Morgeti (Μοργῆτες, Morgetes). Furono un’antica popolazione italica, poi culturalmente ed etnicamente sfumata in età storica. Lo storico siciliano Antioco, (in Strabone, VI, 257, 270, e in Dionigi d’Alicarnasso, I, 12), lì ricorda come abitanti un tempo, insieme coi Siculi, quella regione del Bruzio nella quale più tardi sorse Reggio (Reggio Calabria): Siculi e Morgeti sarebbero poi stati cacciati dalle loro terre nel continente peninsulare italiano per mano degli Enotrî ,e sarebbero passati ad abitare in Sicilia, dove la città di Morganzia ricordava ancora il loro nome. “Lo stesso Antioco, probabilmente, riferiva anche che codesti Morgeti, durante la loro permanenza nell’Italia meridionale, avevano, sotto il loro re (eponimo) Morgete, esteso il loro territorio sino alla regione dove poi fu fondata Taranto.” (Fonte “Enciclopedia Treccani”, sotto la voce “Morgeti”). Il nome dei Morgeti sembra affiorare più volte nella toponomastica, anche moderna, così nella regione pugliese, (Morgia, le Murgie), come della Sicilia orientale; sì da far pensare che questi nomi rappresentino il ricordo del popolo dei Morgeti, probabilmente facevano parte dello stesso gruppo dei Siculi/Ausoni che con l’arrivo degli Japigi in parte dovettero abbandonarono il sud Italia peninsulare, Puglia inclusa, verso la Sicilia (che da essi prese il nome). Ma la permanenza nell’epigrafia e quindi nella lingua e cultura messapica di nomi riconducibili alla medesima radice, lascia pensare che non tutti fuggirono via all’arrivo delle nuove genti d’oltre mare, ma che diversi nuclei, famiglie e comunità rimaste, come è appunto plausibile, furono nel tempo integrate e si fusero con i nuovi arrivati, portando il contributo della loro cultura più autoctona, nella genesi della cultura salentina dell’Età de Ferro. È più che verosimile, come molti sostengono, che l’antica città di Morgantina, in Sicilia, prima sicula poi greca, posta nelle vicinanze dell’Etna e del mare Ionio, e che raggiunse il massimo splendore nel V sec. a.C. fosse stata fondata proprio dai Morgeti. E’ attestata la venerazione lì di una dea, dal ritrovamento di una famosa statua in pietra nota come Dea di Morgantina (si pensa sia Demetra o Persefone, erroneamente Venere). Probabile continuità del culto di una dea femminile dei Morgeti!
Ecateo di Mileto, forse il primo geografo dell’antichità, vissuto nel VI secolo a.C., nel parlare dello stanziamento di vari popoli descrive i Morgeti come collocati nella zona di Reggio Calabria, dove rimane anche il loro nome, in quello del comune di San Giorgio Morgeto (“San Giorgiu Morgetu”, in vernacolo locale). La città si crede fondata con quel nome dal mitico re Morgete (Morges, si crede vissuto nel XI sec. a.C.), che le fonti fanno successore di Re Italo (da cui derivò il nome Italia), il quale governò sulle terre dei morgeti nel sud Italia, sino a quando il suo regno non fu invaso dagli Enotri (e probabilmente anche dagli Iapigi), e guidò le sue genti in Sicilia, dove si favoleggia egli stesso fondò Morgantina. Contempraneo e per le stesse ragioni il flusso verso la Sicilia dei Siculi.
Tucidide che scrisse la sua storia , dopo la disfatta dell’esercito ateniese nel 413 a.c. , riferisce una storia veritiera (ndr. la sua fonte è l’opera “Sikelia” – in 12 volumi del siracusano Antico risalente agli anni 430-424 a.C.) su ciò che è accaduto in Sicilia: “ I Siculi passarono dall’Italia in Sicilia (…) Vennero in Sicilia con un grosso esercito e superati i Sicani in una battaglia li spinsero verso le zone meridionali e occidentali dell’Isola”. E fecero sì che l’Isola da Sikania si chiamasse Sikelia. Compiuto il passaggio, occuparono e abitarono le zone più fertili del paese circa trecento anni prima che i greci venissero in Sicilia e ancora oggi essi possiedono il centro e le parti settentrionali dell’Isola. In realtà anche le popolazioni dell’età del bronzo finale in sud Italia, nell’attuale Calabria e in Puglia, quali Ausoni, Siculi e Morgeti, furono attratte dalle ricchezze della Sicilia e delle sue isole settentrionali, ler isole Eolie, che pertanto invasero anche distruggendo precedenti villaggi. A Lipari questi violenti invasori prevalgono senza difficoltà sulle popolazioni ricche e scarsamente bellicose che nel corso dei secoli precedenti si erano dedicate al commercio e non alla guerra. La storiografia antica (Diodoro Siculo), che spesso si mescola con la leggenda, vuole che sia stato Liparo, il figlio di Auson re degli Ausoni, in rotta con la sua gente per motivi dinastici ad impadronirsi di una flotta insieme ad un gruppo di uomini a lui fedeli e con questa, messosi per mare a partire dalle coste calabre, ad invadere Lipari distruggendone i villaggi.
Sappiamo dalle fonti che, nel XIII sec. a.C. ( secondo Dionigi di Alicarnasso, fonte tratta da Ellanico), o nel XI sec. a.C. (secondo Tucidide, fonte tratta da Antico), alcune popolazioni provenienti dalla penisola italiana, i Siculi e i Morgeti, si stabilirono nella Sicilia orientale.
Dal testo “Alle origini del dialetto pugliese”, di Stefano Leonardo Imperio” (2° edizione, Schena Editore 1993), cui rimandiamo, riportiamo con alcune integrazioni questi dati che seguono:
AUSENTUM: attuale Ugento (antica città messapica, n.d.s.). Nelle monete AOXEN, forse la stessa radice di Ausoni.
(…)
Rimase pur con l’ arrivo degli Japigi, una presenza etnica e cultural linguistica dei morgeti
(…)
Secondo Antioco i Morgeti abitavano nella zona della Murgia, e sotto la minaccia degli Japigi emigrarono [una parte consistente forse solo] in Sicilia.
(…)
In territorio Messapico, nei pressi di Mesagne è stata ritrovata alcuni anni fa una (M. Ignone, A. Nitti, A. Sconosciuto, D.Urgesi, “Mesagne 1984”, volume stampato nella Grafischena di Fasano) un’ iscrizione dedicatoria, l’ epigrafe incisa su pietra ha il seguente testo di tre parole: “DIOVEI MOURG[O] SACR[UM]”
“Diovei” è la redazione più arcaica del Giove latino (così in un’epigrafe trovata a Rossano Calabro, tale redazione arcaica vede al posto della lettera V, il digamma greco F).
Murgo, è un attribuito. Per le consuetudini indoeuropee, si accompagnava quasi sempre un attributo al nome della divinità. Qui potrebbe riferirsi al popolo che lo venerava «A Giove, dio tutelare del popolo morgetico» (da “Alle origini del dialetto pugliese”, di Stefano Leonardo Imperio” 2° edizione, Schena Editore 1993).
In ogni caso, è un attributo che stabilisce una relazione linguistica forte con la cultura Morgetico-ausonica.
La spada nella Roccia e il mito di Teseo l’eroe ateniese ecista fondatore di Brindisi

In una terra salentina-messapica intrisa di cultura greca, la leggenda nei cicli arturiani della suggestiva spada conficcata in parte nella roccia per la punta e da estrarre per aver diritto a regnare. Impresa magicamente concessa solo al prescelto al trono, ed è Artù che riesce nell’impresa, un mito intriso di archetipi legati ai culti betilici, ma forse anche quasi arcaica alchemica allegoria del mistero dell’estrazione dei metalli dalla roccia minerale, troverebbe parallelismi con il mito dell’eroe ateniese Teseo che deve, una volta divenuto forte crescendo, spostare un grosso masso, come riuscì a fare, sotto cui era stata sepolta la spada il cui recupero gli avrebbe dato diritto di successione al trono. Associata a Teseo è anche una clava ricoperta di bronzo, arma che lo caratterizza spesso quando viene ritratto nelle decorazioni su vaso. Teseo eroe dunque al contempo caratterizzato da una spada e da un bastone clavato rivestito di bronzo.
E tornando alle antiche fonti relative ala genesi dei popoli di Puglia, alcune riferiscono della fondazione di Brindisi ad opera dell’eroe ateniese Teseo come ecista, l’eroe che sconfisse il mostruoso forte e terribile Minotauro mangiatore di uomini, a Creta. (Il nome della città di Brindisi, che le fonti antichi riconducevano al termine messapico “brention”, indicante al testa del cervo maschio con palchi, per la somiglianza con essa del porto della città con due arcuati seni. Il cervo inoltre era fino a pochi secoli or sono animale comunissimo in Salento. Per questo nel simbolo civico di Brindisi troviamo oggi una protome di cervo con palchi).

Pavimento a mosaico da via Carmine a Brindisi.
Labirinto con mura merlate; al centro pannello con Teseo che abbatte il minotauro, II sec. d.C.
I miti raccontano che Teseo estrasse la sua spada da una roccia. Per la precisione una versione del mito racconta che suo padre Egeo, un mitico re di Atene, giacque ubriaco con Etra fecondandola, sull’ isola di Samo, in Asia Minore. Dopo che essa rimase incinta, Egeo decise di tornare ad Atene, ma prima seppellì la sua spada sotto un’enorme roccia, un masso noto con il nome di Altare di Zeus, dicendo a Etra che, quando suo figlio fosse cresciuto, avrebbe dovuto spostare la roccia con le sue forze e prendersi le armi per dimostrare la sua discendenza reale. Teseo crebbe così nel paese materno. Una volta cresciuto e diventato un giovane forte e coraggioso, spostò la roccia e recuperò le armi del padre. Etra allora gli disse la verità sull’identità di suo padre, e gli spiegò che avrebbe dovuto riportare le armi a corte, ad Atene, e reclamare i suoi diritti di nascita, come fece. Associata a Teseo è anche una clava ricoperta di bronzo, arma che lo caratterizza spesso quando viene ritratto nelle decorazioni su vaso. Ed è con una clava anche che lo vediamo uccidere il Minotaruo secondo un’iconografia antica che ritroviamo ad esempio su mosaici romani.
Egeo, e dunque Teseo, discendevano da Erittonio o da Cecrope (in greco antico Κέκροψ, traslitterato in Kèkrops), i leggendari primi re e fondatori di Atene. Questi erano “autoctoni”, nati cioè dalla madre terra Gea (o Gaia – “ghì” è il nome della terra in griko), e avevano il corpo nella parte superiore, il busto testa e braccia di uomo, la parte terminale del corpo, invece che gambe era in forma di drago, di coda di serpente in particolar modo. Dei re serpente!
La spada era un pegno avuto da Cecrope.
In questo lavoro qui linkato ho parlato del grande masso associato ad Ercole nel Salento, in merito al quale le leggende popolari raccontano di tesori d’oro celati sotto il suo gran masso, recuperabili solo da fortunati prescelti avvisati da sogni premonitori, o dopo particolari riti coinvolgenti capre. Il prescelto cui in sogno la strega buona indicava di andare al Masso, doveva recarsi lì e toccarlo con un dito, al che il masso si sarebbe spostato facendo recuperare il tesoro. Quell’enorme titanico Masso di Ercole, ed altri enormi nei suoi pressi, di origine naturale e a forma di fungo presenta sopra canalette, bacinelle e coppelle scavate dall’ uomo segno di una utilizzazione come ara di quelle strutture naturale molto suggestive per la loro valenza betilica.
Robert Graves indica nella mazza clava un segno regale così come un attributo regale era la spada in epoca antica, un simbolo di regalità, e “il cavar la spada da una roccia pare facesse parte dei riti della incoronazione nell’età del bronzo”. Graves rintraccia questo rito da alcune opere scultore anche nella civiltà ittita in Anatolia; e inoltre aggiunge che “poiché la roccia di Egeo è detta sia Altare di Zeus il Forte, sia Roccia di Teseo, è presumibile che Zeus e Teseo fossero gli appellativi intercambiabili del re sacro che sopra la roccia veniva incoronato”. (Vedi: di Robert Graves “Miti Greci”, Longanesi, 1983).
Si scopre così dai bassorilievi ittiti del santuario di Yazilikaya, in Anatolia, a breve distanza dal sito della capitale ittita Hattusa, che tra i simboli di regalità e divinità anche in quella cultura strettamente legata a quella coeva dei Micenei in Grecia, troviamo la spada, la mazza clavata, la lancia, l’ascia, e per il re simbolo di regalità il “kalmush”, (lituo), un lungo bastone pastorale ricurvo a spirale all’estremità. Anche fronde vegetali tenute in mano compaiono in quei bassorilievi ittiti.

La leggenda di Teseo era indubbiamente conosciuta in ambiente Messapico, sia per i contatti arcaici viscerali e continui, e poi commerciali e diplomatici con il mondo ellenico e ateniese in particolar modo, sia perché una leggenda legata all’ eroe, Teseo, che una antica voce voleva fondatore di Brindisi.
Da questo sostrato culturale poté approdare alla figura dell’Artas messapico e/o poi dell’Artù traslato in Britannia, la leggenda della “spada nella roccia”, tanto emblematica e famosa nel ciclo arturiano. Il padre di Artù, secondo la leggenda letteraria arturiana medioevale, conficca la sua spada saldamente in una roccia, e lì la lascia. Solo chi la estrarrà con le sue forze e capacità, impresa faticosa e difficilissima, potrà rivendicare il suo diritto a regnare sul suo regno. Artù viene allevato dal mago Merlino, non conoscendo la sua origine genetica legata al Re della spada, che era il suo padre naturale. E sarà solo lui, Artù una volta cresciuto e divenuto forte, e nessun altro, a riuscire nell’impresa di estrarre la spada dalla roccia che gli conferisce il diritto a regnare sul regno del padre, e dal cui evento gli viene rivelata la verità sulla sua origine. Esattamente il mito dell’eroe Teseo.
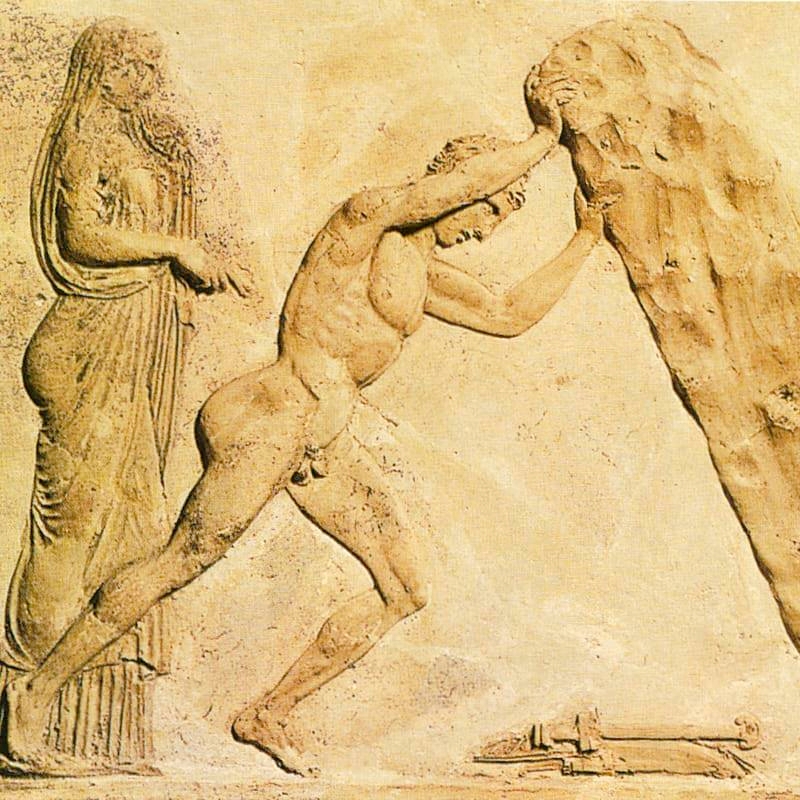
Osserviamo come alla figura dell’eroe Teseo siano legati sia il recupero della spada sia al pari di Eracle una clava come sua tipica arma.
Il mito di Teseo (legato da fonti antiche alla città di Brindisi) vede infatti l’eroe avere come sue armi tipiche tanto la spada quanto la clava. La spada che deve recuperare sotto una grande roccia che deve sollevare, e a cui son legati i suoi diritti regali di nascita e una clava che pare fosse ricoperta di bronzo. Egeo, uno degli antichi re di Atene, si unì con Etra, che rimase incinta di Teseo, Egeo decise di tornare ad Atene ma, prima di partire, seppellì la sua spada sotto un’enorme roccia dicendole che, quando il loro figlio fosse cresciuto, avrebbe dovuto spostare la roccia con le sue forze e prendersi le armi per dimostrare la sua discendenza reale (praticamente lo stesso quasi lo stesso topos leggendario della spada nella roccia di Artù nella saga medioevale).
Un mito quello di Teseo che lega dunque nello stesso personaggio legato ad Atene e a Creta, e non estraneo ai miti ancestrali della Messapia, spade e legno e metallo nello stesso bastone-scettro claviforme. Nella sua iconografia antica consueta è la clava.

Qui la vediamo in questa opera nella forma proprio del bastone clavato in sommità, la paroccola dei pastori italici e pugliesi praticamente e somigliante anche allo scettro di “Rex Arturus” nel mosaico medioevale idruntino. Note sull’immagine: Teseo liberatore, Museo archeologico nazionale di Napoli, (inv. nr. 9043). Da Pompei, Casa di Gavius Rufus. Teseo ha appena ucciso il minotauro riverso a terra nell’ ingresso del labirinto, e viene ringraziato dai giovinetti ateniesi destinati a finire in pasto al mostro, mentre sulla destra il popolo cretese assiste sorpreso all’evento.
Avalon l’isola delle Mele in Salento o nella vicina Albania
E giungiamo, percorrendo questa strada salentina, a valutare la mitica “Avalon” della quale è frequentissimo il ricordo nei poemi arturiani del medioevo. L’ultima dimora di Artù ferito da cui si attende il suo ritorno in piene recuperate forze!

Il primo a far menzione di Avalon è il britannico Goffredo di Monmouth (1100 circa –1155 circa), uno scrittore e storico piuttosto fantasioso, educato in ambiente monastico, e che ne parla nei suoi racconti su re Artù. Morgana, la maga sorella di Artù, riferisce Goffredo, aveva trasportato Artù vivo, ma ferito gravemente dopo una battaglia, nella paradisiaca Isola di Avalon, un’isola descritta come un luogo di delizie. Goffredo di Monmouth cita questa misteriosa Avalon nella sua opera intitolata “Historia Britannicum”, parlando appunto di Artù. In un’altra sua opera, intitolata “Vita Merlini”, così la definisce: “Insula pomorum quae Fortunata vocatur”. Dunque “Avalon”, e il primo a parlarne e chiamarla così è stato appunto Goffredo di Monmouth, era appellata anche “Insula pomorum”, o “Fortunata”. L’isola delle mele, dei pomi, e corrisponde quindi come immagine mitologica alle “isole beate” della tradizione mitologica greca, poste a occidente dove tramonta il Sole e che sono dimora eterna degli eroi; quell’ Occidente dove vi è il giardino delle Esperidi in cui cresce l’albero dai pomi d’oro protetto da un drago, ed Eracle deve raccogliere in una sua fatica proprio quei frutti da quel preciso albero. Grandissime sempre le influenze greche che paion potervisi rintracciare nella saga arturiana. La mela è simbolo antico di rinascita offerta dalla dea al re-sacro, all’eroe greco e latino il cui spirito è diretto nei paradisiaci Campi Elisi, da cui poi rinascerà. Nella tradizione cristiana del sud Italia, e del Salento, ancora forte è l’antica tradizione iconografica della Madonna con Bambino che offre al Bambino Gesù una mela, simbolo della sua resurrezione; è chiamata “la Madonna de lo Melito”; nel Salento poi si coltivano ancora tradizionali vecchie cultivar di melo come la cosiddetta mela di San Giovanni e non solo. Avalon pare potersi ricondurre etimologicamente, tramite radici indoeuropee, proprio alla mela. Alcuni hanno ipotizzato che alla stessa origine etimologia partecipi il nome del dio greco Apollo.
Mi piace qui ricordare che in Albania poco più a Nord di Valona gli antichi greci fondarono una loro importante colonia chiamata proprio Apollonia.
Nel sud Italia ad esempio, il toponimo della città di Avellino, antica “Abella” (in latino“Abellinum”), deriverebbe dal termine indoeuropeo “abel” che vuol dire “mela”; Avellino “la città delle mele” come la definisce Virgilio nell’Eneide (città ricca di mele), a conferma della correttezza di questa etimologia. Dall’ indoeuropeo “abel” derivano i termini indicanti mela nelle seguenti lingue: “aball” nell’ antico irlandese, “apful” nell’antico alto tedesco, “avallo” in gallico. Ora, questo caso toponomastico è molto importante perché permette di evidenziare come aver interpretato ad oggi termini chiave dei cicli arturiani in un sostrato culturale celtico ha comportato il mascherarne le possibili origini mediterranee da area italico-greca, questo perché ondate migratorie indoeuropee hanno interessato i paesi d’Oltralpe e l’Isola Inglese dando luogo alla cultura celtica e a quella tedesca, come anche l’Italia e la Penisola Balcanica, con l’area Illirica e quella Greca, dando luogo, sovrapponendosi al sostrato linguistico mediterraneo precedente, alle lingue parlate in queste terre. E’ così ad esempio che nella lingua messapica troviamo diffusissima la radice “teut-”, che è la stessa di “teutoni”, i tedeschi, della piratesca regina illirica “Teuta” combattuta dai romani, del termine latino “totus”, tutto, nelle lingue italiche, vedi il latino, i “teti”, termine greco che ad Atene designava una classe sociale (quasi sinonimo di plebe), ecc. Tutti termini derivati da una comune radice indoeuropea indicante “popolo” (e da qui anche eventuali divinità etniche del popolo).
E nell’area Salentina, immaginando come stiamo facendo l’influsso della cultura messapica all’origine del mito di Re Artù, vi son località che possono aver ispirato il toponimo Avalon?
La risposta non solo è sì, ma vi son almeno due località che si candidano a pieno diritto a queste valutazioni.
Avalon potrebbe forse identificarsi, o comunque esser stato ispirato, dal celebrato monte Aulon, che doveva essere nei pressi di Taranto, comunque una collina nel Salento (antica Calabria), e cantato dal poeta latino Orazio che lo definisce “il fertile Aulon, amato da Bacco” (Carm., II 6, 18), quindi un luogo legato alla viticoltura, e da altre fonti antiche apprendiamo anche alla pastorizia con produzione di rinomata lana. Un luogo di cui ci parlano le fonti antiche, dunque molto famoso, noto per il buon copioso vino da lì prodotto, ma forse anche per i riti di Bacco, possiamo immaginare, che lì vi si celebravano. Oggi abbiamo perso la corretta ubicazione di questo luogo, ma nel disegno qui si sviluppato dove abbiamo ipotizzato un legame tra Artas e Dioniso Dio del vino in cerimonie locali, (che si svolgevano forse nelle messapiche “feste delle bisbee” o nelle feste chiamate Megalartie), che avevano poi ispirato le antiche narrazioni su Artù e il Graal, questo candidato si rivela interessante. E’ anche dunque un luogo fertile, così come fertile e ricco di delizie è l’Avalon descritto da Goffredo.
Per Aulon, (se non era coincidente con Valona, l’antica Aulona), il caso linguistico di Valona, dall’antico nome Aulona (con un ovvio intermedio “Avalona”), ben pone Aulon, prossimo al termine Avalon. Che fosse un colle pugliese del sud circondato da paludi come un’ isola? Paludi che ben dominavano le piane salentine sia sulla costa, (Arneo, Alimini, Li Foggi, Cesine, ecc.), che dell’ interno, (Paduli-Bosco Belvedere, ecc.), prima delle grandi prosciuganti bonifiche idrauliche disboscanti e spietranti dell’ ‘800 e ‘900 per voracità di terra. Devastazioni cui porre oggi rimedio co vasti interventi di rinaturalizzazione ricostruttiva e resturante il paesaggio storico-naturale.
Altra possibile candidata è proprio la località della città di Valona (antica “Aulona”, conosciuta in antichità come un importante nodo stradale e porto), città costiera dell’ Illiria, dell’Albania, immediatamente prossima a Otranto, oltre il Canale d’Otranto, che è posta sopra un golfo che forma un ampio e sicuro porto. Per tutto il medioevo i pellegrini che usarono l’ “Itinerarium Burdigalense” come guida, dopo la città di Otranto, la tappa successiva di cui leggevano e che dovevano raggiungere, era quella di Aulona al di là del Canale d’ Otranto.
Aulona l’abbiamo già incontrata in questi percorsi di esplorazione intorno ad Artas quando abbiamo parlato della possibile attività militare di quel re messapico contro la pirateria che in antichità aveva una base nell’ Isola di Saseno, che chiude proprio la baia di Valona. Leggendo delle gesta di Artas nell’ Isola di Saseno, (che poteva richiamava per assonanza ad un inglese medioevale i Sassoni), nella baia di Aulona, ne poteva nascere per corruzione l’idea di un’Isola di Avalon?
Una cosa è certa, se l’antica Aulona oggi si chiama Valona, si deve immaginare il passaggio linguistico: Aulona-Avalona-Valona.
Stesso passaggio linguistico che applicato al monte Aulon, avrebbe comportato la trasformazione: Aulon-Avalon.
Da citare anche questo dato. Tra i principali covi pirateschi che Artas avrebbe potuto dover affrontare per sgombrare i mari Pugliesi dalla pirateria vi poteva forse già anche essere, oltre a quello sull’ isola Saseno, anche il covo piratesco noto in tempi antichi sull’Isola di “Melita” in latino, (croato Mljet, italiano Meleda). Cui abbiam accennato sopra. E’ un’isola del Mare Adriatico nella Dalmazia Meridionale, dunque è prossima alla Puglia. Il suo nome suona come l’ “Isola della Mele”, potrebbe essere una coincidenza, ma non possiamo non sottolineare, come è il nome che da Goffredo di Monmouth da invece ad Avalon, che chiama anche l’ “Isola delle Mele”, in latino in cui scrive “Insula pomorum”. Che i testi che ebbero a disposizione su Artos, citassero imprese contro di pirati nell’isola di Saseno nella baia di Aulona (Valona) e nell’ isola di Melita, che poi han ispirato negli scrittori inglesi rispettivamente un re Artù che combatte i Sassoni invasori del nord Europa e che una volta ferito viene condotto su un’isola di Avalon, isola delle mele. Forse quei testi scomparsi raccontavano di re Artas che fu ferito durante quelle operazioni di polizia/pulizia contro la pirateria? E quale fu la fine di Artas? Forse anche lui fu ucciso o fu rapito o comunque scomparse durante quelle operazioni al di là del Canale d’Otranto, da cui il mistero sulla sua scomparsa ispirò gli autori/inventori riciclatori inglesi?
E i Campi dei Beati sono effettivamente rappresentati, sembrerebbe anch’essi, all’interno del mosaico di Otranto nella zona dedicata espressamente, come ben si capisce dagli altri elementi circostanti, alla rappresentazione del Paradiso nella navata di sinistra. Già il Giardino dell’Eden con Adamo ed Eva nudi tra i rami di due alberi a nutrirsi di frutti e giocare, frutti prodotti da quegli alberi a profusione e in gran varietà, è raffigurato a sinistra del tronco del grande immenso albero centrale che si sviluppa per tutta la navata centrale. Eden raffigurato nella parte alta della navata e alla stessa altezza della scena di Artù e il caprone (o capra) e di Caino e Abele, scene che stanno invece tutte queste a destra del grande albero centrale, interpretato come l’Albero archetipo del Bene e del Male e della Conoscenza. Il Paradiso dei Beati, delle anime invece, è raffigurato nella porzione a sinistra del tronco dell’albero centrale che si sviluppa per tutta la navata di sinistra, (stessa struttura con albero centrale si osserva anche per il mosaico della navata di destra). Nella porzione a destra del dritto tronco centrale è raffigurato invece l’inferno. Stesso rapporto simmetrico a quello tra giardino dell’Eden a sinistra e scena di Artù, il felide e il caprone (o capra), e quella di Caino che uccide Abele, a destra, nella navata centrale, con qui al centro, tra le due parti citate, la scena della cacciata dal paradiso di Adamo ed Eva.


Ma torniamo nella navatella di sinistra, e nella rappresentazione del Campo dei Beati, in questa porzione lo spazio è occupato da un ulteriore albero e compaiono due figure umane, una di queste sta seduta completamente nuda a cavalcioni di un ramo che si diparte da una biforcazione a sinistra dell’albero centrale in questo spazio paradisiaco. Essa ha le mani e lo sguardo levati in alto o in riferimento, quasi a presentazione, della persona/anima che sta alla stessa sua altezza e che appare vestita di un perizoma e sta in piedi alla biforcazione del medesimo albero mentre con ciascuna delle mani tiene stretto uno dei rami; questa seconda persona è mostrata di fronte mentre guarda, con espressione tra il sorridente e lo ieratico, davanti a sé, praticamente coloro che transitano sul mosaico. Difficile dire se l’uomo nudo, anche a causa di alcuni danni al volto, ci sta indicando di guardare quello con il perizoma o se forse ci richiama l’attenzione più in alto dove sono rappresentati i grandi patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe del Vecchio Testamento che accolgono nel loro grembo le animelle di coloro che sono giunti in Paradiso, secondo tradizionali iconografie cristiane (il cosiddetto tema del “seno di abramo“). Il patriarca Abramo è più prossimo al centro della navata, quindi alla a sinistra della sua figura vediamo Isacco (figlio di Abramo) e quindi nell’ ordine di parentela, Giacobbe, (“IACOB” si legge nell’epigrafe sul mosaico), figlio di Isacco.
Vien da pensare se quella coppia di due anime nel giardino dei Beati (di dimensioni ben maggiori delle animelle accolte dai patriachi poco sopra), non siano proprio quelle di Artù, l’uomo con il perizoma, e di Perceval quella invece dell’uomo nudo. L’uomo con il perizoma ha una capigliatura che ben somiglio a a quella di Artù nella scena in cui è a terra con il felino che gli morde la gola. Quel felino che poco prima è mostrato mentre gli si stava avventando addosso artigli sguainati e fauci aperte. Una raffigurazione dunque della mitica Avalon di delizie ricca di alberi con frutti, dei Campi Elisi delle anime degli eroi, un’allegoria del Paradiso in terra ripristinato con la scoperta del Graal, allegoria del perdono e superamento del peccato, della Grazia ritrovata, con conseguente e correlata guarigione del re ferito, e ritorno così della terra del re ad esser fertile e produttiva, il ritorno della felicità e del benessere per gli uomini?
Le leggende medioevali che narravano della presenza di Re Artù sul monte Etna
In epoca normanna, dopo la conquista della Sicilia che divenne il centro di potere normanno nel Regno del sud Italia, (regno che includeva anche il Salento, l’ intera Puglia, la Sicilia, la Calabria, ecc., e che rappresentò nei fatti il primo stato “moderno” d’Europa, che durò, istituzionalmente parlando, sino all’Unità d’Italia, pur passando tramite diverse case regnanti di diversa provenienza), si diffusero o comunque iniziarono ad essere registrate per iscritto, diverse versioni di una leggenda che voleva Artù vivente sul monte Etna, in grotte del vulcano, o in un meraviglioso castello in esso. Leggende raccolte lì nei secoli, a partire dal periodo normanno appunto. (Vedi di Arturo Graf, “Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo”, Mondadori, Milano, 1996).
Ad esempio la versione, chiamata del “cavallo del vescovo”, riportata da Gervasio da Tilbury (1155 – 1234?), giurista, uomo politico e scrittore inglese, riferisce la credenza popolare, già dunque comune in Sicilia nei secoli XII-XIII, secondo cui Artù vivrebbe lì sull’ Etna in un meraviglioso palazzo in un luogo di delizie, soffrendo di una piaga dolorosa che si apre ogni anno, (un aspetto che ricorda lo stato claudicante di salute del Re Pescatore/Re Ferito nella storia sulla visione e ricerca del Graal raccontata da Chrétien de Troyes).
Gervasio narra poi un’altra storia, diffusa questa invece in Bretagna e in Britagna (le due Bretagne, come venivano anche chiamate), e dove Artù viene presentato sotto l’aspetto del cacciatore selvaggio, altro noto motivo che pensiamo di poter ritrovare a Otranto nella scena della caccia al cinghiale nel mosaico pavimentale della Cattedrale di Otranto nell’area dell’abside.

E più oltre, ricorda come invece nelle sue terre di origine vigeva, “secondo la volgare tradizione” dei Bretoni, la versione che Artù fosse stato trasportato su un’ isola e come lì Morgana lo custodisse e curasse; (si tratta del riferimento alla leggenda dell’isola di Avalon che bretoni e britanni certo non identificavano con la Sicilia!).
Gervasio fu educato alla corte di Enrico II plantageneto d’Inghilterra (primo re della dinastia plantageneta o angioina), poi a Reims e infine all’Università di diritto canonico di Bologna. Dinastie normanne, normanno-sveve, e angioine, strettamente imparentate tra loro, connotano in quei secoli intrinsecamente i regni del sud Italia e quelli anglo-francesi. Gervasio dunque si muove, e si forma culturalmente, tra il mondo anglo-francese e quello italiano. Appassionato di filosofia naturale, visse in Italia del Sud, alla corte normanna di Palermo, del re Guglielmo II di Sicilia (discendente della famiglia normanna degli Altavilla, sovrano di quel normanno Regno di Sicilia, di cui faceva parte anche l’intera Puglia, la Lucania e il Bruzio). Guglielmo II di Sicilia iniziò a regnare dal 1166.
Ma riportiamo direttamente da Gervasio il passo dedicato ad Arturo sull’ Etna, (passo tratto da “Otia imperialia, secunda decisio“): “In Sicilia è il monte Etna, ardente d’ incendii sulfurei, e prossimo alla città di Catania, (…) Volgarmente quel monte dicesi Mongibello; e narran gli abitatori essere apparso ai dì nostri, fra le sue balze deserte, il grande Arturo. Avvenne un giorno che un palafreno [cavalo da sella, nobile, da viaggio o da parata, non da battaglia] del vescovo di Catania, colto, per essere troppo ben pasciuto, da un subitano impeto di lascivia, fuggì di mano al palafreniere che lo strigliava, e, fatto libero, sparve. Il palafreniere [colui che in passato era adibito alla custodia e al governo di un palafreno], cercatolo invano per dirupi e burroni stimolato da crescente preoccupazione, si mise dentro al cavo tenebroso del monte. A che moltiplicar le parole? Per un sentiero angustissimo ma piano, giunse il garzone in una campagna assai spaziosa e gioconda, e piena d’ ogni delizia; e quivi, in un palazzo di mirabil fattura, trovò Arturo adagiato sopra un letto regale. Saputa il re la ragione del suo venire, subito fece menare e restituire al garzone il suo cavallo, perché lo tornasse al vescovo, e narrò come, ferito anticamente in una battaglia da lui combattuta (…), quivi stesse già da gran tempo, rincrudendosi tutti gli anni le sue ferite. E, secondochè dagli indigeni mi fu detto, mandò al vescovo suoi donativi, veduti da molti e ammirati per la novità favolosa del fatto.”
Mongibello era un sinonimo di Etna, il nome è un composto tautologico di monte e dell’arabo giabal che vuol sempre dire monte (v. gebel) ma in arabo.
Altra simile versione della leggenda popolare del re Arturo sull’Etna la racconta Cesario di Hesteirbach (Colonia, 1180 circa – Heisterbach, 1240 circa), che è stato un abate e scrittore tedesco.
La sua versione, che ritroviamo nel suo “Dialogus miraculorum” è posteriore a quella di Gervasio da Tilbury, ma è sulla falsariga di quella con l’aggiunta di alcuni particolari. Il palafreniere che ha smarrito il cavallo incontra un servo di Artù che lì dice che il cavallo è sul vulcano Etna, “in potere del re Arturo”, e invita il palafreniere a riferire al suo padrone di recarsi lì alla “corte del re Arturo”, entro quattordici giorni altrimenti sarà punito. Così il palafreniere fece ma il padrone (“decano”) al cui servizio egli era, non gli credette, e puntualmente scaduto il quattrordicesimo giorno si ammalò, e morì il giorno prestabilito.
L’interesse per questi aspetti da castigo divino in Cesario di Hesteirbach non meravigliano se si tiene conto che egli fu oltre che storico anche agiografo (dedito dunque a narrare la vita di santi e dei loro miracoli), nonché autore di exempla, un genere letterario diffuso nel medioevo e usato dai predicatori, consistente nel racconto storie paradigmatiche dichiarate come vere in cui il protagonista raggiungeva la salvezza dell’anima.
In queste versioni, troviamo scritto “re Arturo”, il nome e il titolo con cui si indica il re Artù sul mosaico otrantino (“Rex Arturus”).
Altra simile versione, dove si comprende comunque che ci si riferisce sempre a Re Artù date le versione precedenti, anche se qui il nome di Artù non vien fatto e si parla di un generico principe del magico luogo, la riferisce Stefano di Borbone, (Belleville, 1180 circa – 1256). Stefano è stato un religioso francese, e scrisse che la storia che narra la “udii narrare a un frate di Puglia, per nome Giovanni, il quale diceva esser ciò avvenuto dalle sue parti”. Si narra qui sempre di un incontro magico con un re e i suoi cavalieri che avviene sempre sull’Etna, e grossomodo sempre in epoca coeva a quella in cui i fatti venivano narrati. Qui al popolano servo cui capita l’avventura, che ha del magico, di vedere quel “principe”, che praticamente possiamo dire è Artù, questi gli consegna un “nappo d’oro”, da portare al suo padrone una volta tornato nella sua città, perché questi beva della sua bevanda. Sempre dunque il simbolo della coppa d’oro/Graal. Nella vicenda “s’ apre il nappo e ne schizza fiamma; si getta il nappo nel mare e il mare si accende” e quattro uomini “sono rapiti sopra quattro cavalli neri”. Qui sull’Etna quel re vive in una città fortificata dove “per le vie di essa città – vi sono – tanti uomini quanti ne sono al mondo, di ogni generazione e condizione” e il suo palazzo ha tante stanze e lì dove sta lui con i suoi uomini tanti cibi diversi vengono offerti.
Osserviamo poi anche qui comparire un riferimento alla Puglia, e in particolare ad un frate pugliese che riferisce queste favolose narrazione popolari. Troviamo poi la significativa figura di un “nappo d’oro”, e il nappo altri non era che una tazza, un vaso per bere; “nappo” come termine arcaico indicava una tazza profonda e talvolta preziosa o artisticamente lavorata. Esso pertanto ci richiama alla mente proprio quel vaso Graal, coppa d’oro e intarsiati di smeraldi che appare tra le mani del giovinetto nudo e imberbe dalle gote rosse, sul mosaico pavimentale dell’abside della cattedrale idruntina.

Sarebbe interessante approfondire se quel frate Giovanni di Puglia che racconta la leggenda riportata da Stefano di Borbone (XII secolo – XIII secolo) non sia Giovanni da Otranto, detto anche Giovanni Grasso (Otranto, XII secolo – XIII secolo), di cui non mi risulta se fosse un frate, ma è certo che frequentava l’ambiente del monastero otrantino di San Nicola di Casole in Terra d’Otranto, sotto la guida come maestro del monaco intellettuale Nettario (Otranto, 1155/1160 circa – Casole, 9 febbraio 1235). Giovanni è stato un notaio e poeta. Di cultura greco-italica, fu attivo durante il regno di Federico II di Svevia, di cui fu notaio imperiale.
Vediamo il tema archetipo quindi del re che non è morto, sebbene ferito, che è in un luogo paradisiaco ma non del tutto ineffabile, non del tutto trascendentale, e dal quale guarito può ritornare. Questo tema lo vediamo ricomparire qui nella saga di Artù, tanto in quella bretone come in quella italiana, ma lo vediamo riemergere popolarmente anche in epoca medioevale e anche moderna per figure di grandi sovrani che hanno esteso i loro regni sino al sud Italia, come Carlo Magno, Federico II di Svevia (“puer Apuliae” chiamato), Carlo V, sempre anche loro creduti da leggende popolari rinchiusi in monti, non defunti, ma da lì pronti a ritornare.
Il monte è l’archetipo della piramide, dell’Olimpo, che evidenzia la natura semi-divina con cui il popolo guarda sempre al sovrano punto di contatto tra terra e cielo, che sul monte di più si realizza, (vedi per approfondire la mia Teoria T-S).
La grotta nel monte è l’utero della madre terra dove il re viene guarito, rigenerato, dove il re rinasce.
Nel Salento, ad esempio, nelle grotte dove vi son sorgenti sulfuree, a Santa Cesarea Terme lungo la costa del Canale d’Otranto, si immagina che lì la Santa, vissuta in epoca romana, viva ancora nelle viscere della terra, dove talvolta qualcuno sceso nelle grotte, si narra, l’hai miracolosamente incontrata.
Troviamo poi il tema ricorrente dell’animale che permette di ritrovare oggetti e luoghi magici. Nel caso delle leggende di Artù sull’Etna è il cavallo che scappa via. In Salento ad esempio a Parabita un aratro trainato da buoi fece scoprire un cippo-menhir squadrato con affrescata l’immagine della Madonna con Bambino, la Madonna della Coltura detta, per la cui venerazione si costruì una chiesa. A Supersano la leggenda vuol che un principe romano, contagiato dalla peste, assistette alla genuflessione del suo cavallo diverse volte lungo una strada che dal paese di Supersano conduce alla prossima collina (la Serra), e alla terza vota, lì ai piedi della collina, si accorse che dietro un cespuglio di rose sulla roccia vi era l’ immagine della Vergine dipinta in essa. Il principe guarì. Lì oggi esiste la cripta bizantina della Madonna di Coeli-Manna. E dove il cavallo si era genuflesso lungo il cammino lì furono eretti a memoria dei menhir che ancora vi sono, (così la leggenda forse spiegava quei menhir, un po’ come Goffredo di Monmouth spiegava invece, nei suoi scritti, come opera di un incantesimo del mago Merlino il trasporto dei grandi ciclopici massi e la costruzione dei megaliti del famoso protostorico monumento di Stonehenge). Cavali o buoi che trasportano statue o icone di santi che si fermano e non vogliono avanzare e che indicano così il luogo in cui deve rimanere quell’ oggetto sacro o dove lì deve esser costruito un tempio sacro per custodirlo, è un topos tipico nella religiosità salentina e del sud Italia tutto.
Par quasi un’eco di quelle ritualità italiche e magno-greche che si avvalevano di prodigi della natura, e in particolare di animali, sotto la guida di sacerdoti e di oracoli, per scegliere i luoghi in cui fondare una nuova città, il ver sacrum.
Ad arricchimento culturale racconto anche questa altra storia: un pastorello che portava al pascolo il gregge del padre perse tra i rovi il suo temperino, ma nel cercarlo per serendipity scoprì una cripta in cui vi era una icona bizantina della Madonna affrescata sulle pareti, su cui nacque poi un santuario mariano, quello di Montevergine detto, in feudo di Palmariggi, (originariamente chiamata Monte Juzzo, quella altura dove avvenne il ritrovamento delle cripta si chiamò poi Montevergine).
Quell’immenso suggestivo complesso vulcanico dell’ Etna, costituisce anche il monte più alto di tutto il centro e sud Italia. Fu luogo mitopoietico generatore di miti per la sua alta carica suggestiva, e attrattore di miti, fin dai tempi più antichi. Lì per chi giungeva dal mare, terra, acqua, aria e fuoco si incontravano, e persino su quelle pendici ammantate di boschi, il fuoco, la lava incandescente erutta a volte persino tra cime innevate! Un luogo di immensi contrasti, già sacro per la sua natura di montagna dove la terra si innalza come a toccare il cielo. Luogo di grande energia emozionale per l’uomo. E’ da considerarsi pertanto anche una sorta di equivalente del monte Olimpo greco, per le genti italiche, e quindi, nell’ipotesi di un grande re Artù anche a genesi storica meridionale, messapica, (innestato magari anche su una cultura pre-messapica, degli ausoni siculi e morgeti che dagli japigi furono scacciati e costretti in gran parte a trovare rifugio e invadere la Sicilia che da essi trasse il suo nome, in precedenza era chiamata Sicania), non meraviglierebbe se il mito di Artù fosse già spontanemante evoluto nel corso dei secoli nel sud Italia, nel verso di immaginare sull’Etna nell’isola di Sicilia, isola di delizie, una sua divina Avalon!
La fama assunta da Artù nelle due Bretagne, (Bretannia e Britannia di simile cultura e lingua gaelica), veicolata poi direttamente o indirettamente dai normanni, conquistatori del Nord, nel sud Italia, diede nuovo impulso dunque forse e nuova importanza sotto una nuova luce re-interpretativa a relitte leggende locali che avevano mantenuto maggiore filo diretto con l’Artos messapico, il vero primo proto-Artù storico. Un po’ come dall’Inghilterra oggi arrivano dei latinismi di ritorno, parole inglesi si diffondono nella nostra lingua ma che a loro volta derivano dal latino dei conquistatori romani, e che magari riportano in italiano termini latini perduti nell’evoluzione dell’italiano dal latino.
Vediamo quindi una profusione di versioni e di leggende nel sud Italia arricchite e deformate nella macchina popolare della produzione favolistica, ma che deve far riflettere, e in cui vi ritroviamo elementi interessantissimi per l’esegesi e l’ermeneutica del mosaico di Otranto e dei suoi contributi all’evoluzione della storia letteraria di Artù e del Graal, come per i contributi ancor più antichi dati dal sud Italia, (l’Italia storica quindi per antonomasia), e dal Salento per la genesi di questi miti stessi!
Abbiamo già accennato alla forte presenza del mito della Fata Morgana tra Sicilia e l’attuale Calabria, sullo Stretto di Messina per la precisione, là dove già pare gli antichi individuarono l’ubicazione del mito omerico dei mostri Scilla e Cariddi affrontati da Odisseo (Ulisse). Stretto dove lei inganna i viaggiatori coi suoi miraggi ottici facendoli affogare. Sorellastra di re Artù, legata a quest’ultimo da un sentimento di odio e amore incestuoso, fu colei che, mossa da pietà per il fratello ferito mortalmente durante la sua ultima battaglia, ne condusse il corpo nella magica terra di Avalon. Una versione siciliana del mito, tuttavia, narra come la destinazione finale di Artù fu, al contrario, il vulcano Etna, luogo in cui il leggendario eroe pensava di saldare la sua magica spada Exalibur, spezzata in combattimento. Qui fu trasportato proprio da Morgana, ma, innamoratosi di quella meravigliosa e fertile terra, decise di stabilirvi la sua reggia. Anche l’astuta fata fisso la sua dimora in Sicilia, edificando un castello di cristallo nelle profondità marine dello Stretto di Messina. Nella versione letteraria più nota Artù venne sfidato in battaglia da Mordred, il figlio nato dall’incestuosa unione con la sorella Morgana. Ferito gravemente e ormai prossimo alla morte, Artù decise di consegnare la sua magica spada, Excalibur, danneggiata dalla lotta, al cavaliere Lancillotto perché riportasse la magica arma nel luogo in cui era stata originata. Lancillotto gettò, così, l’arma nel lago, ed essa fu ripresa in custodia dalla Dama del Lago nelle profondità delle acque. La versione sicula del mito di re Artù è leggermente diversa. Ci troviamo sempre sul campo dell’ultima battaglia di Artù contro Mordred, ma, anziché ordinare a Lancillotto di gettare Excalibur nel lago, al sovrano morente venne l’idea come abbiamo detto di ripararla, e con ciò si spiega nella fiaba popolare l’apparizione di Artù in zona Etna. Artù viene visto come una sorta di dio-eroe che tiene a freno il vulcano dal distruggere tutto attorno con le sue eruzioni, una leggenda racconta che ancora oggi egli abiti all’intero della sua reggia e si aggiri per i sentieri dell’Etna, da cui si allontana soltanto per portare frutti e fiori siculi in dono ai bambini inglesi. Ma durante le sue assenze il Vulcano ne approfitta per manifestare tutta la sua potenza, sputando lapilli e cenere su Catania, per poi rasserenarsi al ritorno di Artù.
Sempre in connessione alle leggende che vogliono Artù sull’Etna e al mistero di una tale ubicazione in Italia che incuriosiva i poeti rimandiamo all’approfondimento di un poemetto del duecento in volgare italiano di autore anonimo chiamato il “Detto del Gatto lupesco” il cui approfondimento potrebbe rivelare interessanti sorprese: vedi il mio articolo intitolato “Il “Detto del Gatto lupesco” un poemetto del ‘200 ispirato dal mosaico di Otranto e dal mistero su Re Artù in Italia che esso cela?“. Il dubbio sollevato da questa apparizione del mito di Artù e della figura della fata Morgana in sud Italia e Sicilia si rafforzava con un altro dilemma: non solo non si sapeva storicamente che fine avesse fatto Artù, ma sin dagli albori del medioevale letterario ciclo arturiano fu chiaro che la storia dell’Artù bretone era fumosa, senza solide basi storiche, a differenza invece dell’altra parallela famosa saga cavalleresca medioevale, quella di Re Carlomagno e i suoi Paladini, comunque fondata su personaggi realmente vissuti, alcuni se non tutti, che pur nell’epicizzazione e finzione letteraria erano collocabili nella spazio e nel tempo con una certa precisione storiografica. I dubbi si insinuavano negli uomini di lettere, storici, rimatori, giullari, uomini di chiesa, ecc., e forse più d’uno percepì, come anche l’autore del “Detto del Gatto lupesco“, che la soluzione andasse cercata nel sud Italia dove stranamente il mito di Artù e Morgana, che teoricamente doveva esser giunto da poco, dopo la conquista normanna del XI sec. d.C., appariva invece quasi come ben radicato e popolarmente famigliare, stesso dubbio che poi con un’ipotesi più solida verrà esposto dal mago Tafuri qualche secolo dopo (nel XVI sec. d.C.): “In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù – e fosse lo medesimo o un altro de quel Artù Re del Inghilterra nol so“. Ipotesi a cui noi aggiungiamo l’identificazione di quel Re Artù di Terra d’Otranto di cui parla il Tafuri con il Re Artos il Grande dei Messapi antichi salentini ben noto dalle fonti storiografiche antiche!
Artù? Se tutto porta verso la Messapia, ipotizziamo “Re ARTU’ fiabesco di Britannia = Re ARTOS reale di Messapia”
Tanti studi a mio avviso si stanno avvicinando ormai da percorsi diversi sempre più verso la tesi qui avanzata. Innanzitutto quello dei linguisti internazionali che riconoscono l’origine del nome Artù in Italia tra Etruria e soprattutto Messapia (vedi questo post facebook , da cui riporto questo passo “il leggendario nome di Re Artù appare nei primi testi arturiani latini solo come Arthur o Arturus, e mai come Artorius”, o questa pagine sulla voce Artù su Wikipedia);
quindi gli studi del professore milanese Giuseppe Nicolini che pur seguendo un filone di storicità medioevale in Britannia della figura di Artù propone la sua appartenenza ad un ipotetico ordine cavalleresco in cui Artù era una sorta di titolo, inaugurato al tempo dell’imperò romano da un generale legionario, questo realmente esistito come rivelato da un’epigrafe ritrovata nei Balcani (in Dalmazia), di nome Lucius Artorius Castus vissuto tra II e III secolo d.C. che avrebbe comandato delle truppe di cavalieri sarmati in Britannia, nel filone dei quali e della cui cultura in questa teoria si vuole ritrovare l’origine di numerosi elementi della saga del ciclo bretone, contro invece i filoni teorici che la vorrebbero ricondurre ad un substrato autoctono celtico in Britannia. In virtù dei possibili legami del nome Artù e Artorius con la Messapia, il professore Nicolini ha proposto che le origini del generale romano Lucius Artorius Castus affondino in Messapia tramite una possibile gens Artoria sviluppatasi poi anche in seno alla romanità, (aggiungo che in passato grandi erano stati i legami tra Messapi e mondo illirico balcanico). Da tale ipotesi arriva anche in questo parallelamente e indipendentemente dal mio filone di indagine a ipotizzare che il nome della spada Excalibur di Artù discenda dal nome dei Calabri e non direttamente dai Calibi come invece solitamente creduto negli studi della materia arturiana;
e inoltre le teorie di Graham Anderson, professore di studi classici all’Università del Kent, che si è accorto dei notevoli contributi della cultura greca nel mito di Artù, gli influssi del mito di Eracle e Teseo, ma ancor di più egli ritrova le fonti del mito in un personaggio mitologico dell’Arcadia, proprio l’eponimo re Arcade (Ἀρκάς, Arkás). Vediamo innanzitutto come la teoria dell’accademico inglese, che ha esposto in un suo libro dal titolo “King Arthur in Antiquity” del 2009 viene esposta in un articolo sul giornale “La Stampa” il 23 luglio 2004
————
Un mito da riscrivere «Re Artù era un eroe dell’antica Grecia»
A cura di David Keys
LONDRA – E’ una delle leggende più fortunate del Medioevo, è la storia di Re Artù. In realtà, sarebbe molto più remota di quanto si è sempre pensato: è nata nella Grecia antica, oppure in Turchia o in Mesopotamia. Lo sostiene Graham Anderson, professore di studi classici all’Università del Kent, e autore del saggio «King Arthur in Antiquity», con una numerosa serie di prove: il suo studio lega direttamente la mitologia classica con le leggende arturiane del Medioevo, legando così per la prima volta in un tutto unico i grandi racconti epici che caratterizzano la grande tradizione dell’Europa. Anderson ha scoperto due proto-Artù: il primo risale alla Grecia dell’Età del Bronzo, mentre il secondo compare nella Lidia dell’VIII secolo prima di Cristo. «La mia ricerca – spiega – vuole dimostrare che Artù è molto più antico, di almeno un millennio». Il primo è Re Arkas, sovrano del regno di Arcadia, in Grecia: a lui era associata una leggenda che parla di una città, «Il Tavolo», e di un’arma, una clava, nota come Kalabrops. E’ significativo che la spada magica di Artù, Excalibur, fosse inizialmente nota come Caliburnus. Quanto alla città, aveva un grande altare (o tavolo), dedicato a Zeus. Lì i primi abitanti dell’Arcadia avevano deciso di elevare alcuni sacrifici umani in onore del dio, ma Zeus si infuriò e, sconvolto dalla loro crudeltà, rovesciò l’altare e provò ad annegare tutti i suoi fedeli con un diluvio in stile Noè. Arkas (che sarebbe più tardi divenuto Arcturus) e Artù (derivato dal nome latino Artorius e da quello più arcaico Arctus, che significa orso) hanno anche un altro punto in comune: entrambi erano considerati depositari delle conoscenze dell’agricoltura. Ma Anderson è convinto di aver risolto il mistero maggiore, vale a dire le origini mitologiche della famiglia di Artù e della sua regina, Ginevra. Ha scoperto che il proto-Artù dell’Arcadia, Arkas, era figlio di una donna di stirpe reale chiamata «La Più Grande» e «Figlia dell’Uomo Drago». Nelle storie arturiane il re è noto come Artù «Pen Dragon», capo-drago. Inoltre, una delle mogli di Arkas era Ganeira (probabilmente Gwaneira in greco antico): significa «Fantasma splendente» in greco antico, proprio come nel nome scozzese Gwenhwyfar. Altre «declinazioni» di questo nome si trovano in numerose storie medievali, non solo francesi, come Ginover e Guenievre, mentre in Inghilterra gli equivalenti sono Gaynor e Waynor. Il secondo proto-Artù – quello anatolico, vale a dire Re Ardus – era conosciuto nella storiografia greca come «Il più grande di tutti i cavalieri». Il suo nome risulta molto simile alla versione francese di Artù, vale a dire Artus. Come se non bastasse, se uno dei nemici di Ardus era Kerses, uno degli avversari di Artù è Cerses. D’altra parte, la Lidia dell’VIII secolo a.C. era dominata da un sovrano chiamato Myrtilus (il sempreverde), che presenta una serie di straordinarie somiglianze con Bertilak, il Cavaliere Verde del ciclo arturiano. L’uno e l’altro avrebbero incoraggiato un personaggio noto come «Il Falco» a tessere una relazione clandestina con la propria moglie. Sia la Lidia antica che il ciclo medievale arturiano condividono poi il tema della «Waste Land», la terra perdura, un territorio condannato a restare un deserto, finché non venga cancellata una terribile maledizione. Per Artù la possibilità di salvezza è legata alla ricerca del Santo Graal. Ultima prova: la mitica città di Sarras, dove termina proprio la ricerca del Graal, deriverebbe dell’antica capitale della Lidia Xuaris (pronunciata Swarris). Sia gli abitanti della Lidia che i Greci avrebbero ereditato alcuni aspetti dei loro proto-Artù da una serie di leggende mediorientali. Queste storie si sarebbero trasmesse oralmente fino al VII-VI secolo a.C. e sarebbero poi state registrate da vari autori in forma scritta tra il V e il III secolo, e tra questi Erastotene. Furono i Romani – come Plauto e Ovidio – a rielaborarle ulteriormente, finché furono assorbite dai Britanni, che le traghettarono fino all’alba del Medioevo.
————
Graham Anderson ci ricorda ancora che Arcade, re dell’Arcadia è nel mito figlio della ninfa Callisto, ninfa del corteo di Artemide; Callisto, che aveva concepito Arcade per la passione di Zeus che copulò con lei, fu trasformata in orsa prima, e poi fu posta nel cielo nella costellazione dell’Orsa maggiore, a sua volta il figlio Arcade fu trasformato nella costellazione dell’Artofilace, nome che nasce dall’unione delle parole greche arktòs che significa orso e phylax che significa guardiano, il guardiano dell’Orsa, in riferimento alla costellazione dell’Orsa maggiore che è davanti a lui. Nella costellazione dell’Artofilace che è chiamata anche Bootes (o Boote) o Bifolco, nome questo generico quest’ultimo dei mandriani in quanto Arcade viene considerato come fosse anche un mandriano, vi è poi come stella più splendente in tale costellazione la stella chiamata proprio Arturo il cui nome deriva dal greco arktòs che significa orso e ouròs altro termine che significa guardiano. Artofilace il guardiano dell’orso, o meglio dell’orsa dato che si trova alle spalle della costellazione della Grande Orsa.

Nella tavola dedicata a Bootes dall’astronomo Johannes Hevelius nel ‘600 si mostra un uomo che tiene al guinzaglio due cani, rappresentanti la costellazione dei Cani da Caccia, lanciati all’inseguimento dell’Orsa, un ulteriore richiamo al mito che vuol Arcade cacciatore di orsi e proprio della madre che era stata trasformata a sua insaputa in un plantigrado, in un’orsa.
Rimando a questo articolo per un’ottima sintesi degli intricati miti, intricati per il gran numero di versioni diverse, che riguardano Arcade e la madre Callisto prima della loro trasformazione in costellazioni
Inoltre nella medesima tavola Artofilace (Boote), e potremmo dire Arturo (anche se Arturo è il nome solo della stella più luminosa della costellazione considerata), in un solo nome Arcade è raffigurato con una clava, è quella clava che ha portato Graham Anderson, a ipotizzare immagino, che il suo nome fosse proprio quello del bastone che in greco antico si chiamava kalabrops (calabrops) a cui riconduce il nome della spada scettro di Re Artù delle fiabe medioevali Caliburnus/Excalibur.
Non solo, si ipotizza anche che «l’etimologia del nome latino “Artorius” potrebbe essere collegata ad “Arcturus“, forse tramite il popolo italico dei Messapi, che si consideravano discendenti di Arcade e per i quali “Artas” era un nome di re. Graham Anderson».
Indipendentemente dal professor Graham Anderson di cui ho scoperto i suoi studi solo successivamente anch’io ero giunto a ipotizzare un legame tra Caliburnus/Excalibur e il bastone calabrops in greco antico, ma la mia pista partiva da Re Artos re dei Messapi e quindi dei Calabri del tempo nel sud della Puglia, e dallo scettro pomato di Rex Arturus nel mosaico medioevale di Otranto e allo stesso modo partendo da questa mia pista indipendentemente potevo ipotizzare un legame etimologico tra Caliburnus e Calabri, nel verso di un Excalibur da un ex-Calabri e non da ex-Calibi, in questo con convergenza con le ipotesi del professor Nicolini, ma in più con il coinvolgimento del bastone Kalabrops tirato in ballo dal professor Anderson nella sua teoria.
Nella sua teoria alla ricerca di una figura storica che potesse comunque aver influito nella genesi della fiaba di Artù, Anderson propone altri paralleli con miti del Vicino Oriente che potrebbero aver influito sulla costruzione del mito arturiano. Ed in questo ricollegandosi a quel filone di cui appartiene la teoria della “Sarmatian Connection” sposata anche dal professor Nicoletti che ricerca influssi in Oriente per la figura di Artù.
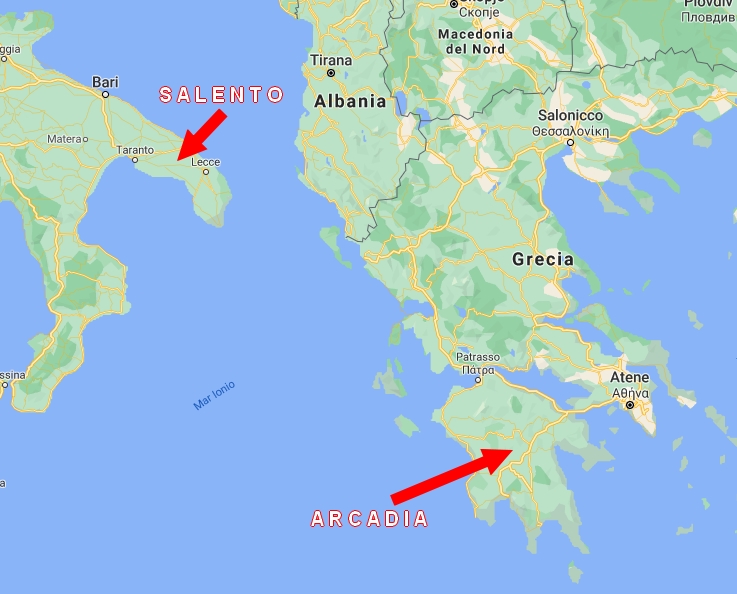
La teoria invece che io propongo sembra quella che troverebbe la quadra rispetto anche ai percorsi di queste tre teorie sopra esposte, quella linguistica sul nome Artù, quella di Excalibur collegata etimologicamente alla Calabria e quella dell’influsso greco arcadico sulla figura di Artù, e infatti gli antichi popoli pugliesi si diceva, secondo alcuni miti, che erano strettamente legati all’arrivo di genti dall’Arcadia, tra i vari contributi etnici che ad essi contribuirono, ne ho discusso anche in questo mio articolo, e la dea Artemide, tanto legata al mito di Arcade e Callisto, era venerata anche dai Messapi. Inoltre per la mia ipotesi trovando anche convergenze inattese con il pensiero di studiosi rinascimentali salentini quali il mago umanista Matteo Tafuri, membro dell’Accademia dei segreti della Natura, e che era stato anche in Inghilterra e Irlanda, nonché discepolo di maestri, come Sergio Stiso, che avevano avuto accesso ai testi della Biblioteca di Casole prima della sua distruzione.

Con questa foto ci richiamiamo ad un mistero nella storia dell’arte quello della epigrafe “ET IN ARCADIA EGO”

Una stupenda foto bucolica che esalta l’importanza pittoresca degli allevamenti bradi lungo la costa salentina del Canale d’Otranto con visibile qui la chiamata “Torre Minervino”. Si vedono in foto pecore di razza di sarda, (ma in zona sono allevate anche pecore di razza moschia leccese), le bianche capre ioniche e capre di altre varietà, (in Puglia è allevata anche la capra garganica nera).
Un meraviglioso scatto realizzato dall’ingegnere Roberto Aloisio e da lui intitolato con la suggestione bucolica al famoso motto epigrafico misterioso “Et in Arcadia ego”, e pensiamo che la regione greca dell’Arcadia non è di fatto troppo lontana proprio da questi luoghi da cui si possono vedere i territori greci e albanesi all’orizzonte, (vi dista l’Arcadia in linea d’aria circa 400 km soprattutto di mare).
Foto mattina del 7 aprile 2019.
Che al di là delle varie spiegazioni (e c’è anche chi l’ha voluta legare al mistero del Graal) è qui per noi una frase non meno enigmatica e suggestiva sui misteri della terra Arcadica e quindi per gli antichi contatti anche della terra Salentina! Un’iconografia che ci fa capire quanta suggestione l’Arcadia abbia esercitato sugli intelletuali europei, pensiamo anche alla nascita nel ‘600 di un circolo poetico a Roma intitolato l’Accademia dell’Arcadia.
Sul discorso di Ginevra quello che invece sottolineo è che il nome mi pare coniato a partire dal termine greco generico “ginecos” (γυναικός) che vuol dire “donna” (in griko “jinèka“).
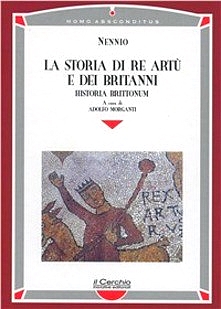
La scelta come immagine percepita più antica e iconica di Artù per la copertina di questa pubblicazione del 2003 del libro di Nennio del IX secolo “Historia brittonum” (la storia di re Artù e dei britanni), prima opera in cui viene citato Artù, proprio del Re Artù raffigurato nel mosaico di Otranto ci trasmette sensazione di una percepita esistenza di un humus nebuloso che collega fortemente misteriosamente il Salento alla figura di quel Re! Un mistero forse proprio dipanabile con l’ipotesi che ispira questo scritto: “Re ARTU’ fiabesco di Britannia = Re ARTOS reale di Messapia”!
I sacrifici umani per costruire fortificazioni solide a Oria in Salento come nella leggenda di Mago Merlino
Partiamo dalla leggenda relativa al mago Merlino. Il personaggio Merlino fu creato o comunque per la prima volta citato dal monaco celtico Geoffrey di Monmouth (ca. 1110 – ca. 1155 d.C.) nella sua Historia Regum Britanniae (1136 EV), dove appare come un giovane saggio e precoce dai poteri profetici. Da questo articolo riporto questi passi che raccontano delle vicende di Merlino raccontate nella Historia Regum Britanniae:
——
Il re Vortigern, l’usurpatore, ha problemi a costruire una torre perché le sue fondamenta non sono solide. I suoi maghi gli consigliano di trovare un giovane del regno senza padre e sacrificarlo, spargendo il suo sangue con il mortaio, cosicché le fondamenta si stabilizzino. Vortigern invia i suoi ministri a cercare il giovane, essi quindi giungono da Merlino. Come racconta la madre del ragazzo, lui non ha un padre mortale, poiché fu uno spirito dall’aspetto umano a ingravidarla.
Merlino viene portato dal re che gli spiega il suo problema e come dovrà sacrificarlo, ma il giovane impassibile gli ordina di portargli i maghi per dimostrare che stanno mentendo. Chiede loro cosa impedisca la solidità delle fondamenta, ma questi non sanno rispondere. Dice allora a Vortigern che sotto di esse troverà un lago, poi gli consiglia di chiamare i suoi braccianti per distruggere le fondamenta. Trovano il lago così come predetto da Merlino, che domanda ai maghi cosa si trova sotto la sua superficie. Per la seconda volta essi non sono in grado di rispondere, allora lui predice che, quando avranno prosciugato il lago, vi troveranno due draghi addormentati, uno bianco e uno rosso, all’interno di due pietre cave.
Merlino spiega il significato dei draghi e predice il futuro. Il drago rosso simboleggia i Britanni e quello bianco i Sassoni, invitati da Vortigern nel proprio regno. Il drago bianco opprimerà quello rosso fino all’ascesa del Verro di Cornovaglia, che caccerà i Sassoni. Questa profezia riguarda Re Artù e la sua futura vittoria contro il popolo nemico.

Particolare dal foglio 43v della Biblioteca di Lambeth Palace MS 6 che illustra un episodio della Historia Regum Britanniae di Geoffrey di Monmouth. I due draghi liberati iniziano a lottare tra loro. Illustratore sconosciuto, c. XV secolo d.C.
Merlino per commemorare una vittoria contro i Sassoni muove le giganti pietre mistiche del Monte Killare in Irlanda fino Amesbury fuori Londra, creando così Stonehenge.

Le pietre di Stonehenge furono importate pare da 240 km di distanza.
Merlino fa un incantesimo per permettere ad Uther Pendragon di unirsi ad una dama che gli concepirà Artù.
——
Il Salento è una terra ricca di monumenti megalitici proprio come la Britannia, vedi ad esempio questo sito web sui megaliti del Salento dolmenhir.it, di leggende sui draghi-grandi serpenti sin dall’antichità, di rappresentazioni di draghi nel mosaico medioevale di Otranto, ma anche di simili leggende di sacrifici umani per i riti di edificazione di fortificazioni.
Vediamo in particolare la molto simile leggenda che si racconta proprio a Oria, città già messapica e sede sulla sua acropoli del palazzo di un basileus di Messapia come sopra ricordato. Per la città di Oria è famoso un detto noto anche a Maglie, il detto è: “Oria fuma e Francavilla guarda”. In riferimento a nebbie/fumi che avvolgerebbero sovente la città posta in collina e che si osservava come avvolta da tale nebbia dalla città poco distante posta più in basso di Francavilla Fontana che invece in quelle occasioni non era avvolta da tale bruma. Vi è una tetra leggenda con cui si spiegava l’origine ed il significato di quella foschia. Secondo la tradizione popolare, fu una madre disperata – alla quale fu strappata la figlia, immolata per bagnare con il suo sangue (così come avevano consigliato gli oracoli) le mura del castello o della città ed evitare così che crollassero – ad imprecare contro il territorio: “Possa tu fumare Oria, come fuma il mio cuore esasperato”, urlò a squarciagola la povera donna. Nacque così la leggenda che ancora oggi gli anziani ricordano con una struggente nenia: “a Oria fumosa ‘ccitera ‘nna carosa, tant’era picciredda, ca si la mintera ‘mposcia” (ad Oria fumosa, uccisero una bambina così piccola che potevano metterla in una tasca).
Leggete anche il racconto riportato in questo post facebook dallo studioso locale Antonio d’Ostuni.
Non molto distante da Oria vi è una seconda collina avvolta da simili leggende, è il Monte dei Diavoli detto in feudo di Manduria. Qui alcune leggende su quel luogo. Altre ne racconta lo studioso locale Pietro Scarciglia: “La leggenda pare abbia alcune stratificazioni successive Nella prima parte si individua un re che per salvare la propria città assediata ( forse riferita all’area archeologica dei Castelli) cede alla divinità infernale il proprio tesoro e la propria figlia. Questa divinità proteggerà quanto ricevuto emanando fumo dal monte per nasconderlo ai passanti (nelle antiche cartografie appare anche come Monte Tremola ed alcuni autori del XIX sec. lo ritenevano un antico vulcano) Nella parte successiva si aggiunge che ci si potrà impadronire del tesoro nel momento in cui all’ostensione dell’ostia sacra si apre nel monte una porta, che ineluttabilmente si richiuderà nel momento in cui termina l’ostensione”. Mi chiedo se non sia un fenomeno meteo di nebbie locali poi entrato nella leggenda, comune con quanto avveniva su un altro monte non molto distante dal cucuzzolo del Monte dei Diavoli a Manduria, ovvero ad Oria di cui è famoso anche a Maglie il detto: “Oria fuma e Francavilla guarda”. In questo studio si parla di tale fenomeno indagandolo geologicamente.

Archita di Taranto il Pitagorico e l’amore ed odio dei Messapi per i Tarantini e i Romani
Il passo dell’umanista Tafuri su Re Artù ci richiama ad approfondire sul pitagorismo. Uno dei più grandi pitagorici della Puglia antica fu Archita di Taranto (Taranto, 428 a.C. – Mattinata, 360 a.C.) che fu “stratego massimo” nella prima metà del IV secolo a.C. della colonia greca di Taranto, proprio nel periodo in cui la città raggiungeva l’apice del suo sviluppo economico, politico e culturale. E’ stato, oltre che politico anche un grande matematico e filosofo, amico di Platone che fu influenzato dal pensiero di Archita che ebbe modo di conoscere personalmente durante un suo soggiorno a Taranto. Appartenente alla “seconda generazione” della scuola pitagorica, ne incarnò i massimi principi secondo l’insegnamento dei suoi maestri. Impegnato nella guida della sua città contro i vicini allora nemici messapi, sulle cui terre i greci di Taranto, provenienti da Sparta, e di stirpe prevalentemente dorica, avevano, a partire dall’ VIII sec. a.C., insediato la loro potente colonia.
L’astio poi nel tempo smussato tra messapi e greci tarantini, dori, come quello tra messapi e romani conquistatori, pare sopravvive in alcuni ormai rari epiteti con valore ingiurioso conservati presso il dialetto griko salentino. Vi troviamo il relitto termine “toro” ( diminutivo “toreddhi”), cioè doro, nome etnico degli spartani colonizzatori di Taranto, colonia magno-greca per molto tempo in forte bellicosa ostilità contro i Messapi, nonostante i continui scambi culturali e commerciali. Dal vocabolario griko-italiano di Mauro Cassoni, (edizioni Argo 1999): “tòro” (doro), “tòruddhi” (dorino), “ratsa toru” (della stirpe dei dori), che si dicevano di persone del luogo che si volevano discreditare come mala gente. Per parlar male di una persona, in griko, si diceva, (questo ancora almeno nella prima metà del ‘900): “ene toro”, “toreddhi”, (è un doro, dorino), “ise toro, torèddhi, mala fides! Ratsa toru, mala fides!”, che significa, misto di griko e latino “sei dorico, razza dei dori, persona di cattiva fede!”. Cassoni pensa che possa essere l’insulto che i romani lanciavano contro i griki, “dori estis, mala fides!”, e che da insulto etnico è divenuto poi insulto locale che egli registrò che era rivolto tra gli stessi griki contro i portatori del cognome “Greco”. Ma non è escluso che modulato su un insulto romano, riprendesse l’astio dei messapi ostili contro gli ellenici di Taranto.
Interessante il fatto che presso la lingua grika si sia conservato e si usi in maniera dispregiativa il termine “rumàno” (romano) per indicare una persona prepotente; e si diceva in griko (questo ancora almeno nella prima metà del ‘900), “aston estèi: e’ sa’ rrumàno – astin estèi: e’ sa’ rrumàna!”, lascialo stare: è come un romano! – Lasciala stare: è come un romano! Così si dice in griko di persona rozza, prepotente, violenta che non conosce altra ragione che la forza; è la sopravvivente valutazione suggestiva degli antichi romani fatta dai griki.
Sembra un relitto rancore dei salentini per l’ assoggettamento della Messapia da parte di Roma, dopo diverse ostilità definitivamente nel 266 a. C., cui seguirono solo alcuni tentativi di rivolta contro Roma nei decenni successivi in terra messapica, in occasione delle campagne militari contro Roma del generale punico Annibale che stanziò in Puglia con il suo esercito cartaginese, e durante le guerre servili che videro la classe degli schiavi ribellarsi contro il giogo romano. Ma come all’odio iniziale verso i tarantini perché si erano insediati da dori colonizzatori in terra messapica adottando un dio locale pare quale eponimo Taras, seguì poi un’alleanza in chiave anti-romana, così all’iniziale odio verso i romani seguì poi una piena integrazione come rivelato dalla figura del poeta Ennio di Rudiae.
Questi elementi insieme a tantissimi altri della cultura popolare salentina, come della lingua, usi e costumi, mostrano l’ esistenza di un filo conduttore comune ininterrotto localmente di tradizioni che si sviluppa con continuità senza cesura attraverso il tempo, dalle epoche protostoriche e classiche, attraverso il medioevo sino ad approdare ai nostri giorni. Una terra che ha ricevuto apporti anche di genti e culture dall’ esterno ma che hanno sempre incontrato un sostrato locale con il quale si sono fuse.
Questi dati dal “Vocabolario griko-italiano”, dizionario dei lemmi griki raccolti e studiati da Don Mauro Cassoni (Norma, 1877- Lecce, 1951), “papa Mauro” chiamato nella Grecìa salentina, monaco benedettino cistercense, studioso di antichità classiche e da sempre interessato a problemi di carattere linguistico, storico ed archeologico, che si innamorò della Grecìa. Durante i 25 anni di apostolato (1928-1951) esercitato a quotidiano contatto con la popolazione della Grecia salentina, attraversò in lungo e in largo l’area grecanica carpendone i segreti e comunicando con la gente in griko. Vi scoprì una cultura ed una lingua ancora viva sulle labbra del popolo minuto, quel dialetto greco un giorno parlato nelle antiche, gloriose colonie della Magna Grecia. “Miliso grìca, miliso grìca” parla greco, parla greco, esortava Don Mauro la gente del Salento per non perdere la locale tradizione. Cassoni sposò la teoria del glottologo tedesco Rohlfs, che trovò nei dialetti grecanici del sud Italia degli arcaicismi riconducibili al greco antico, e dei dorismi presenti nel nostro griko salentino, e che pertanto sosteneva l’ origine magrogreca dalle colonie greche dell’ Italia meridionale. Una lingua che grazie poi alla presenza greco-bizantina medioevale, ancor più poté conservarsi e tramandarsi in condizioni di bilinguismo con il dialetto romanzo.
Mi piace anche qui ricordare come in territorio salentino è stata ritrovata un’ epigrafe messapica con inciso il nome proprio AMOR, pare da leggersi correttamente nel verso apposto, ROMA, probabile nome locale di donna; risale alla fine del V o inizi del IV sec. a. C. e pare essere la più antica attestazione epigrafica, ad oggi rinvenuta, della base del termine! (Vedi per l’epigrafia messapica di Ciro Santoro, “Nuovi studi messapici”, I-III, Congedo Editore, Galatina, 1982-1984).
Tornado alla figura del pitagorico Archita, egli fu anche inventore di un giocattolo per bambini, la raganella, che è ancora in uso e spesso si vede nelle fiere popolari di giocattoli nel Salento, con il nome di “trozzula”. Nella forma originaria era costituita da una piccola ruota dentata fissata ad un bastoncino che si faceva rotare. Sulla ruota, da dente a dente, saltava una asticella lignea fissa ad un pezzo di legno libero di ruotare intorno al bastoncino. Da questi salti da dente a dente si produceva un suono. In Italiano è chiamata raganella per il suono che ricorda quello delle rane. Si suona ancora nel Salento nelle celebrazioni del Venerdì Santo, quando le campane son legate e non possono suonare, se non nella domenica di pasqua per riannunciare la resurrezione del Cristo dopo la celebrazione e ricordo della sua passione e morte per crocifissione sulla sacra Croce, il bethilos e simbolo per eccellenza del cristianesimo. Simbolo in realtà già diffuso nel Salento in epoca minoica-micenea come disvelato dagli scavi archeologici più recenti (vedi decori sui dischi d’oro trovati nella grande fortificata città dell’Età del Bronzo di Roca Vecchia, legata fortemente a Creta minoico-micenea).
E il simbolo del cerchio crociato, già minoico e miceneo, lo ritroviamo disegnato in calce bianca nella tradizione dei molteplici simboli che si raffiguravano, anche in epoca recente, sul cono dei trulli, uno per trullo, nell’area delle Murge e in Valle d’Itria, nel centro della Puglia. Lì anche la svastica tra questi, simbolo che ritroviamo anche su vasi dell’ Età del Bronzo in Salento, e su vasi messapici dell’ Età del Ferro. Tra questi simboli sui trulli, anche ovviamente la croce (tra cui quella greca a braccia uguali e quella latina con il gambo più lungo).
Ma anche Archita saggiamente sottolineava l’ importanza della natura per l’economia di un paese e spesso ricordava loro ai tarantini che il dio Apollo non concesse altro a Falanto, l’ eroe mitico fondatore di Taranto, che fertili campi e amava ripetere: « Se vi si domanda come Taranto sia diventata grande, come si conservi tale, come si aumenti la sua ricchezza, voi potete con serena fronte e con gioia nel cuore rispondere: con la buona agricoltura, con la migliore agricoltura, con l’ottima agricoltura».
TARAS e ARTAS nomi ricorrenti nell’epigrafia messapica sono uno la metatesi dell’altro?
TARAS e ARTAS nomi ricorenti nell’ epigrafia messapica. Il toponimo TARAS compare anche sulla Mappa di Soleto, la più antica mappa geografica occidentale proveniente dall’antichità classica, incisa su un piccolo frammento di un vaso attico smaltato di nero (un ostrakon), risalente al V secolo a. C. e ritrovata nella messapica Soleto;

in essa si mostra il profilo del basso Salento e con dei punti son ubicate le principali città indicate con i loro nomi di solito abbreviati, e nel golfo di Taranto, si indicano le onde con delle linee a zig-zag e il toponimo TARAS.
Taras era un nome e personaggio mitico della cultura messapica, pare, che i Dori giunti da Sparta adottarono come loro eponimo.
“Falanto, ecista messo a capo della colonia che doveva migrare da Sparta, si recò a Delfi per interrogare l’oracolo di Apollo sul da farsi, l’oracolo per mezzo della Pizia, come dice Plutarco (Mor.407f-408a), oltre ad indicare il luogo di destinazione, poteva anche fornire informazioni preziose per riconoscere i luoghi, indicare i momenti propizi per le imprese, sacrifici da fare alle divinità del luogo, il modo di trovare le sepolture degli eroi avventuratisi in precedenza in quelle terre lontane. L’oracolo secondo le fonti antiche fu chiarissimo, testualmente disse:
“ ti do da abitare Saturo e la ricca Taranto
e sarai il tormento degli Japigi”.
(Antioch., ap.Strab., VI, 3,2)
Nessun vaticinio poteva essere più propizio, il dio gli prometteva addirittura la conquista di Taranto, la più grande città degli Japigi, ricca di ogni ben di dio, di un porto naturale e di un mare interno dove poter pescare tutto l’anno al riparo da qualsiasi burrasca.
Naturalmente questi vaticinii sono in gran parte ricostruzioni posteriori agli avvenimenti, il riferimento agli Japigi lo si comprende tenendo conto dello stato di continua conflittualità che caratterizzò la vita della colonia con la popolazione indigena, dalla conquista in armi della città alle grandi battaglie del quinto secolo, che videro i Tarantini due volte vincitori e una volta, nel 473 a.C., terribilmente sconfitti insieme agli alleati Reggini, la più grande strage subita dai Greci ad opera di un popolo barbaro, come ebbe a dire Erodoto (VII 170,3).
Non altrettanto chiare, addirittura scoraggianti, fuono le indicazioni per riconoscere il luogo: doveva trovare Saturo, l’acqua limpida del Taras, un porto e fermarsi dove un capro bagnava la punta canuta della barba nel mare.
Malgrado queste incertezze, dopo aver eseguito i sacrifici di rito e aver dedicato una statua ad Atena vergine, partenos, della quale portavano anche essi il nome, si imbarcarono.
Dopo un viaggio lungo e travagliato, pare che dovettero anche prendere terra in Arcadia, dando forse nome al monte Partemio, raggiunsero l’Italia, dalle parti di Taranto trovarono un fiume e in riva un fico selvatico (profico) con avvolto un tralcio di vite che toccava l’acqua.
Supponendo che il fico fosse il capro con la barba predetto dal dio, perché in greco si chiama tragos il capro eepitragos il tralcio, pensarono di essere arrivati.
Erano in Messapia e trovarono gli abitanti ostili” (passo tratto da questo articolo).
Non ci interroghiamo qui sull’origine etimologica del nome TARAS, ma non si può non sottolineare come esso corrisponda nei fatti al termine che si ricava per metatesi da
ARTAS, AR – TA – S, TA – AR – S, TA – RA- S, TARAS
Come nella parola “capra”, che nel dialetto salentino diventa talvolta “crapa”, CAPRA, C – AP – RA, C – RA – AP, C-RA-PA, CRAPA.
I nomi forse più importani e famosi di tutta la Messapia, ARTAS e TARAS, erano quasi “magicamente” costituiti dallo stesso numero di lettere, ed erano l’uno l’anagramma dell’altro!
Un particolare che non poteva non colpire la fantasia antica dei Messapi.
Il nome Taras (Taranto), è poi particolarmente importante per tutta la cultura salentina ed italica, ad esso è legato il nome della Taranta, l’ insetto aracnide, il ragno mitizzato il cui morso, “pizzicatura”, fa diventare il malcapitato o più spesso la malcapitata una posseduta dallo spirito della Taranta, che cade in trance, divenendo “tarantolata”, “tarantolata”. “Tarantata” come si dice in vernacolo salentino. Da qui i riti, quasi dionisiaci, iatromusicali e ritualizzati del tarantismo. Da qui i balli e le musiche chiamate “tarantella” nel Regno di Napoli, e il nome della “pizzica-pizzica”, ballo+musiche di corteggiamento salentino, e il nome della salentina “pizzica-scherma” dato alla ritualizzata arte marziale detta “danza delle spade”, competizione dove due contendenti di solito nel cerchio “ronda” di persone, al suono di tamburelli e altri strumenti, (ronde come nei riti del tarantismo, e come per la pizzica pizzica), cercano di colpirsi tenendo le mani a mo’ di aculei, a mo’ di coltelli.
Nel tarantismo sono stati ben riconosciuti elementi propri della religione e delle ritualità dionisiache antiche, il furore, la possessione da parte del dio (Dioniso con l’ebrezza provocata dal vino, la Taranta con il veleno inoculato), il ballo, lo stato di estasi-trance, l’uso del tamburello (cembalo), l’altalena o corda appesa cui dondolarsi usata tanto dalle baccanti quanto nel tarantismo, ecc ecc.
(Vedi “Il mito del Tarantismo” di Pierpaolo de Giorgi, Congedo Editore, Galatina, 2008 e “La terra del rimorso” di Ernesto de Martino, Il Saggiatore, Milano, 1991).
Il ragno è poi legato al mito di Aracne e quindi di Atena/Minerva dea fortemente venerata in Salento.
Pertanto il tarantismo connotato etimologicamente da un riferimento al dio locale Taras, già rappresenta una evoluzione locale su connotati autoctoni del più generale culto dionisiaco diffusosi in Grecia e in sud Italia.
Immaginiamo pertanto che lo stesso sia avvenuto nelle Megalartie in Messapia, fusione da un lato della ritualità dionisiaca dall’altro di elementi autoctoni legati ad Artas e in parte anche forse derivati da contributi arcadici.
Se poi si osserva che Artas e Taras paiono in qualche modo esser termini che almeno foneticamente si richiamavano poiché l’uno metatesi dell’altro e viceversa, la suggestione e il rispetto con cui oggi guardiamo al tarantismo, e ai suoi riti che prevedevano anche l’uso delle spade si accresce ancor di più.
E’ indubbio che legami profondi vi siano dunque tra le divinità messapiche, i loro nomi, la toponomastica, e questo misteriosa e mitica creatura filatrice, il ragno chiamato “Taranta”, che vive nei campi del Salento dove pungeva gli uomini e le donne, “a mmenzu all’ anche” recita una canzone, evidenziando simbolicamente le valenze sessuali e di fecondità presenti nei riti del tarantismo, in quei campi dove crescono le spighe e i grappoli d’uva che talvolta mostra in mano il giovane Taras sulle monete, Taras il dio che talvolta tiene in mano la conocchia, simbolo della filatura e della tessitura. Ma non manca mai di raffigurarlo nudo sulle monete tarantine a cavallo di delfino:

Il medesimo motivo degli uomini a cavallo di un grosso pesce (o delfino) lo troviamo anche effigiato sul mosaico di Otranto:

Nel Salento popolare l’insegnamento morale del Graal
Il grande insegnamento della storia di Chetrien del Graal, è quasi quella dell’oraziano “carpe diem”, del cogliere l’attimo, e del non farsi troppo bloccare nell’azione da imposizioni esterne. Del cristiano ed evangelico insegnamento di Gesù del “chiedi e ti sarà dato”. Dell’ importanza della parola e del suo potere. Così alla vista magnifica del corteo del Graal, il giovane inesperto ed impacciato, Perceval, non domanda di cosa si tratti, cosa è il Graal, a chi serviva il Graal, pur provandone l’impulso, e la curiosità. Ed è così che lo smarrisce e non può più ritrovarlo!
Un topos leggendario questo che ritroviamo in alcuni racconti popolari ancora vivi nella tradizione orale dei salentini. Ad esempio, nel feudo di Cutofiano, nella contrada rurale chiamata “Castieddhi” (i Castelli), si racconta di un pastorello che portava al pascolo un gregge di capre, che vide da un foro nella terra emergere una luce, si infilò in quell’apertura e si trovò in una grotta con un enorme tesoro scintillante d’oro e di altri preziosi. Fu però a quel punto preso dal senso del dovere, e dalla preoccupazione di non lasciare troppo a lungo incustodite le sue capre, così si disse di ritornare al suo gregge per poi con calma tornare nel luogo a recuperare il magnifico tesoro, l’ “acchiatura”, come tali tesori son chiamati in vernacolo locale. Così fece, ma tornato poi in seguito al tesoro per recuperarlo, l’apertura non c’era più, e non c’era più alcuna grotta … il tesoro magico era svanito per sempre!
E singolare poi il riferimento alle capre, ed una capra compare sempre nel Salento in merito al racconto dell’acchiatura associata ad alcuni massi megalitici in feudo di Giuggianello. Si dice in quei luoghi che se si prende una capra, la si porta in una chiesa consacrata e le si fa mangiare un’ostia benedetta, le si impartisce dunque la comunione, e quindi si va nei pressi del grande e famoso masso detto “Lettu de la Vecchia”, ci si potrà lì impadronire dell’acchiatura, (dove probabilmente aggiungiamo bisognerà scavare per trovarla o dove semplicemente l’ “acchiatura” apparirà magicamente, secondo le due alterne possibilità nei miti dell’ “acchiatura”); acchiatura consistente in questo caso in una chioccia d’oro con 7 pulcini tutti d’oro, si racconta!
Alcuni dati sulla città di Otranto e i flussi di pellegrini
Otranto fu un centro molto importante sotto l’ impero bizantino, anche per la sua posizone gografica. E’ nel punto d’Italia più vicino alla penisola Balcanica. In epoca romana, costituì un punto strategico non solo commerciale ma anche per tante operazioni militari. I Cesari d’Oriente, dopo la divisione dell’impero romano, fortificarono e abbellirono la città di Otranto. Secondo il politico, letterato e storico Cassiodoro (485 circa – 580 circa), Otranto fin dal V secolo d.C. Otranto ebbe un recinto di mura così esteso tanto da essere chiamata “la rocca delle cento torri”, una delle quali denominata “la torre del Centauro”; A. De Feraris detto il Galateo, nel suo “Liber de situ Iapygiae”, Basilea, 1558, a pag. 48), la diceva esistente ancora nel XVI secolo d.C.
Alla fine della guerra gotica, i Bizantini intensificarono le strutture di difesa della città, proseguendo in varie fasi; prima, nella lotta contro i Longobardi, poi nell’845 contro i Saraceni che, guidati dal condottiero Saba, saccheggiarono la città distruggendo mura e castello. Proseguendo fino alle soglie dell’anno Mille, ed oltre; cioè fino all’occupazione normanna. La cerchia muraria era ritmata da torri quadrate con la cittadella, (detta impropriamente castello), situata nel punto più strategico, cioè verso il mare (Da A. Antonaci Otranto. Cuore del Salento, Editrice Salentina, Galatina, 1976).
Durante la dominazione Normanna, Roberto il Guiscardo, nel 1081 munì questa città di altre bastite, e ne riadattò il castello.
In epoca bizantina, Otranto fu pertanto una delle principali porte di accesso nel Salento, e in tutto il sud Italia, anche per il monachesimo orientale e quindi per i monaci basialiani, che nel Salento edificarono chiesette, e scavarano laure e chiesette ipogee, che affrescarono con icone bizantine.
Pellegrini e mondo clericlare il nastro trasportato dell’ antichità medioevale, e non si dimentichi che anche i primi normanni che giunsero nel sud italia, erano pellegrini diretti a roma ed in terra santa, e lì ebbero modo di vedere le richezze del medietraaneo e da lì portarono in patria questo e da lì partirono er la conquista del sud italia e poi delle crociate, al servizio del papa che ne capiì la valenza in un do ut des tra loro ,
Ma Otranto fu porta di passaggio per tutto il medioevo anche per i Pellegrini sull’asse delle due città sante più importasnmti della Cristianità cui era immancabile fare tappa, Roma e la Terra Santa con Gerusalemme, passando per Costantinopoli.
E proprio da Otranto si prevedeva il passaggio, in quella che fu una delle più importanti guide per pelegrini del medioevo, che dava informazioni utili per il viaggio. Si tratta dell’ “Itinerarium a Burdigala Jerusalem usque et ab Heraclea per Aulonam et per urbem Romam Mediolanum usque”, usualmente noto come “Itinerarium Burdigalense” o “Itinerarium Hierosolymitanus”, è il più antico racconto conosciuto di un itinerario cristiano. Fu scritto nel 333-334 d.C. da un anonimo pellegrino durante il viaggio da Burdigala, l’attuale Bordeaux, fino a Gerusalemme, dov’ era diretto per venerare il Santo Sepolcro.
L’autore dava una descrizione dei luoghi dei luoghi della Terra Santa, annota le più importanti città toccate, ma anche le mansiones (centri più piccoli muniti di locanda) e le mutationes (luoghi intermedi deputati al solo cambio dei cavalli), indicando per ciascuna tratta la distanza in miglia, tramandoci i toponimi adottati in quel periodo per definire città e località minori lungo il percorso.
Vi si evince ilbuono stato in cui versava ancora nel IV secolo la viabilità consolare romana.
Il percorso di andata si snodava dapprima in Gallia, quindi si attraversavano le Alpi e proseguendo lungo la Pianura Padana si giungeva poi nella Valle del Danubio, e da qui verso Costantinopoli, da qui si attraversava la Penisola Anatolica e la Siria, giungeva finalmente a Gerusalemme. Il ritorno seguiva un percorso diverso che da Costantinopoli passava lungo la romana Via Egnatia che attraversava la Macedonia fino ad Aulona (Valona) nell’odierna Albania sul Canale d’Otranto; quindi, dopo l’attraversamento del mare e lo sbarco a Odronto (Hydruntum, Otranto), si proseguiva lungo la via Traiana Calabra fino e quindi la via Appia fino a Roma, per risalire poi lo stivale fino di nuovo in Gallia. Un percorso alternativo prevedeva il viaggio via mare da Gerusalemme a Pisa.
In griko salentino Otranto è chiamata Derento, e Lecce, l’antica Lupiae, è chiamata Luppìu. Il griko è una banca linguistica di conservazione di antichità!
“Aulona” dunque una città ben nota ai pellegrini europei che volevano raggiungere la Terra Santa. Nel testo è accompagnata dalla parola “milia”, e dal numero di miglia che la separavano da varie località riportate.
Un ruolo, quello di Otranto, che divenne ancora ovviamente più importante quando al pellegrinaggio devozionale, si aggiunse quello militare delle Crociate tra l’XI e il XIII secolo d.C., e quindi dei cavalieri che combattevano sotto il segno della croce per liberare la Terra Santa dai musulmani invasori.
Luoghi che i pellegrini attraversavano sostando e vedendo e portando in patria conoscenze, emozioni, suggestioni, saperi appresi.
Può essere importante anche ricordare che il Salento ospitò nel medioevo delle comunità di ebrai, (di giudei anche chiamati), una di queste, uno delle più grandi importanti e floride proprio a Otranto. In particolare, l’importanza della comunità di Otranto è dimostrata da quanto fra i dotti ebrei europei si diceva: “da Bari esce la legge e la parola di Dio da Otranto”, questo detto ci è stato tramandato dal famoso rabbino francese del XII secolo, Rabbenu Tam, (i rabbini sono i dotti maestri di cultura ebraica guide spirituali per le comunità dei figli di Israele). Dunque Otranto era un fiorente centro per gli studi religiosi ebraici. La presenza di ebrei nel mezzogiorno d’Italia risale già all’epoca romana repubblicana. In Puglia per alcune comunità si ha documentazione della loro esistenza con continuità da epoca romana imperiale sin all’epoca normanna. Comunità sovente floride, dedite in particolar modo al commercio e alla attività finanziaria, delle quali spesso nei centri pugliesi resta attestazione nel toponimo urbano di alcuni quartieri detti ancora “giudecca” (ad esempio a Gallipoli, come nel centro storico di Manduria, Oria, Brindisi), o di strade chiamate con nome legato a “Giudecca” (ad esempio a Seclì e Alessano), o altri toponimi correlati come a Lecce “via della Sinagoga” (sinagoga è il nome del tempio sacro per gli ebrei), e il rione cosiddetto “te li pili bianchi” in riferimento alle barbe bianche delle persone ebree.
I rapporti tra cristiani e comunità ebraiche che tradizionalmente si rifiutavano di convertirsi al cristianesimo furono sempre molto tesi, ma non è escluso che tra i dotti delle comunità cristiane e quelli delle comunità ebraiche vi furono, ad Otranto, e più in generale nel Salento, dei momenti di incontro e scambio culturale.
La caccia al terribile cinghiale di Artù, relazioni con il megalitismo e gli influssi classici
La caccia al terribile cinghiale, che racconta Nennio per Artù, ci richiama alla mente la caccia al temibile cinghiale di Erimanto, un poderoso e ferocissimo cinghiale che viveva sul monte Erimànto e che terrorizzava tutta la regione, fu vinto e catturato dall’eroe greco Eracle (Ercole per i latini) in una delle sue “fatiche”. Un motivo mitologico erculeo, quello della caccia e della vittoria sul terribile cinghiale, che ritroviamo quindi proprio nella saga di Re Artù, nelle fonti letterarie medioevali più antiche che lo riguardano, quanto nel mosaico idruntino.
Così anche il mito della caccia al cinghiale di Calidone o calidonio detto, un cinghiale di straordinaria possanza flagello mandato dagli dei irati perché distruggesse i campi nell’area della città greca di Calidone, nella regione balcanica dell’ Etolia, e che vide l’organizzazione di un’epica battuta di caccia a cui parteciparono i più grandi eroi ed eroine di Grecia, la “caccia calidonia” in cui la mostruosa bestia trovò la morte. La caccia fui voluta dal re Oineo (Eneo) di Calidone, cui si lega la scoperta della produzione del vino. Il cinghiale era stato inviato da Artemide a distruggere i campi di Calidone perché Oineo era venuto meno nelle offerte votive. Per liberarsi della belva, Oineo organizzò una caccia in cui chiese la partecipazione di quasi tutti gli eroi del mito greco. Interessante la comparsa di Artemide, ma ancora più il possibile medesimo nucleo mitico dei suini che distruggono le vigne, da qui la necessità della loro caccia per abbassarne il numero. Un aspetto che arricchisce di valenze legate al vino la presenza nel mito arturiano/graal della caccia al cinghiale.
E la caccia al grosso cinghiale è tema ricorrente nel mito greco, e impresa venatoria di iniziazione per i giovani e per gli eroi, vedi anche Ulisse (Odisseo). (Vedi: di Robert Graves “Miti Greci”, Longanesi, 1983). Dal racconto omerico apprendiamo che, impegnato nella caccia al cinghiale da giovane, (caccia che per i giovani achei aveva certamente anche un valore di superamento di prova iniziatica per divenire adulti), fu gravemente ferito ad un’ anca, riportandone una indelebile cicatrice tramite la quale però fu riconosciuto da una sua domestica, quando sotto le protettive sembianze di un vecchio vagabondo, fece ritorno al suo palazzo di Itaca insidiato dai “proci”, aspiranti al suo trono, tramite il diritto che gli sarebbe venuto dalla mano della sposa di Ulisse, Penelope, dal suo talamo cui ambivano, prima che Ulisse ne riportasse la giustizia sterminandoli! Ulisse aveva una ferita alla gamba infertagli dalla zanna di un cinghiale durante una battuta di caccia.
Anche Teseo, si narrà nel mito delle sue fatiche, cacciò e uccise una terribile scrofa a Crommio, la quale aveva fatto tali stragi che la gente del luogo non osava più uscire di casa o per lavorare nei campi; i mitografi Igino e Ovidio presentarono la scrofa come un cinghiale, Plutarco invece la descrive come una donna che per il suo vergognoso comportamento si meritò il soprannome di “scrofa”. E’ importante far rilevare come nel mosaico pavimentale dell’abside a Otranto il cinghiale femmina appare nei pressi della donna nuda dalla lunghissima treccia distesa che appare come quasi masturbarsi davanti alle porte di un castello, (molto probabilmente è la fortificata città di Ninive, e si vuol indicare che le è all’interno), o forse si copre le nudità mentre fuggono via due uomini nudi che stavano facendo sesso promiscuo con lei (vedi per approfondire questo mio articolo). La scrofa, nel mito antico, era anche associata alla dea madre greca Demetra, venerata anche dai Messapi (che la chiamavano anche “Damatra”), che nel santuario, che si ritiene da studi archeologici essere a lei dedicato, in località Monte Papalucio a Oria, riceveva in sacrificio proprio dei maialini sacrificati, e altri in terracotta lì lasciati in offerta come degli ex-voto. Tipico sacrificio nel mondo antico alla Dea Demetra e a sua figlia Persefone era quello di gettare dei maiali in delle voragini naturali o comunque dei “bothroi” dei baratri, fosse nella quale si versavano libazioni e altri sacrifici.

Caccia al cinghiale con cani e lancia la troviamo in bassorilievi, dipinti e mosaici romani e greci antichi, e anche medioevali in tutta Europa.
Il monaco Nennio nella sua opera “Historia Brittonum” del IX sec., nella sezione “de mirabilibus britanniae”, una raccolte di meraviglie della Britannia, “miracoli” tratti soprattutto dal folklore popolare locale, scrive che nella Terra di Builth, in Galles, vi era un cumulo di rocce (“cairn”), di cui l’ultima presentava l’impronta di una zampa, lasciata dal cane di Artù Cafal/Cabal/Cavall su una roccia, quando andarono a caccia del potente cinghiale Troit. Artù allora la poae in cima ad un mucchio di pietre e creò così il Carn Cabal. Artù è descritto come “il soldato”, non come re da Nennio, che ne evidenzia il suo valore sempre di eroe militare, anche nella diplomazia possiamo dire dato che riunì più re britanni di cui era capo in battaglia contro i Sassoni come Nennio racconta.
Se la pietra veniva spostata, scrive il monaco, tornava sempre, misteriosamente, al suo posto la mattina seguente. Cabal, il cane di re Artù, crea una meraviglia mentre insegue il cinghiale qui chiamato Troynt: lascia la sua impronta su di una pietra.
Troit ricorda “troia”, il nome della femmina del cinghiale e del maiale, la scrofa. Il termine è presente nel latino medievale, forse voce onomatopeica espressiva che ne imita il grugnito. Non a caso uno stemma della città nel nord della Puglia chiamata Troia era raffigurata inizialmente una scrofa, che allatta sette porcellini. Da qui l’uso del termine Troia per indicare donna di facili costumi, propensa al sesso sfrenato, ninfomane. Il cinghiale maschio si chiama verro. Anche la femmina ha zanne e può essere molto aggressiva soprattutto se ha la cucciolata di cinghialini da difendere. Non è forse un caso allora che tale cinghialessa appaia nel mosaico idruntino nei pressi della donna nuda, dalla lunghissima treccia distesa che appare come quasi masturbarsi o colta in flagrante durante un orgia con due uomini, nella fortificata città di Ninive. Nella sua prima apparizione nella “Historia Brittonum” il cinghiale si chiama “Troynt”, prima di subire ulteriori deformazioni ad opera dele lingue locali di area britannica. Ma per capire il metodo di indagine errato ad oggi seguito, anziché porre attenzione sulla prima versione “Troynt”, si considera questa un’ alterazione di voci locali nei fatti sviluppatisi dopo, come “Twrch” in gallese. E così si perde la pista per la corretta comprensione dei fatti avvenuti, e in questo caso del legame Troit-Troia. Nella storia locale di “Culhwch e Olwen” la caccia a Twrch occupa la maggior parte della seconda parte e vi viene descritto in molti dettagli il percorso dell’inseguimento e chi vi partecipa. Re Artù e i suoi uomini hanno il ruoto principale nella caccia. Vediamo che Artù non è solo ma ha un seguito dunque e vediamo come il tutto pare ricalcare proprio la grande caccia al cinghiale Calidonio in Grecia dove partecipavano più eroi.
Cafal, il nome dato al cane, può essere una confusione e traduzione di cavallo, che faceva parte della caccia al cinghiale di Artù, di cui lo scrittore Nennio, o altri lesse da altra fonte, e forse più completamente e correttamente descritta poi nel mosaico di Otranto?
Il Cairn, cumulo di pietre, con la pietra oscillante sopra, può ricordare, il masso oscillante di Ercole della tradizione salentina e messapica, che si diceva si poteva spostare con un dito e tornava allo stesso posto, e posto su rocce di strati geologici forse naturali ma tali da apparire come impilamento di pietre, e dunque un cairn/carn come chiamati in lingua gallese, termine dall’antichissima radice rintracciabile in tutt’Europa e nelle culture indoeuropee.
L’assonanza tra il nome Artù e il termine inglese “earth” terra, secondo alcuni studiosi ha favorito l’ associazione di Artù con legende legate ai megaliti in area Bretone e in Gran Bretagna.
E’ in ogni caso singolare che tanto in Salento quanto in quelle aree nordiche vi sia una diffusa presenza di megaliti, dolmen, menhir, tumuli, grandi rocce naturali dalla particolare forma. E così all’ eroe Ercole e alle ninfe delle fonti antiche, nella tradizione popolare odierna si aggiungono streghe, folletti (“scazzamurueddhi” in vernacolo salentino), orchi (“Nanni orcu”), giganti e streghe (“la Vecchia”), fate ammaliatrici, demoni dai grandi artigli che dagli inferi terrebbero salde le grandi pietre infisse al suolo, tesori (“acchiature”) formati spesso da galline con 7 o 12 pulcini d’oro, riti per trovarli ricevuti in sogno dalla strega, l’uso di una coppia di gemelli, o implicanti il portare un caprone in chiesa facendogli prendere la comunione, e magicamente il tesoro si poteva vedere e prendere. Tutto aleggiante intorno ai megaliti; tesori con pentole piene d’oro spesso nelle grotte e protetti da beffardi folletti.
Ercole in Salento combattè contro i giganti secondo il mito antico. Nel corpus aristotelico, l’insieme degli scritti della scuola di Aristotele giunti a noi con varie aggiunte nei secoli successivi alla vita del filosofo greco, si trova un libro chiamato “Racconti meravigliosi”, di cose miracolose, dove si parla di un enorme masso nel Salento che Eracle pteva spostare con un sol dito, e si parlava di un luogo dove si mostravano le orme di Ercole sempre nel Salento. Quel masso pietra di Ercole, si ritiene e sia quello stesso e si mostra ancora oggi, sulla Serra di Giuggianello, chiamata localmente per tradizione masso del “Fuso della Vecchia” (“Furticiddhu de la Vecchia”), per la sua forma a fuso da filatura o a enorme fungo, che una leggenda locale dice si possa magicamente spostare con un sol dito sempre, recuperando così il tesoro che nasconde. Ma questo solo se si sogna la strega buona, non quella cattiva, che dà questo suggerimento magico del tocco col dito. Una grande continuità mitologica.

Secondo alcuni racconti locali fu il masso che Eracle scagliò contro i giganti e che si posò lì in bilico su un gambo di pietre, in equilibrio perfetto che basta un dito per farlo oscillare e lui comunque torna poi in posizione. Un maso oscillante. Una leggenda che tanto meraviglia perché ricorda la leggenda del cairn e della pietra post sopra di cui narrava Nennio per il Galles, Pietra poi con le orme del cane di Artù.
Sulla pietra cappello di quell’ enorme monumento forse naturale a forma di fungo nel Salento vi son due file di coppelle, probabilmente scavate dall’uomo, che possono ben ricordare proprio i passi di un cane. Era un luogo di grande fascino con molte grandi rocce levigate dalle forme suggestive, un luogo generatore di innumerevoli miti nei secoli fino ai nostri giorni. Rocce sulle quali si ritrovano spesso coppelle, bacinelle e canalette che ne evidenziano la natura di altari. Sul più grande di quei massi affioranti levigati dal tempo, chiamato “Lettu de la Vecchia” dai locali, il grande archeologo salentino Cristian Donato Villani vi ha recentemente osservato e documentato i resti di una antica grande epigrafe messapica incisa lunga almeno 1,3 m, e con i caratteri alti fino a 8 cm. Sembrerebbe riferirsi a Metis mandre di Atena, il cui mito echeggia nel nome del vicino paese di Minervino e in quello pure non distante di Castro di Minerva, come anche a Otranto nell’altura detta Colle della Minerva, Minerva era per i romani la dea corrisponderte alla greca dea Atena.

Fu quel luogo naturale così suggestivo al centro della sacralità salentina e luogo cultuale cerimoniale da epoche protostoriche fino ad epoca messapica e forse anche romana, vari indizi lo fanno ritenere, (“La collina dei fanciulli e delle ninfe”, studio di Oreste Caroppo).
Miti antichi collocavano presso le “ieras petras” (dal greco: le rocce sacre) un ninfeion un santuario delle ninfe dove queste dopo aver gareggiato nella danza con pastorelli messapi ignari che quelle fossero divinità che pertanto giocosamente schernirono, furono da quelle mutati in alberi di ulivo, da cui ancora la notte lì si odono i gemiti di quei fanciulli uscire dai tronchi, si favella. Erano racconti orali arcaici messi per iscritto da autori greci e latini. Oggi le ninfe beffarde son divenute nelle leggende popolari fate che incantano, “fatano”, i fanciulli.
Fate-ninfe, giganti, draghi, che troviamo in racconti Salento come nei cicli bretoni, tipici dei miti greco-romani, o comunque comuni in sostrati culturali comuni in tutt’Europa.
Il ratto o fuga di Elena, che fu causa della Guerra di Troia, ricorda l’amore fedifrago tra il cavalier messer Lancillotto e Ginevra, infedele moglie senza onore sposata ingenuamente da Artù, che portò la rovina nel regno di Artù. Troia e Roma, fortissime le influenze, come quel sentire popolare, per lo sviluppo ed evoluzione della figura di Artù e della sua saga.
E quando si cerca da parte degli storici di individuare Artù in un generale romano romano di nome Artorius, tra mille ipotesi forzate e traballanti, ci si trova con racconti medioevali che descrivono Artù, dal nome tanto romano, italico meglio dire, combattere contro gli stessi romani sempre nel nord Europa. L’influenza dal mondo Mediterraneo su Artù pare schiacciante.
Vediamo come nel caso del megalite Carn Cabal e il Masso di Ercole le similitudini son tante. Si tratta nei due casi di grandi massi che possono essere spostati ma che riassumono poi la loro posizione. entrambi son legati ad eroi Artù e Ercole rispettivamente. Forse anche Artas alle origini di Artù ha come Ercole una sorta di clava. Dei due monumenti litici si parla da parte di Nennio nella sua sezione chiamata nella sezione “de mirabilibus britanniae”, da parte di Aristotele, (o meglio lo pseudo-Aristotele, perché l’opera si ritien successiva, verosimilmente databile tra il I e il II sec. d.C.), nell’ opera “Mirabilium auscultationes” (“Racconti meravigliosi”). Stesso genere letterario e con tutta probabilità Nennio conosceva quel libricino di successo dello pseudo-Aristotele cui si ispirò.
Nennio parla nell’ “Historia Brittonum” della foresta di Celidon dove ambienta una battaglia di Artù, la settima. Celidon, suona come Calidone, città legata nella mitologia antica alla caccia al cinghiale detta pertanto Calidone, città dell’Etolia legata al mito di Diomede legato che il mito narrava si insediò e conquistò la Daunia in Puglia. La stirpe di Diomede regnava su Calidone, suo nonno era Eneo legato ai miti del vino. In ogni caso è più probabile che che dall’ antica famosa battaglia narrata dallo storico romano Tacito, dei Romani contro i Caledoni guidati da Calgago in Scozia nell’ 84 d.C., derivi questa operazione di traslazione storica operata da Nennio nella creazione della figura del re Artù medioevale. Caledonia è infatti anche il nome latino dato dai Romani alla terra posta a nord della provincia romana della Britannia, corrispondente in gran parte all’odierna Scozia.
Si tratta di un topos ricorrente nel “ciclo arturiano” che coinvolge Artù per liberare alcune zone dalle insidie di terribili bestie. Tantissime son poi le simili storie di cavalieri di Artù che sconfiggono mostri, come animali più comuni di ogni tipo, draghi e giganti, che insidiavano le comunità e rendevano pericolosi alcuni luoghi in giro per l’Europa ed il Mediterraneo.
Il tutto quindi si inserisce in un comune topos mitologico pagano prima e cristiano, vedi solo ad esempio San Giorgio che sconfigge il terribile drago.

La caccia al cinghiale è un motivo iconografico ricorrente tanto nel mondo classico quanto continuità nell’arte medioevale.
Citiamo qui un interessante dipinto decorativo scoperto all’ interno di un tumulo sepolcrale in Tracia, nei pressi della città di Aleksandrovo (provincia di Haskovo), nel sud-est della Bulgaria. Il tumulo, localmente chiamato “kurgan” (un sinonimo di quanto nel Salento si sarebbe chiamato “specchia”), risale al IV sec. a. C. Un tunnel portava all’ interno del tumulo, avente una camera ed un anticamera decorate con affreschi di influenza greca.

L’affresco nella camera principale raffigura una per noi interessantissima scena di caccia al cinghiale, dove un grosso cinghiale viene attaccato da un cacciatore vestito e a cavallo su una sella. Guida il cavallo con le redini e lancia delle zagaglie contro il cinghiale, alcune lo hanno già trafitto; (a tal proposito importante è ricordare che proprio una lancia, oltre alla spada, è tra i principali attributi di Artù nella saga bretone medioevale). Dei cani agili e lupiformi lo stanno mordendo ed uno gli è balzato in groppa. E’ insidiato poi anche da un uomo nudo che brandisce una doppia ascia con la quale sta per dar il colpo di grazia al suino dalle grosse zanne!
Si tratta di una iconografia che qui sottolineiamo perché la ritroviamo quasi identica nella scena della caccia al cinghiale raffigurata nel mosaico medioevale di Otranto, nell’abside della Cattedrale, nella quale abbiamo visto un uomo vestito e a cavallo che insegue un cinghiale già ferito da una lancia che lo ha colpito, un cane agile e lupiforme sta già mordendo il suino dalle perigliose zanne su cui si è avventato con coraggio, e dietro l’ uomo a cavallo (anche in questo caso si legge la presenza di una sella sul cavallo; il cavallo è guidato con delle redini, come nel dipinto sopra descritto); segue il cavallo un uomo nudo e a piedi che regge un alto bastone rigonfio a sfera nella parte sommitale, monocromatico di colore interamente marrone; una sorta di scettro “paroccola”, un “calabrops”, che forse poi verrà usato per uccidere il cinghiale assestandoli il colpo di grazia come attraverso la bipenne, simbolo di potere e strumento mortale al contempo, nell’affresco sopra descritto.
E’ Artù l’uomo a cavallo nella caccia al cinghiale del mosaico idruntino? Così parrebbe poiché veste una tunica marrone e calza scarpe marroni come nella scena dell’Artù identificato da legenda e che monta su un caprone. Ma non solo per questo, anche nella scena del caprone vi è accanto ad Artù un uomo nudo, forse un fanciullo o comunque un giovane, che lo guarda, e anche in quella scena troviamo il bastone clavato, che abbiamo chiamato calabrops. Qui nella scena della caccia al cinghiale il bastone-arma-scettro cambia solo di mano e passa nelle mani dell’uomo nudo, ma segue Artù. Non meravigli questo, durante le battaglie o nelle processioni e parate rituali, non sempre i vessilli sacri, come ad esempio il labaro, o i fasci littori erano portati dal personaggio insignito di potere, ma da personale addetto e scelto.
In tal caso poi se la caccia a cavallo era effettuato dal principe, o dal re, che doveva lanciare le picche durante l’ inseguimento del cinghiale, scettri o altre armi per finire il cinghiale ferito erano portate dal suo seguito, così è possibile che orpelli come la corona, fossero non utilizzati durante la battuta di caccia.
Il fatto che il bastone clavato che regge l’uomo nudo nel mosaico di Otranto non sia comunque un’ascia, a singolo o a doppio tagliente (bipenne), e lo stesso discorso vale per tutti i tanti bastoni clavati, rigonfi nella parte terminale di maggiore offesa, che abbiamo osservato nel mosaico idruntino, e stesso discorso potremmo estendere allo scettro di Artù, è attestato dal fatto che nel medesimo mosaico delle normali asce a singolo tagliente, sono normalmente rappresentate, ad esempio nella scena di Noè e dei suoi figli che curano la vigna o costruiscono l’ Arca, tagliando la legna e sagomandola, per affrontare il diluvio universale. Un’ ascia anche troviamo nel tondo del mese di dicembre per il taglio della legna per l’inverno, che è nella navata. Un’altra è infissa con un colpo secco nel tronco dell’albero centrale della navata centrale all’altezza della scena dei lavori per la realizzazione dell’Arca di Noè. In queste asce poi ben riconoscibili, con un colore grigio, è distinta la parte in metallo dal bastone ligneo di coloro marrone. Per cui in legno son probabilmente tutti i bastoni clavati che osserviamo nel mosaico, e forse anche lo scettro di Artù del medesimo colore marrone. Compare solo un’ascia di tipo tendente alla bipenne nella scena della sagomatura del legno per costruire l’ Arca, e che è tutta di colore marrone.
In entrambe le opere: caccia al cinghiale con cavallo, lancia, seguito di persone con clava-scettro, e cani.
Questo confronto ci richiama il fatto che per la rappresentazione della scena di caccia vi erano modelli già ellenistici, o più antichi da cui trarre ispirazione per la composizione e struttura della medesima scena di Otranto, ma in tal caso di contesto arturiano.
Pensiamo anche a tanti mosaici romani con scene di caccia al cinghiale, ad esempio nei mosaici tardoantichi policromi del IV secolo d.C. di Villa del Casale (Piazza Armerina) in Sicilia:

o il mosaico della caccia anche al cinghiale degli Horti Liciniani in quella che fu una residenza imperiale del tardo IV secolo d.C. a Roma, o i mosaici della villa romana di S. Lucia (Pollenza – MC), mosaico policromo del I°secolo a.C.:

o ancora a Chiusi il mosaico romano di Meleagro che uccide il cinghiale calidonio:

motivo che ritroviamo anche nella scultura romana, ad esempio nei Musei Capitolini a Roma su un sarcofago romano:
Non solo, ma nello stesso Salento come possibile motivo ispiratore per i mosaicisti, a Lecce (antica Lupiae) a pochi chilometri da Otranto, troviamo lo stesso motivo nella arte romana.


Dall’ uso di questi modelli, il parallelismo ci dice che il calabrapos paroccola che ha in mano il servo, in tal caso di Otranto, (il cavaliere Perceval o il gigante(?) servo uscito dal felide ucciso, o chissà), ha la valenza della Labrys, e può esser usato sia come scettro, si all’atto pratico della caccia per finire un animale ferito, e infatti è noto che le paroccole avessero anche questo potere.
Nei mosaici romani vediamo poi come il cinghiale venisse finito con un grosso masso o con un colpo di scure, e anche la tecnica venatoria per chi andava a piedi con lancia, nascondersi per proteggersi dietro un albero e intanto trafiggere il cinghiale con la lancia. Vediamo anche personaggi feriti dal cinghiale.
Motivi che ritroviamo nell’arte medioevale quando si rappresenta la caccia al cinghiale, ad esempio nella seguente miniatura:

APPENDICI con commenti discorsivi dell’autore con sintesi e ulteriori dati dalle corrispondenze sviluppate a seguito della divulgazione di questo studio
Per le fonti letterarie più antiche che citano un comandante di nome Artù in Britannia dobbiamo risalire a Nennius un monaco gallese del IX secolo d.C. al quale è stata attribuita la Historia Brittonum dove compare il primo riferimento ad Artù. Il materiale di Nennio fu poi ripreso da Goffredo di Monmouth. La mia idea non è che i monaci del mosaico di Otranto, o attivi in Salento al tempo della sua stesura, il XII secolo. d.C. abbiano influenzato gli inglesi nella creazione della figura di Artù, ma che, tramite ambienti monastici necessariamente dato il tipo di circolazione del sapere del tempo, in Inghilterra circolassero ancora da epoca romana o neogiunte nel medioevo opere antiche su Artas (come lo scritto oggi perduto di Polemone su Artas il Grande re dei Messapi, e poi chissà anche opere perdute di Ennio o di altri autori antichi) che fornirono un sostrato di ispirazione, come avvenuto per tanto materiale classico finito in quelle storie spesso pseudo-storiografiche sul passato della Britannia redatte da Goffredo e Nennio.
Durante i miei studi sulla materia arturiana trovai che Nennio citava pochissimo Artù, ma lo citava nella Historia Brittonum. Nominò invece assai un personaggio di nome Ambrosio Aureliano.
“La Historia Brittonum (prima fonte che cita Artù in Britannia) scritta dal monaco Nennio descrive il presunto insediamento nella Gran Bretagna di espatriati troiani e afferma che la Gran Bretagna prese il nome da Bruto, discendente di Enea. Immaginate in questa pseuda-storia quanto si pesca dalla storia Roma, da Virgilio e forse anche da Ennio. Bruto è nel mito romano l’eroico fondatore della repubblica romana. L’opera era fonte più importante utilizzata da Geoffrey di Monmouth nella creazione della sua Historia Regum Britanniae e, grazie all’enorme popolarità di quest’ultima opera, questa versione della storia precedente della Gran Bretagna, inclusa la tradizione di origine troiana, sarebbe stata incorporata in cronache successive per la lunga storia del paese” (passo tratto dal link).
Negli articoli sopra linkati si può approfondire sulle varie critiche che vi sono state sulla datazione del testo attribuito a Nennio, sulla stessa attribuzione a lui.
Forte è il dubbio per me che Nennio sia uno pseudonimo a emulare Ennio poeta messapico celebratore della origini di Roma, che Orazio definiva padre della letteratura latina e in parte anche lo fu della lingua latina letteraria che egli raffinò grazie alla sua cultura latina. O al limite se Nennio era davvero il nome di battesimo di quel monaco gallese erudito di classici greco-latini, forte fu su di lui una psicologica identificazione con Ennio che lo condizionò e guidò nella sua opera letteraria pseudo-storiografica.
In allegato alla Historia c’è una sezione chiamata “De mirabilibus Britanniae” (o semplicemente “Mirabilia” in breve). Fornisce un elenco di 13 meraviglie topografiche, o meraviglie della Gran Bretagna, Irlanda ed altre isole dell’area. Due delle meraviglie sono la tradizione arturiana (capitolo 73 della Historia ). Riportiamo questa:
“C’è un’altra meraviglia nella regione che si chiama Buelt. C’è un mucchio di pietre lì e una pietra posta sopra il mucchio con l’impronta della zampa di un cane dentro. Quando Cabal (Cavall in gallese), che era il cane di Arthur il soldato, stava dando la caccia al cinghiale Troyt (Porcum Troyt), ha impresso la sua stampa nella pietra, e successivamente Arthur ha assemblato un tumulo di pietra sotto la pietra con l’impronta del suo cane, e si chiama Carn Cabal. E gli uomini vengono e rimuovono la pietra nelle loro mani per la durata di un giorno e di una notte; e il giorno dopo si trova in cima al suo tumulo” (dalla “Historia Brittonum“).


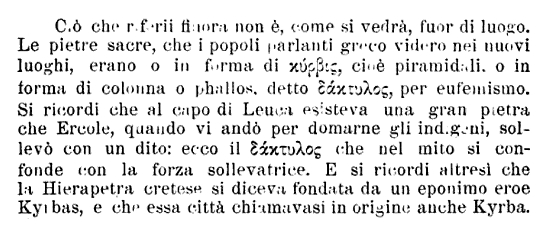



E LA JAPIGIA?
Lì la scoperta di re Artas mi incuriosì moltissimo proprio perché in Terra d’Otranto avevamo Artù enigmaticamente rappresentato a Otranto, e a partire da quell’input otrantino avevo approfondito scoprendo che sulla figura dell’Artù di Britannia praticamente non c’era nessuna storicità in Gran Bretagna.
Per approfondire su Artas comprai appena venne pubblicato il romanzo storico “Arthas Il Grande – Eroe di Messapia” del professor Sammarco Fernando di Manduria edito nel 2010. Lì trovai un’ottima bibliografia che acquistai quasi interamente trovando anche le opere del Ribezzo e del Santoro in tre volumi sulla epigrafia messapica. E anche molto interessante un altro testo che consigliato per approfondire sulle origini dei dialetti pugliesi. Di Francesco Ribezzo “Corpus inscriptionum messapicarum” testo scritto in latino.
a cura di Lorenzo Braccesi “La pirateria nell’Adriatico antico” edito nel 2004.

qui il tema Graal a Otranto.
(…Già ultimate da tempo saranno caricate nei prossimi giorni le ulteriori parti del lavoro di ricerca indiziaria qui ad ora parzialmente esposto…)
————————–
PER APPROFONDIRE:
Nella vera terra del Graal e del vero Re Artù: il Salento!
Individuata a Otranto la prima rappresentazione ante-litteram del sacro calice GRAAL?
e
Nel re salentino Artos il Grande la vera origine storica del fiabesco Re Artù
per ulteriori approfondimenti sul mosaico otrantino
Oreste Caroppo